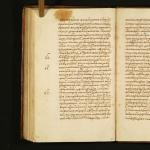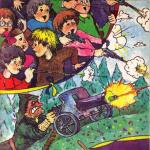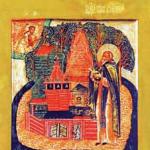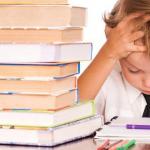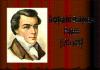A. Kurkin
Kiev
Declino della cavalleria europea
"Vincere e resistere
la sconfitta va fatta con onore"
Pierre Bayard
La crisi della cavalleria si manifestò chiaramente durante la Guerra dei Cent'anni. La cavalleria pesante francese si rivelò assolutamente impotente contro il sistema di fanteria inglese. La terribile sconfitta di Crecy (1346) e il fallito tentativo dei francesi di vendicarsi a Poitiers (1356) fecero letteralmente saltare in aria la società feudale. Il fatto della relativa inutilità della cavalleria sul campo di battaglia appariva chiaramente davanti allo sguardo scioccato dell'uomo europeo della strada.
Tuttavia, difficilmente sarebbe corretto considerare gli arcieri inglesi o i picchieri svizzeri come becchini della classe militare.
Il processo di decomposizione della cavalleria come istituzione militare-sociale iniziò molto prima degli eventi chiave dei Cent'anni e delle successive guerre europee. Crécy, Poitiers e Agincourt non sono che esempi di questa scomposizione.
I rappresentanti più importanti della cavalleria europea - principalmente Edoardo III Plantageneto, Giovanni II Valois e Filippo il Buono - fecero sforzi davvero titanici per fermare in qualche modo questo processo di distruzione. Gli apologeti della cavalleria hanno cercato di far rivivere i tempi leggendari degli eroi della Tavola Rotonda di Artù, proponendo, come contrappeso all'idea di consolidamento nazionale, l'idea di un'unione cavalleresca paneuropea sovranazionale. Il re inglese Edoardo III, uno dei principali istigatori della Guerra dei Cent'anni, con tutto il suo atteggiamento “non notturno” nei confronti dei metodi di combattimento (ricordate le tattiche inglesi a Sluys o Crecy), coltivò intensamente le norme di cortesia: inviò il re di Francia una sfida a duello, e durante i combattimenti emanò che i cavalieri francesi ricevessero speciali lettere di salvacondotto in modo che potessero venire al torneo in Inghilterra, ecc.
Nel settembre del 1351, dopo clamorose vittorie nel continente, Edoardo III creò il primo Ordine cavalleresco secolare della Giarrettiera. Tutti i 24 cavalieri dell'ordine si distinsero nella battaglia di Crecy, durante la quale, secondo la leggenda, il re inglese raccolse da terra una giarrettiera staccatasi dai suoi vestiti per dare il segnale dell'attacco.
Esiste un'altra versione di un distintivo dell'ordine così strano. È noto che Edoardo III non era indifferente alla contessa di Salisbury. Quando la bella contessa perse la sua giarrettiera blu tempestata di gioielli durante un ballo al Castello di Windsor, il re presumibilmente la raccolse dal pavimento e disse ad alta voce: "Vergogna a chiunque ne pensi male". Successivamente, queste parole divennero il motto del primo ordine cavalleresco secolare.
I francesi, eterni oppositori degli inglesi, che consideravano la Francia la culla della cavalleria, presero subito l'iniziativa degli isolani. Nello stesso 1351, Giovanni II di Valois, a dispetto di Edoardo III, creò l'ordine secolare francese dei Cavalieri di Nostra Signora della Nobile Casa (Chevaliers Nostre Dame de la Noble Maison). Il segno dell'ordine era una stella nera a otto punte ricamata su una veste scarlatta, a seguito della quale questa unione cavalleresca ricevette il secondo nome non ufficiale "Ordine della Stella".
I detentori dell'ordine che più si distinsero in battaglia tenevano le loro assemblee nelle cosiddette. Casa nobiliare a Saint-Ouen (vicino a Saint-Denis). C'era una cerimonia speciale per i pasti dell'ordine dei cavalieri: durante varie celebrazioni alla Tavola d'Onore (Table d'oneur), tre posti venivano assegnati ai principi, ai cavalieri con i propri stendardi e ai cavalieri con scudo singolo - postulanti.
Ogni detentore dell'Ordine della Stella fece voto durante la battaglia di non spostarsi più di quattro passi (arpana) dal campo di battaglia.
Va notato che i Cavalieri della Stella sono rimasti fedeli al loro giuramento. Nella battaglia di Poitiers, quasi 90 membri dell'ordine e il loro seguito morirono perché si rifiutarono di fuggire. E lo stesso re di Francia Giovanni II, capo dell'ordine, trascurando gli interessi statali, rimase sul campo di battaglia fino alla fine e fu catturato. Con la morte di Giovanni II durante la prigionia inglese (1364), l'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora della Nobile Casa si disintegrò.
Uno degli ordini cavallereschi più famosi che si evolse da un'associazione corporativa diretta a un premio in quanto tale fu l'Ordine del Toson d'Oro, fondato a Bruges il 10 febbraio 1430 (secondo altre fonti - 10 gennaio 1429) dal Duca di Borgogna Filippo il Buono *1.
L'ordine fu fondato in onore del matrimonio tra Filippo il Buono e Isabella del Portogallo e originariamente era concepito come ordine personale del duca di Borgogna.
Formalmente l'Ordine del Toson d'Oro (Toison d'or) era dedicato alla Vergine Maria e a Sant'Andrea e perseguiva il buon fine di tutelare la chiesa e la fede. Il numero dei membri dell'ordine era inizialmente limitato a ventiquattro i cavalieri più nobili.
I primi detentori dell'ordine furono lo stesso Filippo il Buono e Guillaume di Vienne.
Insieme ai cavalieri, l'ordine comprendeva anche i dipendenti: cancelliere, tesoriere, segretario, maestro d'armi con uno staff di araldi e seguito. Il primo cancelliere dell'ordine fu il vescovo di Chalons, Jean Germain, e il primo maestro d'armi fu Jean Lefebvre.
I nomi degli araldi ripetevano tradizionalmente i nomi dei signori: Charolais, Zealand, Berry, Sicilia, Austria, ecc.
Il primo degli scudieri portava il nome Flint (Fusil) in connessione con l'immagine della selce - l'emblema di Filippo il Buono - nella catena dell'ordine. Altri scudieri avevano nomi altrettanto sonori e romantici: Perseverance, Humble Regueste, Doulce Pensee, Leal Poursuite, ecc.
Lo stesso re d'armi portava il nome di "vello d'oro".
Misha Tayevan ha sottolineato il carattere spirituale e cavalleresco dell'ordine in forma poetica:
Per non integrarsi con gli altri,
Non per gioco o divertimento,
Ma per lodare il Signore,
E il tè per i fedeli: onore e gloria.
Il distintivo dell'ordine era un'immagine dorata di una pelle di pecora, rubata alla Colchide da Giasone, che era attaccata a una catena. Ventotto anelli della catena portavano immagini di selci con lingue di fiamma e selce con scene della battaglia di Giasone con il drago.
La natura spirituale dell'ordine era sottolineata da un rituale rigoroso: frequenza obbligatoria in chiesa e messa, collocazione dei cavalieri durante le assemblee sulle sedie dei canonici, commemorazione dei signori dell'ordine defunti secondo il rito della chiesa, ecc.
Tuttavia, ben presto i malvagi del duca di Borgogna notarono una contraddizione tra il simbolismo e il concetto etico dell'ordine:
Perché Dio e le persone sono spregevoli
Venendo, calpestando la legge,
Attraverso l'inganno e il tradimento, -
Non annoverato tra i coraggiosi
Colchide vello Giasone,
Rubato solo per tradimento.
Non riesci ancora a nascondere il furto.
(Alain Chartier)
Una via d'uscita dalla difficile situazione fu trovata dal cancelliere dell'ordine, Jean Germain, che attirò l'attenzione di Filippo il Buono su una scena della Sacra Scrittura: Gedeone stese la lana su cui cadeva la rugiada del cielo. Così, il vello di Giasone (Vellus yasonis) si è evoluto in un simbolo del mistero della concezione della Vergine Maria, e l'ordine stesso ha ricevuto il suo secondo nome "Segno di Gedeone" (Gedeonis signa).
Guillaume Philastre, il nuovo cancelliere dell'ordine, andò oltre il suo predecessore e trovò nella Scrittura altre quattro rune, oltre a quelle menzionate, alle quali sono associati Giacobbe, Giobbe, il re Davide e il re di Moab. La pecora maculata di Giacobbe divenne un simbolo di giustizia (fustitia).
Philaster non si stancava mai di ripetere a Carlo il Temerario: "Tuo padre non ha stabilito quest'ordine invano, come dicono alcuni". Lo stesso Carlo, cercando di dare vita alle idee di consolidamento della cavalleria europea, divorziate dalla realtà, scambiò le insegne degli Ordini del Toson d'Oro e della Giarrettiera con il re inglese Edoardo IV di York. L’unificazione, tuttavia, non è avvenuta. Con la morte di Carlo il Temerario, il capo dell'ordine divenne l'arciduca d'Austria e più tardi l'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano d'Asburgo, genero di Borgogna. L'Ordine del Toson d'Oro sopravvisse con successo alla morte del cavalierato, diventando infine il fondatore del sistema europeo di onorificenze.
La genesi delle relazioni sociali nell'Europa occidentale e centrale nel XV secolo, la nascita di un nuovo concetto politico di servizio allo Stato e, infine, la crescita dell'importanza socioeconomica del cosiddetto. Il "terzo stato", volenti o nolenti, costrinse la cavalleria ad adattarsi a un sistema di valori etici in cambiamento. Philippe de Maizières fece un tentativo rischioso di consolidare tutte e tre le classi ("quelli che pregano", "quelli che combattono" e "quelli che arano") unendo i loro rappresentanti nelle fila dell'Ordine della Passione del Signore (Ordre de la passion) da lui fondata. Secondo il progetto di Mézières, il vertice dell'ordine (gran maestro e cavalieri) doveva essere composto dall'aristocrazia, il patriarca e i vescovi suffraganei potevano essere eletti tra le file del clero, i mercanti fornivano i fratelli, i contadini e i borghesi - servi. Ai classici voti degli ordini spirituali cavallereschi (povertà e obbedienza), Mézières aggiunse un voto di castità coniugale e un voto di tensione alla massima perfezione personale (summa Perfectio).
Creando l'Ordine della Passione del Signore principalmente con l'obiettivo di contrastare l'espansione turca, Philippe de Maizières, senza nemmeno rendersene conto, si avvicinò in modo puramente intuitivo a realizzare l'idea del "bene comune", un tempo così importante per i fondamenti del diritto romano. In un certo senso, Mézières anticipò l’unico premio di tutte le classi del suo genere, che sarebbe poi diventato l’“Ordine della Legione d’Onore” fondato da Napoleone I.
Tuttavia, non tutti i rappresentanti della cavalleria europea si rendevano conto della necessità di collaborare con il “terzo stato”. Inoltre, molti feudatari cercarono le ragioni del declino della casta militare nell'oblio delle “buone usanze cavalleresche” e tentarono con tutte le loro forze di farle rivivere. Il duca di Borgogna, Carlo il Temerario, riuscì più di tutti in questo percorso. Appassionato ammiratore delle tradizioni cavalleresche, Carlo amava leggere fin dall'infanzia le vite di Alessandro Magno e Cesare, Carlo Magno e San Luigi. Sotto la penna dei creatori di romanzi eroici, sia il macedone che San Michele si trasformarono in cavalieri “senza paura né rimprovero”, servendo da esempio all'ambizioso borgognone. Grazie agli sforzi di Carlo, la Borgogna si trasformò in una sorta di oasi cavalleresca con magnifici armamentari e una rinnovata cortesia. Le feste cavalleresche raggiunsero l'apogeo del loro sviluppo: i tornei, che furono organizzati in modo più magnifico, meno evidente divenne l'influenza della cavalleria cavalleresca sull'esito delle battaglie reali. La nobiltà feudale, avvertendo il progressivo aumento della proporzione dei rappresentanti della “nuova nobiltà”, sempre più raggruppati attorno ai troni reali, cercò con tutti i mezzi possibili di dichiarare la propria individualità. Tutto ciò si rifletteva nell'architettura, nell'abbigliamento e nel comportamento. Il lettore moderno non può fare a meno di rimanere colpito, ad esempio, dai numerosi voti dei rappresentanti dell'élite politico-militare dell'epoca. Così, al banchetto che Edoardo III diede prima di essere inviato in Francia, il conte Solbercy, secondo Froissart, giurò alla sua signora di non aprire il suo occhio destro finché non avesse ottenuto una vittoria in battaglia con i francesi *2.
Ancora più assurdo e, in una certa misura, disumano fu il giuramento della moglie di Edoardo III, Filippa di Genegau, prestato da lei durante la stessa memorabile festa:
La mia carne ha riconosciuto che il bambino dentro di me sta crescendo.
Oscilla un po', non aspettandosi guai.
Ma lo giuro sul Creatore e faccio un voto...
Il frutto del mio grembo non nascerà,
Finché lei stessa non entrò in quelle terre straniere,
Non vedrò i frutti delle vittorie promesse.
E se partorisco un bambino, allora questo stiletto
La vita finirà sia per lui che per me senza paura,
Possa io distruggere la mia anima e lasciare che il frutto segua!
Il comandante francese Bertrand du Guesclin, che apprese metodi di combattimento "non cavallereschi" dagli inglesi, tuttavia non riuscì a liberarsi di alcune delle assurdità del comportamento cortese. Ad esempio, una volta prima di un duello con un cavaliere inglese, giurò di non sguainare la spada finché non avesse mangiato tre ciotole di stufato di vino nel nome della Santissima Trinità.
Ed ecco esempi di voti cavallereschi pronunciati durante una festa a Lille (1454) alla presenza di Filippo il Buono. “Giuro di non andare a letto il sabato e di non restare nella stessa città per più di 15 giorni finché non avrò ucciso un saraceno”, “Giuro il venerdì di non dare da mangiare al mio cavallo finché non toccherò lo stendardo del nemico”, ecc.
Le norme del comportamento cortese divennero sempre più bizzarre e separate dalla realtà. In particolare, nel percorso di servizio alla Signora del Cuore, il cavaliere era obbligato a percorrere a turno una serie di fasi.
In primo luogo, il cavaliere identificò la “sua” Signora - di regola, una donna sposata - e, senza rivelarle i suoi sentimenti, iniziò a compiere varie imprese, che dedicò alla sua prescelta. In questa fase il cavaliere veniva chiamato "Lurking".
Quando l’oggetto della passione prestava attenzione al suo “ammiratore”, quest’ultimo diventava una “Preghiera”.
Se la Signora ascoltava le richieste di clemenza e attenzione del suo gentiluomo, questi diventava un “Ammiratore” ufficialmente riconosciuto.
Alla fine, quando la Signora mostrò reciprocità al cavaliere - regalò souvenir, legò la sua sciarpa o la manica strappata del suo vestito alla lancia del suo torneo - il fortunato raggiunse il grado più alto di cortigiano e si trasformò in “Amato”.
Tuttavia, il massimo che un cavaliere veramente cortese poteva ottenere dai piaceri amorosi (e su cosa poteva contare!) era un breve bacio, poiché il significato del servizio cavalleresco alla Dama era sofferenza, non possesso. Esempi del tragico amore di Tristano e Lancillotto per le donne sposate non hanno fatto altro che rafforzare il vero “Amato” nei loro pensieri sull'irraggiungibilità del frutto della loro passione.
La vita, tuttavia, ha preso il suo pedaggio. Quindi, in Francia nel XV secolo. Esisteva un ordine erotico di Ammiratori e Ammiratori (Galois et Galoises), i cui membri facevano voto di indossare pellicce e manicotti in estate, e un abito leggero in inverno.
Se un membro dell'ordine si recava da un cavaliere, il primo era obbligato a mettere a sua disposizione la sua casa e la moglie, e lui, a sua volta, si recava dall'“Ammiratore” dell'ospite.
Elementi di fantasmagoria invasero sempre più la vita dei cavalieri e gli scenari delle feste cavalleresche iniziarono a basarsi su scene fiabesche con nani che incatenavano giganti, potenti streghe dai castelli sotterranei e principesse da isole sconosciute. Un tipico esempio di un simile torneo, organizzato a Bruges (1468) in onore del matrimonio di Carlo il Temerario con Margherita di York, fu lasciato nelle sue memorie dal cerimoniere della corte borgognona, Olivier de la Marche. Una descrizione più dettagliata della cerimonia che accompagna il torneo è contenuta nel cosiddetto. "Libro dei tornei" di Renato I d'Angiò, re di Sicilia (1460)*3.
Parlando del torneo tra i duchi di Bretagna e i Borbone, l'autore ha cercato di mostrare non tanto il combattimento in sé, ma gli elementi del corteggiamento cavalleresco che lo hanno preceduto, per creare un insieme ideale di regole o regolamenti dell'etichetta del torneo.
L'iniziatore del torneo descritto, Francesco II, duca di Bretone, che ne era il “fomentatore” (avventuriero), inviò una sfida formale a Giovanni II, duca di Borbone, che risultò così essere il destinatario (mantenador).
L'ambasciata del duca di Bretone era guidata dal cosiddetto. "re d'armi" (primo scudiero), accompagnato da quattro araldi - araldi.
All'ingresso della città in cui si sarebbe svolto il torneo, il corteo si schierava secondo una sequenza rigorosamente definita: prima venivano lo “sfidante” e il “ricevitore”, seguiti dal “re d'armi”, dagli araldi con gli assistenti e dal seguito ducale. Il “Re d'Armi” era vestito con una veste araldica, stilizzata come una pelliccia di ermellino, uno dei simboli della Bretagna, e teneva tra le mani una spada da torneo e un cartiglio con gli stemmi dei partecipanti al torneo e l'elenco dei loro collocamento in appartamenti. Uno degli araldi portava il manifesto del torneo aperto e gridava ad alta voce il contenuto della sfida del suo signore.
Il secondo giorno della festa cavalleresca è stato dedicato a portare negli appartamenti gli stendardi dei partecipanti: prima lo stendardo del Duca di Bretone, poi quello del Duca di Borbone.
Poi, in un luogo appositamente recintato - in alcuni casi potrebbe diventare la cattedrale della città - venivano esposte le insegne dei cavalieri partecipanti al torneo. Le dame più nobili, accompagnate da araldi, esaminavano questi segni - solitamente elmi da torneo con stemmi araldici - per contrassegnare l'emblema del cavaliere che le aveva calunniate. Ciascuno di questi precedenti veniva esaminato da una commissione araldica e il cavaliere, se la sua colpevolezza veniva dimostrata, veniva punito: veniva espulso dal torneo.
Il terzo giorno, ai partecipanti furono lette le regole del torneo e i cavalieri giurarono di rispettarle. Le donne hanno scelto l'arbitro principale del torneo: il "Cavaliere d'Onore", che potrebbe fermare questo o quel combattimento o rimuovere dal campo un cavaliere che ha utilizzato una tecnica proibita.
Il quinto giorno è stato dedicato alla competizione del torneo vero e proprio.
Dopo essersi sottoposti all'apposita procedura religiosa, i duchi di Bretone e di Borbone, alla testa delle loro truppe, presero posto ai bordi delle liste e si prepararono alla battaglia.
Il campo del torneo era un'area rettangolare circondata da una doppia recinzione. Dietro il recinto, al centro, c'era una tribuna dei giudici, a destra e a sinistra c'erano i palchi delle nobili dame e dei signori.
Su entrambi i lati delle liste sono state montate le tende dei partecipanti e sono stati esposti i loro striscioni. Le armi e l'equipaggiamento dei cavalieri consistevano in una spada da torneo, una mazza di legno e una mezza armatura con un elmo a traliccio. L'elmo portava lo stemma del proprietario - kleynod, che per il duca di Bretagna era un'immagine tridimensionale di un leopardo posto tra due corna dipinte nel colore di un manto di ermellino, e per il duca di Borbone - uno stemma dorato immagine di un giglio. I simboli degli stemmi erano duplicati sui tabar dei cavalieri e sulle coperte dei loro cavalli. Anche tutti gli altri partecipanti al torneo erano vestiti con stemmi e avevano armi simili.
L'autore del libro dei tornei dedica relativamente poco spazio alla descrizione della battaglia stessa e la battaglia stessa, a quanto pare, è stata molto fugace.
Una delle illustrazioni del libro, apparentemente realizzata dall'artista di corte di Renato d'Angiò, Bartolomeo d'Eyck, mostra la lotta dei cavalieri "dentro le barriere". Al centro della battaglia c'è il Cavaliere d'Onore con uno stendardo bianco tra le mani, con le quali dava segnali di inizio e fine della battaglia o di cancellazione dalle liste dei cavalieri che hanno violato le regole. La testa del Cavaliere d'Onore è nuda, e il suo elmo è esposto su una delle tribune .
Al termine della battaglia, il giudice supremo e gli araldi eleggevano la “Dama del Torneo”, la quale, insieme alle sue due assistenti (damoiselle), consegnava premi e doni ai vincitori.
La sproporzione fornita dalla fonte nella descrizione della cerimonia del torneo e della competizione stessa riflette ciò che è tipico del XV secolo. un quadro della degenerazione della cavalleria europea come forza combattente.
I tornei si trasformano sempre più in spettacoli in costume e ricordano sempre meno l'apoteosi del potere primordiale che regnava sulle liste duecento anni prima:
Il danese guardò lo straniero con uno sguardo arrabbiato,
I cavalieri spronano i fianchi dei cavalli,
Mirando allo scudo del nemico, le loro lance si piegarono,
E Ludegast si allarmò, nonostante fosse potente e focoso.
I cavalli si scontrarono e si impennarono,
Poi si incrociarono come il vento.
I soldati li fecero voltare e si riunirono di nuovo,
Per tentare la fortuna in una feroce battaglia con le spade.
Sigfrido colpì il nemico e la terra tremò.
Scintille volarono in una colonna sopra l'elmo del re,
È come se qualcuno avesse acceso un grande fuoco lì vicino,
I combattenti valevano a vicenda: nessuno poteva avere la meglio.*4
In tutta onestà, va notato che i tornei non sono mai diventati completamente sicuri per i loro partecipanti, e le affermazioni di un certo numero di ricercatori dell'era cavalleresca (più di una volta, tra l'altro, criticati di recente) secondo cui un guerriero, messo fuori combattimento sella, non potrebbe alzarsi senza aiuto esterno, avere giustificazioni reali. Tali tipi di combattimenti di tornei come geshtech "vestiti di armatura" o rennen, in cui i partecipanti al galoppo cercavano di buttarsi a vicenda dalle loro selle con le lance, erano molto pericolosi. In effetti, un cavaliere che ha perso uno scontro con la lancia, ha ricevuto un terribile colpo al petto o alla testa ed è caduto a terra con tutte le sue forze, difficilmente sarebbe riuscito a rimettersi in piedi senza un aiuto esterno.
Possiamo anche citare un esempio da manuale di una tragica combinazione di circostanze e negligenza criminale degli scudieri: la morte del re francese Enrico II in un torneo nel 1559. La causa della morte del portatore della corona fu una visiera non fissata, sotto la quale penetrarono frammenti della lancia del conte di Montgomery.
Nella terminologia relativa alle competizioni cavalleresche esiste una tradizionale confusione associata sia alle diverse interpretazioni delle fonti sia all'impossibilità di un completo adattamento filologico.
Inoltre, è necessario tenere conto delle varie innovazioni in alcuni esercizi di torneo che i feudatari svolgevano, guidati sia dai propri gusti che dalle caratteristiche mentali nazionali.
Le battaglie a cavallo e a piedi, che potrebbero essere di coppia o di gruppo, sono più o meno distinguibili. Il combattimento a coppie con lance (geschtech tedesco, juxta francese, dgostra italiano) aveva varietà come geschtech di "selle alte", geschtech "tedesco generale" e geschtech di "corazzato". I combattimenti di cavalli in coppia includono anche il rennen ("corsa di cavalli" tedesca), in cui il cosiddetto Rennen "preciso". Il combattimento di gruppo equestre, il torneo stesso (Turneu francese), differiva anche nelle armi dei partecipanti e nei metodi di combattimento. Un combattente poteva dimostrare le sue capacità personali durante l'esecuzione di vari esercizi da torneo: quintata, anelli, ecc., distinguibili con il termine italiano generale bagordo.
Tuttavia, la realtà della Guerra dei Cent'anni negava tutta l'abilità dimostrata dalla cavalleria nei tornei.
E nella fase finale delle guerre di Carlo il Temerario o durante la Guerra delle Rose Scarlatte e Bianche, gli avversari cercavano già di non ricordare le cortesie cavalleresche. 
Le sfide al combattimento, che si scambiavano re, imperatori o duchi in guerra, iniziarono sempre più a essere viste come una formalità vuota e non vincolante.
Tuttavia, come lampi di tempi eroici caduti nell'oblio, scintille di nobiltà cavalleresca divamparono improvvisamente sui campi di battaglia del Basso Medio Evo. Nel 1351, in Bretagna, vicino alla città di Ploermel, si svolse un torneo di battaglia tra i francesi sul da un lato, e gli inglesi e i tedeschi dall'altro: la "Battaglia dei Trenta". Gli avversari hanno selezionato 30 partecipanti ciascuno, guidati dal maresciallo di Francia Jean de Beaumanoir e dal capitano inglese John Bemborough, che hanno combattuto per tutti davanti alla linea. Durante questo torneo-battaglia, cavalieri e scudieri potevano uccidere il nemico o farlo prigioniero. Inoltre i prigionieri, senza alcuna sicurezza, aspettavano la fine della battaglia e potevano entrare di nuovo in battaglia solo se il loro vincitore fosse morto, perché la sua morte li liberava dal giuramento.
È interessante notare che entrambe le truppe hanno assistito alla battaglia e non hanno nemmeno pensato di intervenire dalla propria parte.
Durante la battaglia di Grunwald (1410), il cavaliere tedesco Diepold Käckteritz von Dieber cavalcò davanti allo stendardo polacco e sfidò a duello il re Jagiello (Wladislaus) e, ancora una volta, nessuno dei cavalieri polacchi osò impedire il duello, ad eccezione del notaio reale Zbigniew Olesinski, che non era vincolato alle norme dell'etica cavalleresca.
Nello stesso 1410, in una battaglia vicino alla città di Koronova, polacchi e tedeschi, di comune accordo, interruppero una volta la battaglia per riposarsi.
Famosi cavalieri e comandanti come du Guesclin, Hawkwood, Tremouille, La Hire e Sentrail glorificarono i loro nomi con clamorose vittorie in duelli all'ultimo sangue: "corti di Dio con le armi".
Nel 1501, vicino alla città di Barletta, il famoso Pierre Bayard sconfisse in duello il famoso cavaliere spagnolo Soto Major.
Per una malvagia ironia della sorte, i più famosi cavalieri del tardo medioevo - Treimul, Carlo il Temerario e Bayard - caddero per mano dei rappresentanti dello stesso "terzo stato" che tanto disprezzavano: il primo fu ucciso da una palla di cannone. , il secondo morì sotto le picche della milizia, il terzo ricevette una ferita mortale da un proiettile di moschetto.
Gli ideali morali della cavalleria, difesi così zelantemente da rappresentanti di spicco della letteratura cavalleresca come Jean Froissart, Olivier de La Marche, Jean Molineux e Jean d'Authon, furono soppiantati dalle norme pragmatiche del "popolo nuovo" - Philippe de Commines, Jean de Busem e Niccolò Machiavelli, che nelle loro opere svilupparono il concetto di “bene comune” fino alle idee del patriottismo.
Il valore combattivo della cavalleria, il cui mito fu predicato da Carlo il Temerario, Gaston de Foix e Pierre Bayard, fu sconfitto senza pietà dai comandanti della nuova era Massimiliano d'Asburgo, Jacques de Romont e Gonzalo de Cordova, che facevano affidamento su senza volto e masse di fanteria disciplinate.
Lo sviluppo della metallurgia e la produzione "in linea" di armi nei secoli XIV-XV. ha portato alla relativa economicità dell'equipaggiamento da combattimento. Elmi, cotta di maglia e spade divennero armi democratiche. Quest'ultimo fatto stimolò un aumento quantitativo dei distaccamenti di mercenari ben armati - "cittadini comuni", che nelle loro qualità di combattimento inizialmente eguagliarono la milizia cavalleresca, e poi la superarono. Così Philippe de Commines dipinge un quadro molto sgradevole della professionalità militare della cavalleria feudale borgognona nella battaglia di Montlhéry (1465): “Su circa 1200 di questi cavalieri, non più di 50, credo, sapevano impugnare una lancia erano pronti e al massimo 400 in corazza, e i servi erano tutti disarmati, poiché non conoscevano la guerra da molti anni."*5
Va sottolineato che l'evoluzione delle armi da fuoco non giocò nel declino della cavalleria il ruolo decisivo che le attribuisce la tradizione storiografica. Gli attacchi della cavalleria pesante venivano respinti molto più efficacemente con l'aiuto di un arco inglese o di una picca svizzera.
Solo la semplicità di imparare a sparare da una colubrina e da un archibugio, l'accessibilità e la natura democratica del nuovo tipo di arma, moltiplicata per l'effetto psicologico che aveva, permisero quest'ultimo entro la metà del XVI secolo. estromettere l'arco dagli affari militari europei e verso la metà del XVIII secolo. - luccio di fanteria.
L'ostacolo per gli specialisti nel campo della storia militare è stata la periodizzazione dell'era cavalleresca, l'identificazione di alcune pietre miliari, di regola adattate artificialmente a un denominatore comune, dell'origine, dello sviluppo e della morte della cavalleria europea. 
È ovvio che le origini dell’emergere della cavalleria come istituzione militare-sociale non risiedono nell’invenzione della staffa o nella ratifica della benefica riforma di Carlo Martello, e le ragioni del suo declino e della sua morte difficilmente possono essere ricercate in l'abilità e la disciplina dell'alabardiere svizzero o del moschettiere spagnolo. Inoltre, il termine stesso "cavalleria" è estremamente condizionale e può essere interpretato su piani filologici, etici e militari completamente diversi. Il modo empirico di pensare di una persona richiede una chiara datazione di un particolare fenomeno. Tuttavia, la cronologia di aspetti dell’attività sociale come la politica o l’economia è solitamente molto difficile da decifrare. Pertanto, quando si parla del declino della cavalleria e tenendo conto della convenzionalità sia della fraseologia che del fenomeno stesso, si possono dichiarare responsabilmente solo quelle pietre miliari cronologiche che i contemporanei degli eventi stessi hanno interpretato in modo identico alla posizione data e documentato.
Così il cavalierato francese, in quanto corporazione militare, perse la sua immunità professionale e fu teoricamente abolito grazie alle ordinanze reali del 1445-1447. La stessa cosa accadde nel 1471 con il cavalierato borgognone.
Nonostante tutta la loro somiglianza esterna, lo stendardo cavalleresco e la compagnia dei gendarmi erano completamente diversi nel contenuto interno. È difficile immaginare un barone che riceve un congedo in un momento strettamente definito e per un periodo chiaramente limitato, che esegue tecniche di esercitazione e condivide una cortigiana con il suo sergente.
Nei secoli XIV-XV. Anche la cavalleria europea sta perdendo le sue barriere di classe. Il patrizio dei comuni italiani e delle città olandesi, percependo l'armamentario cavalleresco come un elemento di un gioco sofisticato, acquisisce i propri stemmi e fieri motti. Allo stesso tempo, molti nobili iniziano a trascurare il rito della nomina a cavaliere e la padronanza delle sette arti cavalleresche si riduce a esercizi irregolari di volteggio e scherma.
Tuttavia, gli ideali cavallereschi riuscirono a sopravvivere a lungo ai loro creatori. L'era moderna ha lasciato il segno su di loro e il credo cavalleresco "la vita non è niente, l'onore è tutto" è stato infine trasformato nel motto della Legione d'Onore francese: ONORE E PATRIA.
Appunti:
*1. Vsevolodov I.V. Conversazioni sulla faleristica. Dalla storia dei sistemi di ricompensa. M., 1990.
*2. Froisser I. Cronache. V.I, Parigi, 1975.
*3. Le Livre des Tournois du Roi René. Hercher, 1986.
*4. Canzone dei Nibelunghi. L., 1972.
*5. Commin F. Memorie. M.; 1986.
Illustrazioni (artista - A. Kurkin):
Nella prima pagina di copertina:
Armatura dell'arciduca Sigismondo del Tirolo.
Realizzata nel 1480 dal famoso armaiolo di Augusta Lorenz Helmschmidt per il diciottenne arciduca. Attualmente conservato a Vienna.
Riso. 1. Varianti di catene e segni dell'Ordine del Toson d'Oro.
Riso. 2. Armamento ed equipaggiamento per il combattimento equestre (torneo) di Francesco II, duca di Bretagna (dal “libro dei tornei” di Renato d'Angiò).
Fig 3. Armatura “gotica” e suoi elementi (seconda metà del XV secolo Germania).
Riso. 4. Armi ed equipaggiamento completi del capitano dei gendarmi, realizzati in stile “gotico”. (metà del XV secolo Francia, Germania).
Qualsiasi utilizzo dei materiali è consentito solo con il permesso della redazione.
Nell'utilizzo dei materiali è OBBLIGATORIO il riferimento a “PARA BELLVM”.
Il periodo di massimo splendore del feudalesimo fu il tempo della cavalleria e del suo metodo di combattimento intrinseco. Cavalleria pesante nei secoli XII-XIII. regna sovrano sul campo di battaglia. Allo stesso tempo, il numero delle truppe viene ridotto: anche nelle grandi battaglie, il numero dei partecipanti di solito non supera le centinaia, raramente raggiunge diverse migliaia.
Le unità ausiliarie di fanteria e di cavalieri armati leggeri sono numerose, ma l'esito delle guerre dipende quasi esclusivamente dai cavalieri.
L'armamento del cavaliere subisce alcune modifiche. La lancia pesante della cavalleria è ancora utilizzata per l'offensiva. Diventa gradualmente più complessa strutturalmente e aumenta di dimensioni: sulla lancia appare una guardia per la mano, che copre parte del corpo del cavaliere, l'asta diventa più pesante e più lunga. Un colpo violento con una lancia del genere porta a conseguenze disastrose per il nemico. Anche una seduta salda in sella serve allo scopo: diventa sempre più difficile far cadere il cavaliere.
La spada carolingia, senza cambiare nel disegno, aumenta anche di dimensioni. Nel 13 ° secolo compaiono le sue varianti da un anno e mezzo (con un manico leggermente allungato, che a volte veniva afferrato con entrambe le mani), così come i prototipi di una vera e propria spada a due mani. Nel 13 ° secolo si trasforma in una classica spada da cavaliere di circa le stesse dimensioni, ma con lama notevolmente affusolata dotata di punta pronunciata. Questa spada ha una guardia sviluppata e un potente pomo (mela), a dimostrazione del ruolo maggiore della scherma con la spada in assenza di uno scudo. Diventa più piccola, secondo le esigenze dell'epoca: la funzione di protezione del corpo è sempre più assolta dall'armatura.
Numerosi esempi di armi da colpo vengono utilizzati attivamente: flagelli, mazze, ecc. Essendo comuni nell'alto medioevo, col tempo trovarono applicazione nell'ambiente cavalleresco. La loro popolarità è associata al fiorire degli ordini cavallereschi spirituali. Sconfiggere il nemico senza spargere sangue era in qualche modo indebolito dalla contraddizione con i comandamenti del Vangelo, che ogni monaco guerriero doveva affrontare.
Le armi leggere non erano ancora rappresentate nell'arsenale cavalleresco come ignobili. La balestra veniva talvolta usata volentieri, soprattutto durante gli assedi ai castelli. Tuttavia, non è molto incoraggiato - nel XII secolo. fu emessa una bolla papale che ordinava l'uso delle balestre solo nelle guerre con gli infedeli (ovviamente, a causa della loro efficacia) - in questo modo si cercava di limitare le perdite tra i cavalieri nelle guerre europee.
Anche l'armatura è stata trasformata. Nel periodo classico dominava l'usbergo di cotta di maglia: una camicia con cappuccio e guanti realizzata contemporaneamente ad essa. Le calze di cotta di maglia vengono messe sulle gambe e attaccate alla cintura. Questo kit sarebbe diventato un classico durante le Crociate, solitamente completo di elmo, anche se a volte mancava. Per attutire i colpi, sotto la cotta di maglia venivano indossate vesti di pelle o di stoffa trapuntata.
Tutto ciò aiutava a proteggere dai colpi taglienti accidentali (non parati), ma non era una garanzia di sicurezza. Le armi leggere penetravano quasi sempre nell'armatura. Tuttavia, i cavalieri europei, di regola, non incontravano i nomadi, e quindi il problema non era troppo acuto. Per i teatri di guerra europei, tale armatura era l'ideale.
I requisiti gradualmente crescenti per la qualità della protezione e i progressi tecnologici nella metallurgia hanno permesso di creare un tipico elmo a forma di pentola del 13 ° secolo. (il cosiddetto tophelm) e rinforzare la cotta di maglia con piastre metalliche, che col tempo ricoprirono una zona sempre più ampia del corpo. L'armatura a piastre iniziava con gli stinchi e gli avambracci, che erano principalmente esposti agli impatti.
Durante le Crociate si scoprì che le armature si riscaldavano al sole, causando non pochi disagi. Fu allora che venne loro l’idea di utilizzare indumenti di stoffa (cotta o sopravveste). Divenne pratica comune indossare mantelli sopra le armi protettive. L'armatura cavalleresca non sarà più coperta da abiti solo nella prima metà del XV secolo.
Tipiche del periodo classico furono le incursioni di eserciti feudali relativamente piccoli, il cui nucleo erano distaccamenti di cavalieri. Le principali forme di scontri militari sono battaglie regolari, distruzione dell'area circostante e assedio delle fortezze.
Di solito la battaglia, che inizialmente consisteva in un attacco a cavallo - muro contro muro, si trasformava in una serie di duelli quando i cavalieri cercavano di scegliere un avversario in base al proprio status. Molto rapidamente, il compito principale non divenne l'omicidio, ma costringere alla resa per ricevere un riscatto, così come il cavallo e l'armatura dei vinti. Pertanto, le guerre cavalleresche erano quasi incruente. In una battaglia alla quale prendevano parte centinaia di cavalieri, spesso morivano solo poche persone.
Altri rami dell'esercito servivano a scopi ausiliari. La cavalleria leggera era destinata alla ricognizione, la fanteria copriva i convogli e creava l'effetto di comparse, essendo coinvolta anche negli assedi. Esempi classici di tali battaglie furono le battaglie di Bouvines e Laroche-aux-Moines (entrambe nel 1214).
La devastazione del territorio nemico era la forma di guerra più importante nel Medioevo, poiché rappresentava il modo più semplice per infliggere danni al nemico.
Per quanto riguarda le operazioni d'assedio, con l'inizio della costruzione di massa di castelli in pietra in Europa (a partire dall'XI secolo) e l'emergere di molte città grandi e piccole, si rivelarono sempre più rilevanti.
La fortezza consentiva di radunare truppe e mantenerne l'efficacia in combattimento, oltre a controllare il territorio circostante. La costruzione dei castelli si trasformò rapidamente in un intero ramo dell'arte militare: furono costruiti tenendo conto delle caratteristiche del paesaggio. Particolarmente inespugnabili erano i castelli costruiti nelle zone montuose dell'Alto Reno, ai piedi delle Alpi, dei Pirenei, degli Appennini e dei Carpazi, ecc. In assenza di polvere da sparo e attrezzature d'assedio di alta qualità, non era possibile prenderli.
Di norma, il castello comprendeva una torre principale (mastio), un complesso di edifici economici, militari e residenziali, uno o più anelli di potenti mura in pietra o mattoni con torri. Il suo assedio poteva durare mesi e perfino anni; A volte il castello era difeso da un piccolissimo contingente di diverse dozzine di persone. Allo stesso tempo, nei secoli XII-XIII. le tecniche di assedio e lancio si stanno notevolmente sviluppando; compaiono anche campioni che a volte superano le invenzioni dell'antichità.
I tornei stanno diventando estremamente popolari: regolari competizioni di cavalieri, che si riducono ai classici duelli con lance e altre forme di combattimento cavalleresco. A poco a poco le loro regole divennero più rigide. Se all'inizio combattevano esclusivamente con armi contundenti, usavano sempre più armi militari. In un certo senso, il confine tra torneo e guerra cavalleresca divenne illusorio, e la sua scomparsa fu impedita solo dalla rinascita della fanteria.
L'emergere di società specifiche dominate dal terzo stato (ad esempio in Svizzera), l'organizzazione di unità di autodifesa nelle città, il progresso delle armi di fanteria (la comparsa dell'alabarda e la diffusione di archi e balestre) hanno reso possibile entro la fine del XIII - inizio del XIV secolo. formare efficaci distaccamenti di fanti, capaci di resistere ugualmente anche alle formazioni chiuse di cavalleria cavalleresca. Fu creata una sorta di specializzazione: arcieri inglesi, balestrieri genovesi, alabardieri fiamminghi e svizzeri - nel XIV secolo. una forza importante sul campo di battaglia. L'era del dominio della cavalleria stava volgendo al termine.
Esempi classici di azioni di fanteria di successo sono la battaglia di Courtrai (1302) e tutte le principali battaglie della Guerra dei Cent'anni (Crecy - 1346, Poitiers - 1356, Agincourt - 1415).
Meno rivoluzionario, stranamente, fu il primo uso militare della polvere da sparo. Fino alla fine del XV secolo. le armi da fuoco rimanevano per lo più stazionarie (artiglieria) e avevano una cadenza di fuoco estremamente bassa. Ciò ne escludeva l'utilizzo nelle battaglie campali, limitandolo ad azioni di controfortificazione. Solo nel XVI secolo. Verranno utilizzati modelli di armi leggere veramente mobili ed efficaci, che sostituiranno l'arco e la balestra.
La comparsa delle armi cavalleresche nei secoli XIV-XV. assume un aspetto da manuale: una corazza in piastre d'acciaio che copre il busto è completata da rivestimenti in piastre per braccia e gambe, assemblati da dozzine di parti, solitamente su cinture di cuoio. Sotto l'armatura c'è quasi sempre una cotta di maglia. Lo scudo diventa di dimensioni del tutto simboliche (tarch) e solitamente è completamente in metallo.
Il casco viene modificato, vengono create due versioni. Uno è un bacinetto (“muso di cane”) con visiera mobile e fortemente sporgente, che si trasformò gradualmente nei classici elmi del XV secolo. - come armais e bourguignon. La seconda - l'insalata, a volte con visiera, ma che copre la testa solo dall'alto - è diffusa sia nella cavalleria che nella fanteria.
Entro la fine del XV secolo. l'armatura cavalleresca (gotica) con un peso totale di circa 25-33 kg ha permesso di ottenere la massima efficienza in battaglia pur mantenendo la manovrabilità. Il miglioramento del modello - l'armatura di Massimiliano - è solo un tentativo di prolungare l'esistenza dell'elemento un tempo principale dell'equipaggiamento cavalleresco.
La lancia come arma principale di un cavaliere diventa un anacronismo, cedendo nel XV-XVI secolo. primato alla spada. Nel corso del tempo appare una gigantesca spada a due mani, lunga fino a 150-160 cm o più, che sta diventando sempre più popolare tra la fanteria, in particolare tra i lanzichenecchi tedeschi. Il modo di combattere con tali armi non ricorda più le azioni dei guerrieri dell'alto Medioevo, lo scudo praticamente non viene utilizzato. Il desiderio di colpire un nemico corazzato in luoghi vulnerabili porta al fatto che una spada da taglio pesante si trasforma in un'elegante spada destinata alla scherma. Qui finisce l'evoluzione delle armi bianche nel Medioevo.
A cavallo dei secoli XV-XVI. Il ruolo strategico dei castelli viene meno significativo a causa dello sviluppo dell'artiglieria. I miglioramenti nelle azioni della fanteria e nelle sue armi resero inutile l'uso delle armature d'acciaio, e intorno al 1550 esse andarono quasi universalmente in disuso, rimanendo solo un elemento del costume cerimoniale dei comandanti e talvolta riprendendo sotto forma di corazza in cavalleria pesante. L'era delle guerre cavalleresche sta finalmente finendo.
Chiunque abbia mai visitato l'Ermitage di San Pietroburgo non dimenticherà certamente l'impressione lasciata dalla famosa Sala dei Cavalieri. E così sembra che attraverso strette fessure negli elmi decorati con magnifiche piume, i severi cavalieri-guerrieri dei tempi antichi, rivestiti di acciaio dalla testa ai piedi, osservano con cautela chiunque entri. I cavalli da guerra sono quasi completamente ricoperti da un'armatura pesante, come se aspettassero solo il segnale della tromba per precipitarsi in battaglia.
Tuttavia, ciò che forse colpisce di più è la squisita maestria nella finitura delle armature: sono decorate con niello, costose dorature e sbalzi.
E non puoi distogliere lo sguardo dalle armi cavalleresche nelle teche di vetro: ci sono pietre preziose, argento, dorature sulle impugnature delle spade e i motti dei loro proprietari sono incisi sulle lame azzurrate. I pugnali lunghi e stretti stupiscono per l'eleganza del loro lavoro, la perfezione e la proporzionalità della loro forma: sembra che non sia stato un fabbro-armaiolo a lavorarci, ma un abile gioielliere. Le lance sono decorate con bandiere, le alabarde con rigogliose nappe...
In una parola, in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza romantica, i lontani tempi cavallereschi vengono resuscitati davanti a noi in una delle sale del museo. Quindi non ci crederai subito: tutto questo splendore colorato e festoso appartiene... al periodo peggiore della cavalleria, al suo declino, alla sua estinzione.
Ma lo è davvero! Queste armature e queste armi di straordinaria bellezza furono forgiate in un'epoca in cui i cavalieri stavano perdendo sempre più la loro importanza come principale forza militare. Sui campi di battaglia tuonavano già i primi cannoni, capaci di disperdere a distanza le schiere corazzate di un attacco cavalleresco a cavallo; la fanteria già addestrata e ben preparata, con l'aiuto di speciali uncini, strappava facilmente i cavalieri dalle selle in corpo a corpo, trasformando i formidabili combattenti in un mucchio di metallo, disteso impotente a terra.
E né i maestri d'armi, né i cavalieri stessi, abituati a battaglie che si dividevano in duelli corpo a corpo separati con gli stessi cavalieri, non potevano più opporsi ai nuovi principi della guerra.
In Europa apparvero eserciti regolari: mobili, disciplinati. L'esercito cavalleresco fu sempre, infatti, una milizia che si riuniva solo su chiamata del suo signore. E nel XVI secolo - e la maggior parte delle armature e delle armi scintillanti risalgono a quest'epoca - tutto ciò che restava alla classe cavalleresca era brillare alle parate reali come scorta onoraria e partecipare ai tornei nella speranza di guadagnarsi lo sguardo favorevole. di alcune dame di corte su un podio lussuosamente decorato.
Eppure, per più di mezzo migliaio di anni, i cavalieri furono la forza principale dell'Europa medievale, e non solo militare. Molto è cambiato durante questo periodo: la visione del mondo di una persona, il suo modo di vivere, l'architettura, l'arte. E il cavaliere del X secolo non era affatto simile al cavaliere, diciamo, del XII secolo; Anche il loro aspetto era straordinariamente diverso. Ciò è dovuto allo sviluppo delle armi cavalleresche: sia le armature protettive che le armi offensive venivano costantemente migliorate. In ambito militare l'eterna competizione tra attacco e difesa non è mai cessata e gli armaioli hanno trovato numerose soluzioni originali.
È vero, ora non è così facile giudicare come siano cambiate le armi europee prima del X secolo: gli storici si affidano principalmente solo alle miniature di antichi manoscritti, che non sono sempre eseguiti accuratamente. Ma non c'è dubbio che i popoli europei utilizzassero i principali tipi di armi dell'antica Roma, modificandole leggermente.
Come erano le armi cavalleresche agli albori della cavalleria?
I guerrieri romani usavano una spada a doppio taglio con una larghezza da 3 a 5 centimetri e una lunghezza da 50 a 70 centimetri come arma offensiva. Il bordo a forma di cono della spada era ben affilato; un'arma del genere poteva sia tagliare che pugnalare in battaglia. I legionari romani erano armati di lance da lancio e usavano archi e frecce.
Le armi difensive erano costituite da un elmo con alta cresta, uno scudo rettangolare leggermente ricurvo e una tunica di cuoio ricoperta di placche metalliche. Probabilmente, le armi protettive di un guerriero erano simili in Europa nell'alto medioevo.
A partire dai secoli X-XI, lo sviluppo delle armature e delle armi offensive può essere tracciato in modo molto più chiaro. La regina Matilde, moglie di Guglielmo il Conquistatore, capo dei Normanni che conquistarono l'Inghilterra nell'XI secolo, fece molto per i futuri storici.
Secondo la leggenda fu Matilde a tessere personalmente un enorme tappeto, oggi conservato nel museo della città francese di Bayeux, che raffigura dettagliatamente gli episodi della conquista dell'Isola Britannica da parte del marito, compresa la leggendaria battaglia di Hastings in 1066. Sul tappeto sono anche chiaramente mostrati campioni di armi di entrambe le parti in guerra.
L'arma offensiva di quest'epoca era una lunga lancia, decorata con una bandiera, con due o anche più punte su una punta d'acciaio, nonché una spada lunga e diritta, leggermente smussata all'estremità. Il suo manico era cilindrico, con pomello a forma di disco e traversa diritta in acciaio. In battaglia venivano usati anche arco e frecce; il suo design era il più semplice.
Le armi protettive consistevano in una lunga camicia di cuoio, sulla quale erano rivettate scaglie di ferro o anche solo strisce di ferro. Questa camicia con maniche corte e larghe pendeva liberamente sul guerriero e non avrebbe dovuto ostacolare i suoi movimenti. A volte tale armatura era completata da pantaloni di pelle corti al ginocchio.
Sulla testa del guerriero c'era un cappuccio di cuoio, sopra il quale era indossato un elmo conico con un'ampia freccia di metallo che copriva il naso. Lo scudo era lungo, quasi intero, a forma di mandorla. Era composto da assi robuste e rivestito all'esterno con pelle spessa con finiture in metallo. Un guerriero protetto in questo modo era quasi invulnerabile alle moderne armi offensive.
A volte, invece di scaglie o strisce di ferro, sulla base di cuoio venivano cucite file di anelli di ferro; in questo caso gli anelli di una fila coprivano la metà di quella successiva. Successivamente, gli armaioli iniziarono a realizzare armature costituite solo da anelli di acciaio, ciascuno dei quali catturava quattro anelli adiacenti ed era ermeticamente sigillato.
Tuttavia, in tutta onestà, va sottolineato che questa idea è stata presa in prestito dagli europei in Oriente. Già nella prima crociata, proprio alla fine dell'XI, i cavalieri incontrarono un nemico vestito con una cotta di maglia leggera e flessibile e apprezzarono tali armi nel loro vero valore. Ottennero molte di queste armature orientali come trofei di guerra, e in seguito la produzione di cotta di maglia fu stabilita in Europa.
Se torniamo al romanzo Ivanhoe di Walter Scott, possiamo leggere come era armato uno degli eroi, il cavaliere Briand de Boisguillebert, che combatté a lungo in Palestina e da lì prese la sua armatura:
“Sotto il mantello si vedeva una cotta di maglia con maniche e guanti costituiti da anellini metallici; è stato realizzato con estrema abilità e si adatta perfettamente ed elasticamente al corpo come le nostre felpe, lavorate a maglia in morbida lana. Per quanto si potevano vedere le pieghe del mantello, i suoi fianchi erano protetti dalla stessa cotta di maglia; le ginocchia erano ricoperte da sottili piastre d'acciaio e i polpacci da calze di cotta di maglia metallica.
I cavalieri si vestono con una cotta di maglia
Entro la metà del XII secolo, il cavalierato era completamente rivestito di cotta di maglia. Le incisioni dell'epoca mostrano che la cotta di maglia d'acciaio copriva letteralmente il guerriero dalla testa ai piedi: venivano usate per realizzare protezioni per le gambe, guanti e cappucci. Questo indumento di acciaio flessibile veniva indossato sopra una maglietta di pelle o trapuntata per proteggersi dai lividi e poteva essere molto sensibile, anche se una spada o un'ascia da battaglia non tagliava gli anelli d'acciaio. Sopra la cotta di maglia indossavano una tunica di lino, che proteggeva l'armatura dai danni e dal riscaldamento dei raggi del sole.
All'inizio, la tunica sembrava molto modesta - dopo tutto era destinata alla battaglia - ma col tempo divenne un abito lussuoso e dandy. Era cucito con tessuto costoso e decorato con ricami, di solito con immagini dello stemma del cavaliere di famiglia.
Le armi di cotta di maglia erano incomparabilmente più leggere di prima. I contemporanei affermavano che muoversi al suo interno era facile e comodo come con gli abiti normali. Il cavaliere ricevette maggiore libertà d'azione in battaglia e fu in grado di infliggere colpi rapidi e inaspettati al nemico.
In tali condizioni, un grande scudo che copriva quasi tutto il corpo era, piuttosto, un ostacolo: la trama della cotta di maglia proteggeva già sufficientemente il corpo del cavaliere. Lo scudo, diventando gradualmente più piccolo, iniziò a servire solo come protezione aggiuntiva dai colpi di lancia o spada. La forma degli scudi era ora molto diversa. Lo stemma era raffigurato all'esterno e all'interno erano allacciate delle cinghie in modo che lo scudo potesse essere tenuto comodamente e saldamente sulla mano sinistra.
Per gli scudi rettangolari o allungati, la disposizione di tali cinture era trasversale. Negli scudi a sei o ottagonali, così come in quelli rotondi, le cinture erano posizionate in modo tale che una volta indossate, la base dello stemma fosse sempre in basso. La cintura più larga cadeva sull'avambraccio e quella più corta e stretta veniva fissata con la mano.
Anche l'elmo cambiò: ora non era più conico, ma a forma di vasca. I suoi bordi inferiori poggiavano sulle spalle del cavaliere. Il viso era completamente coperto, lasciando solo strette fessure per gli occhi. Le decorazioni apparivano anche sugli elmi di legno, osso, metallo - sotto forma di corna, enormi artigli, ali, guanti da cavaliere di ferro...
Tuttavia, anche quest'arma apparentemente abbastanza avanzata, affidabile e conveniente aveva i suoi inconvenienti. Il casco a forma di vasca forniva troppo poca aria per respirare. Al culmine del litigio ho dovuto addirittura togliermelo per non soffocare. Non era facile orientarsi nelle strette orbite; È successo che il cavaliere non riusciva a distinguere immediatamente il nemico dall'amico. Inoltre, l'elmo non era fissato in alcun modo con altre armature e con un colpo abile poteva essere ruotato in modo che il lato cieco apparisse davanti agli occhi invece delle fessure. In questo caso, il cavaliere era alla completa mercé del nemico.
E ora anche le armi offensive sono diventate diverse. Nel X secolo, l'armatura protettiva era più facile da tagliare che da perforare. Ma se il nemico è protetto da una cotta di maglia, allora il colpo tagliente, invece di strisce di ferro rivettate sulla pelle, incontra una superficie metallica flessibile che scorre e pende in pieghe.
Qui, un colpo penetrante era molto più efficace, separando e perforando gli anelli relativamente sottili della cotta di maglia. La spada assume quindi una forma più comoda per la spinta: la lama termina con un'estremità affilata, e l'intera striscia della lama è rinforzata da una nervatura convessa che corre al centro dalla punta al manico.
Una spada del genere era forgiata da una striscia di acciaio larga da 3 a 8 centimetri e lunga fino a un metro. La lama era a doppio taglio, ben affilata all'estremità. L'impugnatura era di legno o osso, protetta da una piccola copertura a forma di croce - una guardia, e terminava con un contrappeso ispessente per rendere la spada più comoda da impugnare.
Indossavano la spada in un fodero sul lato sinistro su una speciale fionda fissata con una fibbia. Entro la fine del XIII secolo, la spada, così come il pugnale, erano talvolta dotati di catene d'acciaio sottili ma resistenti, che erano attaccate all'armatura del cavaliere. C'erano meno possibilità di perderli in battaglia. La spada di ogni cavaliere aveva il proprio nome, come se fosse una creatura animata. La spada del cavaliere Roland, l'eroe della famosa "Canzone", si chiamava Durandal, la spada del suo fedele amico Olivier si chiamava Altclair.
Un'altra principale arma cavalleresca, la lancia, divenne più lunga. L'asta dipinta a volte raggiungeva i quattro metri; la punta era, di regola, stretta e tetraedrica.
Gli armaioli ora dovevano cercare protezione specifica contro un colpo penetrante. Come spesso accade, ho dovuto ricordare di nuovo qualcosa che sembrava essere già stato abbandonato: l'armatura a scaglie. È vero, sono cambiati in modo irriconoscibile.
La base per ulteriori armi protettive era un'elegante tunica, che veniva indossata sopra la cotta di maglia. Ma hanno iniziato a cucirlo con materiale molto resistente o addirittura con pelle. Tuttavia, era ricoperto sopra di seta o velluto e foderato con scaglie di metallo sotto. Ciascuna delle squame era attaccata a un perno separato e le estremità dei perni erano distribuite e dorate o addirittura decorate con pietre preziose.
Tali armi, che completavano la cotta di maglia, si rivelarono molto affidabili, ma, ovviamente, proibitivamente costose. Non tutti i cavalieri potevano permetterselo. E chi lo possedeva se ne prese cura in ogni modo possibile, utilizzandolo non più in battaglia, ma in tornei o solenni cerimonie di corte. Tuttavia, furono proprio tali armi a influenzare l'ulteriore evoluzione dell'armatura cavalleresca.
L'armatura diventa metallo
Nel corso del tempo, ulteriori strisce di metallo iniziarono a essere rafforzate direttamente sulla cotta di maglia. Anche le cosce di cotta di maglia furono rafforzate. Particolare attenzione è stata prestata alla protezione di quelle parti dell'armatura più esposte agli attacchi in battaglia. È così che è apparso un altro tipo di armi aggiuntive: spallacci, bracciali, ginocchiere con leggings.
I bracciali - dalla spalla al gomito, e gli schinieri - dal ginocchio al piede, erano già così grandi che coprivano le braccia e le gambe fino alla metà del loro spessore, proteggendo completamente la parte anteriore. Erano fissati dietro con robuste cinture e fibbie. Non era più possibile indossare un'armatura del genere senza l'aiuto di uno scudiero.
A volte piccole parti mobili erano attaccate ai bracciali da strette strisce trasversali collegate tra loro secondo il principio delle stesse scale, che coprivano la spalla e il gomito. Anche i leggings sono stati allungati: il collo del piede è stato protetto. I guanti da cavaliere in pelle erano realizzati con campanelli larghi e rinforzati all'esterno con solide scaglie di metallo.
All'inizio del XV secolo, sulla base della cotta di maglia c'era già così tanto metallo che aveva senso abbandonare del tutto la cotta di maglia. Le singole parti metalliche erano fissate insieme con strisce di cuoio duro, pressato e bollito nell'olio.
Sotto un simile guscio, il cavaliere indossava una spessa giacca trapuntata di pelle o di materiale denso. Sopra veniva ancora indossata una tunica elegante, ma ora consisteva di due parti: superiore e inferiore. La metà anteriore della parte superiore è stata notevolmente accorciata per aprire la parte inferiore e ristretta in modo che si adattasse perfettamente, senza pieghe, al corpo. Una o due placche di metallo iniziarono a essere cucite sulla tunica superiore, alla quale erano attaccate catene di elmo, spada e pugnale. Il cavaliere era cinto da un'ampia cintura con struttura in metallo e fibbia. Lo indossavano senza stringerlo, ma abbassandolo liberamente sui fianchi. Su una spada del genere erano appesi una spada e un pugnale nel fodero.
Lo scudo in quel momento era ancora piccolo, ma la sua forma divenne triangolare quasi ovunque.
Ma la forma degli speroni, che servivano come accessorio necessario per il cavaliere, e inoltre erano la principale distinzione del cavalierato - al momento dell'iniziazione, al cavaliere venivano dati speroni d'oro come simbolo - quasi non è cambiata. Erano una punta rotonda, o addirittura sfaccettata, o una ruota dentata su un collo corto. Gli speroni erano fissati con cinghie fissate abbastanza in alto sopra il tallone.
Le modifiche interessarono anche le armi usate per proteggere il cavallo da guerra del cavaliere. Qui, come nel caso del cavaliere, la cotta di maglia è stata sostituita da strisce di metallo fissate con pelle.
C'era, ovviamente, una buona ragione per il costante miglioramento delle armi offensive e difensive cavalleresche nei secoli XIV-XV. Era la Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia, durante la quale gli inglesi conquistarono vasti territori francesi, possedevano Parigi, ma alla fine furono espulsi e mantennero solo la città costiera di Calais. La guerra fu piena di battaglie sanguinose e le perdite da entrambe le parti furono così grandi che gli armaioli dovettero mostrare molta ingegnosità. Tuttavia, proprio perché gli scontri tra inglesi e francesi erano troppo frequenti, ogni miglioramento apportato da una delle parti veniva immediatamente adottato dall'altra, e le possibilità si equilibravano nuovamente.
A proposito, lo sviluppo delle armi è stato influenzato anche da altri fattori, ad esempio... cambiamenti nel taglio degli abiti secolari. Quando erano di moda canottiere attillate, pantaloni attillati con sbuffo sulla pancia e punte delle scarpe lunghe, a volte anche risvoltate, anche l'armatura cavalleresca veniva adattata a questo standard. Non appena si diffusero abiti più ampi e larghi, le armature furono forgiate in questo modo.
Lo sviluppo delle armi fu influenzato anche dal fatto che all'inizio della guerra il successo accompagnò costantemente gli inglesi, e questo rafforzò la tendenza già in via di sviluppo tra i cavalieri inglesi a sfoggiare equipaggiamenti militari belli e riccamente decorati. In questo volevano, se non superare, almeno confrontarsi con i cavalieri francesi, che avevano un tale brio, come si suol dire, nel sangue e che, ovviamente, accettarono anche qui la sfida del nemico.
Ma i cavalieri tedeschi si distinguevano per un evidente conservatorismo nella moda. Vivevano piuttosto appartati nei loro castelli; le innovazioni francesi arrivarono nelle loro terre con grande ritardo. Tuttavia, la tendenza all'ostentazione non era loro del tutto estranea: i cavalieri tedeschi amavano decorare le loro armature con campanelli e campanelli.
Armi cavalleresche nel XV secolo
Nel XV secolo, le armi cavalleresche cambiarono rapidamente e le singole parti continuarono a essere migliorate.
I bracciali furono notevolmente migliorati con l'aggiunta di placche rotonde convesse che proteggevano il gomito. Successivamente ai bracciali già semiformati furono aggiunte parti complementari, collegate ad essi mediante cerniere e cinturini con fibbie. Adesso tutto il braccio del cavaliere, dalla spalla alla mano, ad eccezione del gomito, era ricoperto di acciaio. Ma anche il gomito era ricoperto da strette strisce trasversali di ferro. Con l'aiuto dei cardini sono stati resi mobili.
Esattamente come i bracciali, anche i gambali sono stati migliorati. Con l'aiuto di piccole piastre laterali, le ginocchiere sono diventate mobili. Se prima il metallo copriva le gambe solo nella parte anteriore e per metà, ora si aggiunge un'altra metà metallica, fissata alla prima con cerniere e cinghie, che sono state via via sostituite da ganci più comodi e affidabili. Ora, dalla cavità poplitea al calcagno, la gamba del cavaliere era protetta con l’acciaio.
Alla fine cambiarono anche gli speroni del cavaliere: divennero più lunghi e con ruote molto grandi.
Lo scomodo elmo a forma di vasca fu sostituito da un elmo con visiera metallica dotata di occhi e fori per la respirazione. La visiera era incernierata ai lati dell'elmo e, all'occorrenza, poteva essere sollevata, rivelando il volto, e abbassata nuovamente in caso di pericolo.
Tuttavia, il vecchio elmo pesante non andò completamente in disuso, ma iniziò ad essere utilizzato nei tornei, per i quali l'armatura, a differenza di quella da combattimento, fu resa ancora più massiccia. È vero, ha subito alcune modifiche: l'elmo del torneo cominciò ad essere attaccato alle spalline, c'erano fessure più grandi per gli occhi, ma per maggiore sicurezza furono coperti con un'ulteriore griglia metallica.
Con tali armi cavalleresche migliorate, lo scudo, a quanto pare, divenne meno necessario; continuò ad essere indossato piuttosto secondo la tradizione. Ma gradualmente il precedente scudo triangolare fu completamente sostituito da un altro: quadrangolare, con un bordo inferiore arrotondato e un ritaglio per una lancia, realizzato nell'angolo in alto a destra. E un tale scudo veniva indossato in modo speciale: non sulla mano sinistra, ma appeso a una cintura corta indossata sopra la spalla. Proteggeva solo la parte superiore destra del torace e il braccio destro. Successivamente abbandonarono anche la cintura da cui era sospeso: lo scudo era fissato al guscio con ganci o avvitato con viti. E dalla seconda metà del XV secolo, come l'antico elmo a forma di vasca, cominciò ad essere utilizzato solo nei tornei.
Le singole piastre metalliche delle armi protettive furono sempre più ingrandite e assemblate insieme. Alla fine, il cavaliere si ritrovò completamente vestito di ferro.
Il petto e la schiena erano ricoperti da una solida corazza, fissata con ganci laterali. La parte inferiore dell'addome e la parte superiore delle gambe erano protette da piastre aggiuntive fissate alla corazza. Le singole parti della corazza erano rivettate sulle cinture e quindi, in generale, l'armatura era abbastanza flessibile.
L'elmo è cambiato di nuovo: gli armaioli hanno inventato la cosiddetta "insalata". Sembrava una ciotola rovesciata con i lati leggermente inclinati e una piastra posteriore allungata. Quando l'insalata veniva tirata sopra la testa, la copriva interamente fino alla linea del naso. Per proteggere la parte inferiore del viso, sul fondo della corazza era fissata una speciale mentoniera. In questo modo sia la testa che il viso erano completamente protetti, e per gli occhi c'era uno stretto spazio tra il bordo inferiore dell'insalata e il bordo superiore del mento.
L'insalata potrebbe essere lanciata un po' indietro dietro la testa, aprendo il viso e consentendo un maggiore accesso all'aria e, in caso di pericolo, potrebbe essere tirata rapidamente indietro sopra la testa.
Un'armatura di questo tipo, ovviamente, richiedeva notevole abilità e tempo per essere prodotta ed era molto costosa. Inoltre, le nuove armi diedero origine anche a un tipo speciale di decorazione: le singole parti dell'armatura iniziarono ad essere ricoperte con rilievi artistici, dorature e niello. Questa moda ebbe origine alla corte del duca di Borgogna, Carlo il Temerario, e si diffuse rapidamente. Ora non c'era bisogno di indossare una ricca tunica ricamata, poiché l'armatura stessa sembrava molto più lussuosa. Naturalmente erano disponibili solo per i cavalieri più nobili e ricchi. Tuttavia, chiunque altro poteva ottenerli, come trofeo sul campo di battaglia o in un torneo, o anche come riscatto per un prigioniero.
Tale armatura non pesava così tanto: 12-16 chilogrammi. Ma alla fine del XV secolo divenne molto più massiccio, e per una buona ragione: il cavaliere doveva difendersi dalle armi da fuoco. Ora il peso delle armi difensive potrebbe superare i 30 chilogrammi; le singole parti dell'armatura raggiunsero il centinaio e mezzo. Naturalmente era possibile spostarsi al suo interno solo a cavallo, ora non aveva senso pensare a combattere a piedi.
E sebbene un'armatura così pesante risalga davvero al declino della cavalleria, non si può fare a meno di rimanere stupiti non solo dalla decorazione artistica dell'armatura, ma anche dalla perfezione e dalla premurosità del loro design stesso.
L'armatura più avanzata
Entro la fine del XV secolo, gli armaioli trovarono finalmente una forma di elmo estremamente comoda e perfetta, che sostituì l'insalata. Qui tutte le parti che già esistevano, ma che prima erano state indossate separatamente, sono state combinate insieme con successo.
L'elmo del cavaliere assumeva una forma quasi sferica ed era dotato di un'alta cresta. Ad esso era fissata una visiera su cardini, che poteva muoversi su e giù lungo la cresta. Il mento era collegato all'elmo con anelli e copriva la parte inferiore del viso e del collo.
Una "collana" rotonda di metallo proteggeva la parte superiore del torace, la schiena e le spalle. Era realizzato con un “collare” verticale, forgiato lungo il bordo superiore con un flagello. Sul bordo inferiore dell'elmo era presente una scanalatura corrispondente, che consentiva di collegare l'elmo alla collana in modo molto saldo e sicuro.
La corazza era costituita da un pettorale e da uno schienale, collegati con fermagli. La corazza era modellata in modo tale da sembrare deviare un colpo diretto di una lancia o di una spada, ammorbidendolo.
Un gancio di sostegno era rivettato al pettorale sul lato destro per sostenere la pesante e lunga lancia. Le placche addominali erano attaccate alla parte anteriore, coprendo la parte superiore dell'addome. I gambali erano la loro continuazione e una copertura lombare era attaccata allo schienale.
I mantelli venivano fissati alla collana mediante cinghie o mediante apposite spille. Il mantello destro era sempre più piccolo del sinistro, per rendere più comodo tenere la lancia sotto l'ascella destra. Talvolta i mantelli erano dotati di alte creste che proteggevano il collo dai colpi laterali.
I bracciali erano divisi in due parti. Quello superiore era un tubo di metallo grezzo e quello inferiore era costituito da due metà fissate dall'interno. Il gomito era coperto da uno speciale guscio ulnare, che permetteva al braccio di piegarsi liberamente.
Le mani erano protette con guanti di metallo. A volte venivano addirittura realizzati con le dita separate.
Le gambe fino alle ginocchia erano coperte con le cosiddette coperture a mezzo tubo. Sotto c'erano le ginocchiere con una "presa" laterale che proteggeva la piega della gamba, e infine le protezioni per le gambe, che erano un tubo staccabile che andava dal ginocchio alla caviglia. I gambali, che proteggevano completamente la parte superiore dei piedi, furono realizzati in forme diverse in tempi diversi, a seconda di come cambiava la moda delle scarpe secolari.
Armatura del cavallo
Anche il cavallo da guerra, fedele compagno del cavaliere, era ormai quasi completamente nascosto dall'armatura. Per trasportare lui, e anche un cavaliere armato altrettanto pesantemente, il cavallo, ovviamente, richiedeva forza e resistenza speciali.
Il poggiatesta o il frontalino per un cavallo era solitamente forgiato da un unico foglio di metallo e ne copriva la fronte. Aveva grandi fori per gli occhi con bordi convessi, ricoperti da sbarre di ferro.
Il collo del cavallo era coperto da un collare. Era formato da scaglie striate trasversali e somigliava soprattutto... alla coda di un gambero. Questo tipo di armatura copriva completamente la criniera sottostante ed era attaccata alla fronte con una chiusura di metallo.
È stato fornito anche un bavaglino speciale. Composto da più larghe strisce trasversali, si chiudeva con il colletto e, oltre al petto, proteggeva la parte superiore delle zampe anteriori. I fianchi del cavallo erano ricoperti da due solide lamiere di acciaio collegate dai bordi concavi superiori. Le parti laterali dell'armatura erano strettamente collegate al pettorale.
Da dietro il cavallo era protetto da possibili attacchi anche da un'armatura molto ampia e convessa, forgiata da lastre solide o assemblata da strisce strette separate. Per mantenere saldamente in posizione tale armatura e non ferire il cavallo, sotto di essa veniva posta una speciale base di supporto, realizzata in legno e rivestita in tessuto o pelle, oppure interamente realizzata in osso di balena.
Le selle di tale armatura erano grandi, massicce, con un ampio pomello a forma di scudo che copriva in modo affidabile i fianchi del cavaliere e con la schiena alta. Le redini e le cinghie delle briglie erano molto larghe, con placche di metallo densamente rivettate su di esse, che servivano sia come decorazione che come protezione aggiuntiva dai colpi taglienti della spada.
Nelle sfilate cerimoniali, nei tornei o in altre celebrazioni, i cavalli da guerra cavallereschi venivano ricoperti sopra l'armatura con coperte lussuose e riccamente ricamate, che potevano, oltre a questo, essere decorate in qualche altro modo.
Qui non c'era davvero limite all'immaginazione. Come testimoniano i contemporanei, nel 1461, durante l'ingresso cerimoniale di Luigi XI a Parigi per l'incoronazione, i cavalli del suo seguito cavalleresco erano ricoperti in parte di broccato, in parte con coperte di velluto, che scendevano fino a terra e completamente tempestati di campanelli d'argento. E uno dei cavalieri vicini al re di nome La Roche, volendo distinguersi soprattutto, appese campanelli delle dimensioni di una testa umana attorno alla coperta del suo cavallo, che, come scrive un testimone oculare, "provocarono un suono terrificante".
Come sono cambiate le armi offensive?
Qui i cambiamenti esterni non furono così evidenti come nelle armi difensive. L'arma principale è sempre rimasta la spada. Verso la seconda metà del XIV secolo la lama venne allungata e, per potenziare il colpo, non divenne più a doppio taglio, ma affilata solo da un lato; l'altro si trasformò in un sedere largo. Per maggiore comodità, la maniglia precedentemente ampia è diventata più sottile ed è stata avvolta con filo. Il fodero era realizzato in cuoio duro, che veniva dipinto o ricoperto di stoffa, e poi rivestito con placche e decorazioni metalliche.
È interessante notare che la moda è cambiata anche nel modo di indossare la spada. A metà del XIV secolo, ad esempio, e poi nella seconda metà del XV secolo, i cavalieri portavano le spade non sul fianco sinistro, come era consuetudine in tutti gli altri tempi, ma davanti, al centro della cintura. ..
La lancia, altra arma principale del cavaliere, si divise gradualmente in due tipologie principali: da combattimento e da torneo. Il torneo cambiava costantemente nella lunghezza, nello spessore e nella forma della punta, che poteva essere smussata o affilata. La lancia da battaglia mantenne a lungo la sua forma originale e consisteva in una robusta asta di legno lunga da 3 a 5 metri, solitamente di frassino, e una punta di metallo. Solo l'avvento dell'armatura metallica solida costrinse gli armaioli a migliorare la lancia. È diventato molto più corto e più spesso. La mano del cavaliere che reggeva la lancia era ora protetta da un cappuccio d'acciaio a forma di imbuto sull'asta.
Un accessorio obbligatorio per un cavaliere era un pugnale con una lama quadrangolare stretta e lunga. Potrebbero colpire un nemico sconfitto nella minima apertura dell'armatura. Tale arma era chiamata il "pugnale della misericordia", perché accadde che un cavaliere sconfitto, non volendo implorare pietà, chiese al vincitore di finirlo, cosa che fece, mostrando al nemico l'ultima misericordia in segno di rispetto. per il suo valore e onore.
Altri tipi di armi offensive apparvero infine nell'Europa medievale, ad esempio un'enorme spada che raggiungeva fino a due metri di lunghezza. Poteva essere maneggiato solo con due mani, motivo per cui veniva chiamato a due mani. C'era una spada e "una mano e mezza". Si diffusero anche tipi speciali di armi da colpo: la mazza, l'ascia, la canna. Aveva lo scopo di sfondare armature ed elmi di metallo. Tuttavia, di regola, tutti questi tipi di armi non venivano usati dai cavalieri. Erano usati dalle truppe regolari e dalla fanteria assoldate.
Fabbro d'armi
Sfortunatamente, non molti dei nomi di coloro che hanno creato armi cavalleresche sono sopravvissuti fino ai nostri giorni. È un peccato: è stato realizzato con mani abili e molte armature, spade, lance, pugnali, elmi, scudi che ora sono esposti nei migliori musei del mondo possono essere giustamente definiti veri e propri capolavori. Combinano felicemente funzionalità attentamente studiate e completa bellezza artistica. È vero, sappiamo ancora qualcosa, anche se poco.
Nel tardo periodo della cavalleria, gli armaioli iniziarono a mettere segni sui loro prodotti e, grazie a ciò, si può sostenere che i maestri ereditari Aguirro, Hernandez, Martinez, Ruiz e alcuni altri lavoravano nella città spagnola di Toledo.
Nel nord Italia, Milano divenne un importante centro di armi, dove erano particolarmente famose le famiglie di artigiani Piccinino e Missaglia. E il famoso marchio di un'altra città italiana, Genova, è stato addirittura contraffatto da armaioli meno coscienziosi in altri luoghi d'Europa allo scopo di migliorare le vendite.
In Germania, la città di Solingen è sempre stata un famoso centro di armi.
Tattiche di battaglie cavalleresche
Tuttavia, ogni cavaliere aveva le sue armi individuali. Il cavaliere faceva affidamento solo su se stesso in un duello uno contro uno. Tuttavia, in una grande battaglia, i cavalieri agivano come un'unica forza, interagendo tra loro. Pertanto, ovviamente, l'esercito cavalleresco aveva anche tattiche speciali per condurre combattimenti generali. Inoltre, a differenza delle armi, è rimasta pressoché invariata per secoli.
Ora, dall'alto dei nostri tempi, è facile giudicarne la primitività e la monotonia, rimproverando ai cavalieri di seguire con noncuranza la disciplina elementare, di completo disprezzo per la fanteria, e anche per la propria. Tuttavia, erano i cavalieri a decidere l'esito di ogni battaglia. Cosa potrebbe opporsi la fanteria, seppur numerosa, a un distaccamento di guerrieri professionisti rivestiti di armature, spazzando via tutto sul loro cammino? Quando i principi del combattimento iniziarono a cambiare, la cavalleria dovette abbandonare. Non solo dai campi di battaglia, ma anche dal palcoscenico della storia.
L'esercito cavalleresco si radunò così: ogni cavaliere portò diversi scudieri sotto lo stendardo del suo signore, che durante la battaglia rimasero dietro la linea di battaglia, tenendo pronti diversi cavalli di riserva e armi di riserva. Inoltre, il cavaliere era accompagnato da cavalieri leggermente armati, che non erano altro che domestici, nonché da un distaccamento di fanteria reclutato dai servi.
I cavalieri stessi di solito si formavano in unità a cuneo prima della battaglia. Nella prima fila non c'erano più di cinque cavalieri, nelle due successive ce n'erano sette, seguiti da file di nove, undici e tredici cavalieri. Dietro, formando un quadrilatero regolare, seguiva il resto della cavalleria del cavaliere.
Queste formazioni, come probabilmente tutti ricordano dal film di Sergei Eisentstein, erano i cavalieri dell'Ordine Teutonico che avanzavano sull'esercito di Alexander Nevsky nella famosa Battaglia del Ghiaccio nel 1242. Ma, a proposito, le squadre russe usarono con entusiasmo lo stesso principio quando attaccarono per prime il nemico.
Con un cuneo così stretto era facile speronare le difese nemiche; soprattutto perché la parte in difesa di solito schierava fanteria scarsamente armata e scarsamente addestrata. Per mantenere la formazione per il momento decisivo della battaglia, il cuneo inizialmente si muoveva molto lentamente, quasi al passo, e solo quando si avvicinavano quasi al nemico i cavalieri facevano andare i loro cavalli.
L'enorme massa del cuneo sfondò facilmente la fanteria e immediatamente i cavalieri si voltarono con un ampio fronte. Fu allora che iniziò la vera battaglia, suddivisa in molti combattimenti separati. Potrebbe durare ore e spesso i leader di entrambe le parti non possono intervenire nel suo svolgimento.
Come hanno avuto luogo le arti marziali cavalleresche?
All'inizio, i cavalieri combatterono a cavallo: due cavalieri con lance pronte, coprendosi di scudi, si precipitarono l'uno contro l'altro, mirando allo scudo o all'elmo del nemico. Il colpo, amplificato dal peso dell'armatura, dalla velocità e dalla massa del cavallo, fu terribile. Il cavaliere meno agile, stordito, volò giù dalla sella con uno scudo spaccato o fece cadere l'elmo; in un altro caso, entrambe le lance si spezzarono come canne. Quindi i cavalieri lanciarono i loro cavalli e iniziò uno scontro con la spada.
Durante il Medioevo era molto diversa dalla scherma aggraziata e rilassata dell'epoca successiva dei moschettieri. I colpi erano rari e molto pesanti. L'unico modo per respingerli era con uno scudo. Tuttavia, nel combattimento ravvicinato, lo scudo potrebbe servire non solo come arma difensiva, ma anche offensiva: potrebbe, cogliendo l'attimo, spingere inaspettatamente il nemico tanto da fargli perdere l'equilibrio, e infliggergli immediatamente un colpo decisivo.
Idee abbastanza affidabili su come fosse un duello cavalleresco possono essere ottenute, ad esempio, dal famoso romanzo di Henry Rider Haggard "La bella Margaret", dove in una delle scene arrivarono i nemici giurati dell'inglese Peter Brook e dello spagnolo Morella faccia a faccia, anche se non sul campo di battaglia, ma sulle liste, alla presenza del re stesso e di molti spettatori, ma la battaglia tuttavia non era per la vita, ma per la morte:
"La collisione fu così forte che la lancia di Peter andò in pezzi, e la lancia di Morell, scivolando lungo lo scudo del nemico, rimase incastrata nella sua visiera. Peter barcollò sulla sella e cominciò a cadere all'indietro. Sembrava che stesse per cadere, le corde dell'elmo scoppiarono. L'elmo gli fu strappato dalla testa e Morella passò con l'elmo in punta di lancia.
Ma Peter non è caduto. Gettò via la lancia rotta e, afferrando la cinghia della sella, si tirò su. Morella cercò di fermare il suo cavallo per voltarsi e attaccare l'inglese prima che si riprendesse, ma il suo cavallo correva velocemente, era impossibile fermarlo. Alla fine gli avversari si voltarono di nuovo l'uno contro l'altro. Ma Peter non aveva né lancia né elmo, e sulla punta della lancia di Morell pendeva l'elmo del suo nemico, dal quale tentò invano di liberarsi.
La lancia di Morell era mirata al volto non protetto di Peter, ma quando la lancia fu molto vicina, Peter lasciò cadere le redini e colpì con il suo scudo il pennacchio bianco che svolazzava all'estremità della lancia di Morell, la stessa che era stata precedentemente strappata dalla testa di Peter. Calcolò correttamente: le piume bianche ondeggiavano molto basse, ma abbastanza perché, chinandosi sulla sella, Peter potesse scivolare sotto la sua lancia mortale. E quando gli avversari si avvicinarono, Peter tese il suo lungo braccio destro e, afferrando Morell come un gancio d'acciaio, lo tirò fuori dalla sella. Il cavallo nero corse avanti senza cavaliere e il cavallo bianco con un doppio carico.
Morella afferrò Peter per il collo, gli avversari si dondolarono in sella e il cavallo spaventato si precipitò finché non si voltò bruscamente di lato. Gli avversari caddero sulla sabbia e rimasero sdraiati per qualche tempo, storditi dalla caduta...
Peter e Morella si allontanarono l'uno dall'altro e sguainarono le loro lunghe spade. Pietro, che non aveva l'elmo, teneva alto lo scudo per proteggersi la testa e attendeva con calma l'attacco.
Morella colpì per primo, con la spada che cozzava con l'acciaio. Prima che Morella potesse tornare in posizione, Peter lo colpì, ma Morella si abbassò e la spada gli tagliò solo le piume nere dall'elmo. Con la velocità del fulmine, la punta della spada di Morell si precipitò direttamente in faccia a Peter, ma l'inglese riuscì a deviare leggermente e il colpo lo mancò. Morella attaccò di nuovo e colpì con tale forza che, sebbene Pietro riuscisse a sostituire il suo scudo, la spada dello spagnolo scivolò attraverso di lui e colpì il suo collo e la spalla non protetti. Il sangue macchiò l'armatura bianca e Peter barcollò.
Apparentemente infuriato per il dolore della ferita e la paura della sconfitta, con il grido di battaglia: “Lunga vita ai Brums!” - Peter raccolse tutte le sue forze e si precipitò verso Morell. Gli spettatori hanno visto che metà dell'elmo dello spagnolo giaceva sulla sabbia. Questa volta è stato il turno di Morell di influenzare. Inoltre, ha lasciato cadere lo scudo..."
Ma sebbene i colpi inflitti dalla mano del cavaliere fossero potenti, i cavalieri morirono in battaglia molto meno spesso dei fanti contadini o dei cavalieri leggermente armati. E il punto qui non è solo che i cavalieri erano protetti in modo affidabile dall'armatura.
Ciascuno dei cavalieri vedeva nell'altro cavaliere un avversario uguale a lui, membro della stessa comune confraternita cavalleresca, una casta chiusa per la quale confini e re contavano poco. I confini cambiavano costantemente, le terre passavano da un sovrano all'altro, e i cavalieri possedevano gli stessi castelli e villaggi ed erano tutti considerati fedeli servitori di un'unica santa chiesa cristiana. Non aveva senso uccidere il nemico, tranne nei casi in cui era nemico dei nemici o non voleva arrendersi e chiedeva di finirlo in nome dell'onore cavalleresco. Tuttavia, molto più spesso il cavaliere sconfitto si riconosceva prigioniero, e il vincitore riceveva come riscatto per la sua libertà un cavallo, un'armatura costosa o addirittura terre con villaggi...
I cavalieri usavano “stratagemmi” sul campo di battaglia?
Ma, naturalmente, c'erano battaglie nel Medioevo quando era in gioco il destino di interi paesi, e talvolta il nemico non poteva essere considerato uguale a se stesso - ad esempio, gli "infedeli" durante le crociate per la liberazione del Santo Terra. Quindi i cavalieri erano perfettamente capaci di vari trucchi militari: manovre di fiancheggiamento, falsi attacchi e ritirate che attiravano il nemico.
Nel 1066, il duca Guglielmo di Normandia rivendicò il trono inglese. Ma poiché il re anglosassone Harold non aveva intenzione di rinunciarvi volontariamente, Guglielmo chiamò tutti i cavalieri normanni sotto la sua bandiera. All'esercito riunito si unirono anche molti cavalieri poveri e senza terra provenienti da tutta la Francia, sperando in un ricco bottino. Su navi equipaggiate, William navigò attraverso la Manica e sbarcò nell'Inghilterra sud-orientale vicino alla città di Hastings.
Harold, non supportato dalla maggior parte dei suoi vassalli, riuscì a radunare solo una piccola squadra e una milizia contadina armata di asce da battaglia. Tuttavia, l'esercito cavalleresco normanno, che attaccò il distaccamento di Harold il 14 ottobre 1066, non riuscì a prendere il sopravvento per molto tempo. Gli anglosassoni si fortificarono con successo sul fianco della collina e, uno dopo l'altro, respinsero gli attacchi dei cavalieri con lunghe lance.
Quindi Wilhelm dovette ricorrere a un trucco militare: parte del suo esercito fece una finta fuga. Credendo che la vittoria fosse già nelle sue mani, Harold partì all'inseguimento del nemico, e allo scoperto i ranghi della fanteria anglosassone erano misti. Ne seguì una nuova battaglia, e ora i cavalieri normanni erano completamente padroni della situazione. Harold morì e il suo esercito fuggì. Nel dicembre del 1066 Guglielmo fu incoronato sul trono inglese.
Un'altra battaglia medievale è famosa per la sua abile manovra che assicurò la vittoria. Risale alla Guerra dei Cent'anni e avvenne nel 1370 vicino alla città di Valen. I cavalieri francesi attaccarono improvvisamente l'accampamento inglese, ma il nemico riuscì a formare una formazione di battaglia, e dapprima l'attacco francese fu respinto. Tuttavia, il capo dell'esercito cavalleresco francese, Bertrand Du Guesclin, riuscì a condurre una manovra distraente sul fianco. I ranghi degli inglesi, come a Hastings tre secoli fa, si mescolarono e furono sconfitti, perdendo - un numero enorme per quel tempo - 10.000 soldati, uccisi, feriti e arresi.
Si deve presumere che il cavaliere francese Bertrand Du Guesclin fosse un capo militare capace e abile, poiché una manovra così inaspettata non fu la prima nella sua storia. Sei anni prima, vicino alla città di Cocherel, il suo esercito di cavalieri di diecimila uomini fu attaccato da un grande distaccamento di mercenari inglesi e cavalleria navarrese che agivano in alleanza con loro. Du Guesclin si ritirò, quindi circondò completamente il nemico e lo costrinse ad arrendersi.
Quando le truppe cavalleresche iniziarono a perdere la loro antica importanza?
Allo stesso tempo, nello stesso XIV secolo, l'esercito cavalleresco, ahimè, perse sempre più le sue pretese ad un ruolo primario sul campo di battaglia.
Già nel 1302, la battaglia di Courtrai nelle Fiandre dimostrò quanto potente potesse essere una fanteria ben organizzata e disciplinata. L'esercito francese che invase le Fiandre fu completamente sconfitto dalla milizia popolare, e le perdite tra i cavalieri furono così grandi che dopo la battaglia settecento speroni d'oro furono appesi come trofei nella cattedrale della città di Courtrai. Nella storia, questa battaglia è spesso chiamata la “Battaglia degli Speroni d’Oro”.
E come si è scoperto, la nobiltà inglese, durante la Guerra dei Cent'anni, molto prima dei francesi, si rese conto che per avere successo era necessario non disprezzare la propria fanteria, ma agire con essa, così come con gli arcieri degli archi e balestre, in unità e cooperazione. I francesi non si fidavano affatto della loro milizia. Anche nel pieno della guerra, le autorità a volte proibivano ai cittadini di praticare il tiro con l'arco, e quando una volta i parigini si offrirono volontari per schierare 6mila balestrieri, i cavalieri rifiutarono con arroganza l'aiuto dei "negozianti".
Il 26 agosto 1346 entrò nella storia della Francia come una data nera. Fu allora, nella battaglia di Crecy, che il ruolo principale nelle azioni di un piccolo distaccamento britannico di novemila uomini, comandato dallo stesso re Edoardo III, fu assegnato per la prima volta alla fanteria. L'esercito francese, sotto il comando del re Filippo VI, era composto da dodicimila cavalieri, dodicimila fanti stranieri assoldati, tra cui seimila tiratori di balestra genovesi e cinquantamila cittadini armati debolmente e quasi privi di addestramento militare.
La sconfitta dell'esercito francese si rivelò terribile e allo stesso tempo istruttiva. Gli avversari hanno agito in modi completamente diversi nella battaglia.
Edoardo III, di fronte a tutto il suo distaccamento, schierò una lunga catena di arcieri inglesi, che portarono la loro arte a una perfezione sorprendente ed erano famosi per il fatto che potevano colpire qualsiasi bersaglio da trecento passi.
Dietro i tiratori, i cavalieri mescolati con la fanteria e altri tiratori erano disposti su tre linee di battaglia. I cavalli dei cavalieri smontati rimasero nel convoglio dietro l'esercito.
Quando Filippo mosse il suo esercito contro gli inglesi, obbedì in modo molto ostile, le ultime file stavano per partire e quelle del fronte erano già lontane. Ma quando i francesi si avvicinarono abbastanza agli inglesi, Filippo decise improvvisamente di posticipare la battaglia e dare ai distaccamenti sparsi l'opportunità di unirsi e riposare durante la notte.
Tuttavia, i cavalieri francesi, trascinati dalla sete di battaglia, continuarono ad avanzare, senza alcun ordine, sorpassandosi e respingendosi a vicenda. Alla fine si avvicinarono agli inglesi. Sembrava loro la più grande vergogna per il loro onore ritardare la battaglia, e ormai il re stesso aveva già dimenticato la sua prima prudente decisione e diede l'ordine di attaccare.
Secondo la disposizione precedentemente prevista, i fucilieri genovesi avrebbero dovuto avanzare, e le file dei francesi si aprirono per lasciar loro il posto. Tuttavia, i mercenari si mossero senza molto desiderio. Erano già stanchi dalla marcia, e i loro scudi rimasero nei carri ritardati, perché, secondo il primo ordine reale, prevedevano di combattere solo il giorno successivo.
I capi dei mercenari maledissero ad alta voce il nuovo ordine. Sentendo ciò, il conte d'Alençon disse con arroganza, come riferiscono i cronisti: "Questo è tutto il vantaggio di questa bastarda, è buona solo da mangiare, e per noi sarà più un ostacolo che un aiuto".
I genovesi, però, si avvicinarono agli inglesi e lanciarono per tre volte il loro selvaggio grido di guerra, sperando di terrorizzarli. Ma in risposta, iniziarono con calma a sparare omicida dai loro archi.
Lunghe frecce piumate colpirono i genovesi prima che avessero il tempo di tirare le corde delle loro balestre. Gli archi inglesi erano così potenti che le frecce trapassavano le armature dei mercenari.
Quando finalmente i genovesi fuggirono, gli stessi cavalieri francesi iniziarono a calpestarli con i loro cavalli da guerra: i mercenari impedirono loro di precipitarsi all'attacco. Tutte le formazioni militari erano crollate, e ora gli arcieri inglesi sparavano non solo ai genovesi, ma anche ai cavalieri, e cercavano soprattutto di colpire i cavalli.
Ben presto davanti alle file degli inglesi rimase solo una massa informe di cavalieri e mercenari morti distesi sotto i cavalli caduti. Fu allora che la fanteria inglese si precipitò sul campo di battaglia, finendo con calma gli sconfitti. Il resto dell'esercito francese fuggì in disordine.
Le perdite francesi furono orribili. Sul campo di battaglia rimasero 11 duchi e conti, rappresentanti della più alta nobiltà del regno, 1.500 cavalieri con titoli più semplici e 10.000 fanti.
La Guerra dei Cent'anni: il declino della cavalleria
E più di una volta durante la Guerra dei Cent'anni, la parte inglese ha mostrato ai francesi cosa significano disciplina, tattica ponderata e unità di azione sul campo di battaglia. Il 19 settembre 1356 il cavalierato francese subì un'altra terribile sconfitta nella battaglia di Poitiers.
Un distaccamento inglese di seimila persone, comandato dal figlio maggiore di Edoardo 111, soprannominato il Principe Nero per il colore della sua armatura, occupò una posizione molto vantaggiosa nelle vicinanze di Poitiers dietro siepi e vigneti in cui erano nascosti gli arcieri. I cavalieri francesi si mossero per attaccare lungo uno stretto passaggio tra le siepi, ma una grandine di frecce cadde su di loro, e poi i cavalieri inglesi colpirono i cavalieri francesi rannicchiati in una folla disordinata. Morirono circa cinquemila soldati, senza contare l'enorme numero di prigionieri. Anche il re Giovanni II, che a quel tempo aveva sostituito Filippo VI sul trono di Francia, si arrese alla mercé del vincitore.
L'esercito francese era quasi cinque volte più numeroso del nemico, ma questa volta gli arcieri inglesi si nascondevano dietro una palizzata appositamente costruita, che impediva l'avanzata dei cavalieri pesantemente armati. Ad Agincourt, i francesi persero seimila morti, tra cui i duchi di Brabante e Bretone, e furono catturati altri duemila cavalieri, compreso il parente più stretto del re, il duca d'Orleans.
Eppure, alla fine, i francesi furono i vincitori della Guerra dei Cent'anni, conquistando vasti territori del regno che gli inglesi possedevano da molti anni. Avendo imparato la lezione insegnata, la Francia si affidò nella guerra contro gli invasori non tanto alla cavalleria quanto all'intero popolo; Non senza motivo i maggiori successi nella guerra furono associati a una semplice ragazza del villaggio di nome Giovanna d'Arco. Il tempo cambiò inesorabilmente e la cavalleria lasciò il palcoscenico storico, dove per tanto tempo aveva ricoperto i ruoli principali, cedendo il posto ad altre forze.
La Guerra dei Cent'anni: il declino della cavalleria
E più di una volta durante la Guerra dei Cent'anni, la parte inglese ha mostrato ai francesi cosa significano disciplina, tattica ponderata e unità di azione sul campo di battaglia. Il 19 settembre 1356 il cavalierato francese subì un'altra terribile sconfitta nella battaglia di Poitiers.
Un distaccamento inglese di seimila persone, comandato dal figlio maggiore di Edoardo 111, soprannominato il Principe Nero per il colore della sua armatura, occupò una posizione molto vantaggiosa nelle vicinanze di Poitiers dietro siepi e vigneti in cui erano nascosti gli arcieri. I cavalieri francesi si mossero per attaccare lungo uno stretto passaggio tra le siepi, ma una grandine di frecce cadde su di loro, e poi i cavalieri inglesi colpirono i cavalieri francesi rannicchiati in una folla disordinata. Morirono circa cinquemila soldati, senza contare l'enorme numero di prigionieri. Anche il re Giovanni II, che a quel tempo aveva sostituito Filippo VI sul trono di Francia, si arrese alla mercé del vincitore.
L'esercito francese era quasi cinque volte più numeroso del nemico, ma questa volta gli arcieri inglesi si nascondevano dietro una palizzata appositamente costruita, che impediva l'avanzata dei cavalieri pesantemente armati. Ad Agincourt, i francesi persero seimila morti, tra cui i duchi di Brabante e Bretone, e furono catturati altri duemila cavalieri, compreso il parente più stretto del re, il duca d'Orleans.
Eppure, alla fine, i francesi furono i vincitori della Guerra dei Cent'anni, conquistando vasti territori del regno che gli inglesi possedevano da molti anni. Avendo imparato la lezione insegnata, la Francia si affidò nella guerra contro gli invasori non tanto alla cavalleria quanto all'intero popolo; Non senza motivo i maggiori successi nella guerra furono associati a una semplice ragazza del villaggio di nome Giovanna d'Arco. Il tempo cambiò inesorabilmente e la cavalleria lasciò il palcoscenico storico, dove per tanto tempo aveva ricoperto i ruoli principali, cedendo il posto ad altre forze.
Cavalieri Malov Vladimir Igorevich
La Guerra dei Cent'anni: il declino della cavalleria
E più di una volta durante la Guerra dei Cent'anni, la parte inglese ha mostrato ai francesi cosa significano disciplina, tattica ponderata e unità di azione sul campo di battaglia. Il 19 settembre 1356 il cavalierato francese subì un'altra terribile sconfitta nella battaglia di Poitiers.
Un distaccamento inglese di seimila persone, comandato dal figlio maggiore di Edoardo 111, soprannominato il Principe Nero per il colore della sua armatura, occupò una posizione molto vantaggiosa nelle vicinanze di Poitiers dietro siepi e vigneti in cui erano nascosti gli arcieri. I cavalieri francesi si mossero per attaccare lungo uno stretto passaggio tra le siepi, ma una grandine di frecce cadde su di loro, e poi i cavalieri inglesi colpirono i cavalieri francesi rannicchiati in una folla disordinata. Morirono circa cinquemila soldati, senza contare l'enorme numero di prigionieri. Anche il re Giovanni II, che a quel tempo aveva sostituito Filippo VI sul trono di Francia, si arrese alla mercé del vincitore.
L'esercito francese era quasi cinque volte più numeroso del nemico, ma questa volta gli arcieri inglesi si nascondevano dietro una palizzata appositamente costruita, che impediva l'avanzata dei cavalieri pesantemente armati. Ad Agincourt, i francesi persero seimila morti, tra cui i duchi di Brabante e Bretone, e furono catturati altri duemila cavalieri, compreso il parente più stretto del re, il duca d'Orleans.
Eppure, alla fine, i francesi furono i vincitori della Guerra dei Cent'anni, conquistando vasti territori del regno che gli inglesi possedevano da molti anni. Avendo imparato la lezione insegnata, la Francia si affidò nella guerra contro gli invasori non tanto alla cavalleria quanto all'intero popolo; Non senza motivo i maggiori successi nella guerra furono associati a una semplice ragazza del villaggio di nome Giovanna d'Arco. Il tempo cambiò inesorabilmente e la cavalleria lasciò il palcoscenico storico, dove per tanto tempo aveva ricoperto i ruoli principali, cedendo il posto ad altre forze.
Dal libro Cavalieri autore Malov Vladimir Igorevich Dal libro Grande Enciclopedia Sovietica (ST) dell'autore TSBIl periodo di massimo splendore della cavalleria Ci furono, tuttavia, tempi completamente diversi per la cavalleria: una fioritura di ideali senza precedenti, una stretta aderenza al codice d'onore cavalleresco, il culto dell'amore disinteressato e l'adorazione della Bella Signora. E ovviamente c'erano delle ragioni per questo. I primi tra loro lo sono
Dal libro 100 Grandi Guerre autore Sokolov Boris Vadimovič Dal libro L'enciclopedia completa delle nostre idee sbagliate autoreCome erano le armi cavalleresche agli albori della cavalleria? I guerrieri romani usavano come arma offensiva una spada a doppio taglio larga da 3 a 5 centimetri e lunga da 50 a 70 centimetri. Il bordo a forma di cono della spada era ben affilato; un'arma del genere poteva farlo
Dal libro Cavalieri autore Malov Vladimir IgorevichLa Guerra dei Cent'anni - il declino della cavalleria E più di una volta durante la Guerra dei Cent'anni, la parte inglese mostrò ai francesi cosa significano disciplina, tattica ponderata e unità di azione sul campo di battaglia. Il 19 settembre 1356 il cavalierato francese subì un'altra terribile sconfitta
Dal libro The Complete Illustrated Encyclopedia of Our Misconceptions [con illustrazioni] autore Mazurkevich Sergei Alexandrovich Dal libro The Complete Illustrated Encyclopedia of Our Misconceptions [con immagini trasparenti] autore Mazurkevich Sergei Alexandrovich Dal libro Tutto su Parigi autore Belochkina Yulia Vadimovna Dal libro Vecchia Cracovia autore Frolova Natalya GennadievnaTradizioni cavalleresche Come diventavano cavalieri... Il giovane scudiero trascorse la notte nel tempio. Qui, sotto gli archi oscuri, in completo silenzio, si inginocchiò presso uno degli altari, dove le candele tremolavano davanti all'immagine di San Giorgio il Vittorioso, patrono della cavalleria. Le luci delle candele sono fioche
Dal libro 200 avvelenamenti famosi autore Antsyshkin IgorIl periodo di massimo splendore della cavalleria Ci furono, tuttavia, tempi completamente diversi per la cavalleria: una fioritura di ideali senza precedenti, una stretta aderenza al codice d'onore cavalleresco, il culto dell'amore disinteressato e l'adorazione della Bella Signora. E naturalmente c'erano delle ragioni per questo, la prima tra queste era
Dal libro dell'autoreIl declino della cavalleria L'era del culto della Bella Signora, le celebrazioni continue, i tornei, la poesia, la santa osservanza di tutti i comandamenti dell'onore: questo è il periodo di massimo splendore della cavalleria. Ahimè, se c’è stata una fioritura, ci deve essere anche un declino. In realtà arrivò al cavalierato già alla fine del XIII secolo.
Dal libro dell'autoreLa Guerra dei Cent'anni Se chiedi a qualcuno quanti anni è durata la Guerra dei Cent'anni, molto probabilmente ti risponderà: “Cent'anni. Ciò è evidente dal suo nome." Tuttavia, questa risposta è sbagliata. La Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia durò 115 anni, dal 1338 al 1453. A proposito, questa guerra
Dal libro dell'autoreLa Guerra dei Cent'anni Se chiedi a qualcuno quanti anni è durata la Guerra dei Cent'anni, molto probabilmente ti risponderà: “Cent'anni. Ciò è evidente dal suo nome." Tuttavia, questa risposta è sbagliata. La Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia durò 115 anni, dal 1338 al 1453. A proposito, questa guerra
Dal libro dell'autoreIl miglioramento di Parigi sotto Carlo V. La Guerra dei Cent'anni Il cambiamento nella vita della città nel XIV secolo e all'inizio del XV secolo si riflette nel suo aspetto. Verso la metà del XIV secolo sorse la necessità di costruire una nuova cinta muraria. Una caratteristica distintiva delle strutture protettive aggiuntive del nuovo
Dal libro dell'autoreIl declino dell'impero del Wawel visto dall'alto Come altrove in Europa, il Rinascimento polacco fu un'epoca di fioritura culturale, che si ripercosse sia a Wawel che a Cracovia nel suo complesso. Questo fu il momento in cui le persone furono finalmente in grado di liberarsi dall'oscurità del Medioevo, e i più coraggiosi e
Dal libro dell'autoreIL DECLINO DELL'HELLAS E IL VELENO Durante il periodo del declino dell'Hellas, causato dalle guerre intestine, morì di veleno anche il famoso comandante greco Filopemene di Megalopoli. Alla guida degli Achei in battaglia, non perse una sola battaglia. I suoi successi contribuirono a rafforzare e indebolire la Lega achea