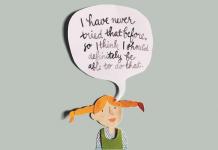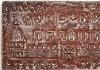I lisosomi sono organelli di membrana con un diametro compreso tra 0,2 e 2,0 µm. Fanno parte della cellula eucariotica, dove si trovano centinaia di lisosomi. Il loro compito principale è la digestione intracellulare (decomposizione dei biopolimeri), per questo gli organelli hanno un insieme speciale di enzimi idrolitici (oggi se ne conoscono circa 60 tipi). Le sostanze enzimatiche sono circondate da una membrana chiusa che ne impedisce la penetrazione nella cellula e la sua distruzione.
Il primo a identificare i lisosomi e a iniziare a studiarli fu lo scienziato belga nel campo della biochimica Christian de Duve nel 1955.
Caratteristiche della struttura dei lisosomi
I lisosomi sembrano sacche di membrana con contenuto acido. La configurazione è ovale o rotonda. Tutte le cellule del corpo contengono lisosomi, ad eccezione dei globuli rossi.
Una differenza speciale tra i lisosomi e altri organelli è la presenza di idrolasi acide nell'ambiente interno. Garantiscono la scomposizione delle sostanze proteiche, dei grassi, dei carboidrati e degli acidi nucleici.
Gli enzimi lisosomiali includono fosfatasi (enzima marcatore), solfatasi, fosfolipasi e molti altri. L'ambiente ottimale per il normale funzionamento degli organelli è acido (pH = 4,5 - 5). Se gli enzimi sono insufficienti o la loro attività è inefficace, oppure l'ambiente interno è alcalinizzato, possono verificarsi malattie da accumulo lisosomiale (glicogenosi, mucopolisaccaridosi, malattia di Gaucher, malattia di Tay-Sachs). Di conseguenza, nella cellula si accumulano sostanze non digerite: glicoproteine, lipidi, ecc.
La membrana a membrana singola dei lisosomi è dotata di proteine di trasporto che assicurano il trasferimento dei prodotti della digestione dall'organello all'ambiente interno della cellula.

Ci sono lisosomi in una cellula vegetale?
NO. Le cellule vegetali contengono vacuoli - formazioni piene di succo e racchiuse in una membrana. Sono formati da provacuoli che si allontanano dall'EPS e. I vacuoli cellulari svolgono una serie di funzioni importanti: accumulo di nutrienti, mantenimento del turgore, digestione delle sostanze organiche (che indica somiglianze tra vacuoli vegetali e lisosomi).
Dove si formano i lisosomi?
La formazione dei lisosomi avviene da vescicole che gemmano dall'apparato del Golgi. La formazione degli organelli richiede anche la partecipazione della membrana granulare del reticolo endoplasmatico. Tutti gli enzimi lisosomiali vengono sintetizzati dai ribosomi ER e poi inviati all'apparato del Golgi.
Tipi di lisosomi
Esistono due tipi di lisosomi. Lisosomi primari si formano vicino all'apparato del Golgi e contengono enzimi non attivati.
Lisosomi secondari, oppure i fagosomi hanno enzimi attivati che interagiscono direttamente con i biopolimeri scomposti. Di norma, gli enzimi lisosomiali vengono attivati quando il pH cambia verso il lato acido.
I lisosomi si dividono inoltre in:
- eterolisosomi- sostanze digestive catturate dalla cellula mediante fagocitosi (particelle solide) o pinocitosi (assorbimento di liquidi);
- autolisosomi- progettati per distruggere le proprie strutture intracellulari.
Funzioni dei lisosomi nella cellula
- Digestione intracellulare;
- autofagocitosi;
- autolisi
Digestione intracellulare I composti nutritivi o gli agenti estranei (batteri, virus, ecc.) che entrano nella cellula durante l'endocitosi vengono effettuati sotto l'azione degli enzimi lisosomiali.
Dopo la digestione del materiale catturato, i prodotti di decomposizione entrano nel citoplasma, le particelle non digerite rimangono all'interno dell'organello, che ora viene chiamato - corpo residuo. In condizioni normali, i corpi lasciano la cellula. Nelle cellule nervose che hanno un lungo ciclo di vita, durante il periodo della loro esistenza si accumulano molti corpi residui, che contengono il pigmento dell'invecchiamento (inoltre non vengono escreti durante lo sviluppo della patologia).
Autofagocitosi- scissione delle strutture cellulari che non sono più necessarie, ad esempio durante la formazione di nuovi organelli; la cellula si libera di quelli vecchi mediante autofagocitosi.
Autolisi- autodistruzione della cellula, che porta alla sua distruzione. Questo processo non è sempre di natura patologica, ma avviene in normali condizioni di sviluppo dell'individuo o durante la differenziazione delle singole cellule.
Ad esempio: la morte cellulare è un processo naturale per un organismo normalmente funzionante, quindi esiste una morte cellulare programmata: l'apoptosi. Il ruolo dei lisosomi nell'apoptosi è piuttosto ampio: gli enzimi idrolitici digeriscono le cellule morte e purificano il corpo da quelle che hanno già adempiuto alla loro funzione.
Quando un girino si trasforma in un individuo maturo, i lisosomi situati nelle cellule della parte della coda lo scompongono, di conseguenza la coda scompare e i prodotti della digestione vengono assorbiti dal resto delle cellule del corpo.
Tabella riassuntiva della struttura e delle funzioni dei lisosomi
| Struttura e funzioni dei lisosomi | |
|---|---|
| Fasi | Funzioni |
| Endosoma precoce | Formato per endocitosi di materiale extracellulare. Dall'endosoma, i recettori che hanno trasferito il loro carico (a causa del basso pH) tornano al guscio esterno. |
| Endosoma tardivo | Dall'endosoma precoce, le sacche con particelle assorbite durante la pinocitosi e le vescicole del complesso lamellare con enzimi acidi passano nella cavità dell'endosoma tardivo. |
| Lisosoma | Le vescicole dell'endosoma tardivo passano al lisosoma e contengono enzimi idrolazzanti e sostanze per la digestione. |
| Fagosoma | Progettato per scomporre le particelle di grandi dimensioni catturate dalla fagocitosi. I fagosomi si combinano quindi con un lisosoma per un'ulteriore digestione. |
| Autofagosoma | La regione citoplasmatica è circondata da una doppia membrana e si forma durante la macroautofagia. Quindi si collega al lisosoma. |
| Corpi multivescicolari | Formazioni a membrana singola contenenti diverse piccole sacche di membrana. Si formano durante la microautofagocitosi e digeriscono il materiale ricevuto dall'esterno. |
| Telolisosomi | Bolle che accumulano sostanze non digerite (il più delle volte lipofuscina). Nelle cellule sane si collegano alla membrana esterna e lasciano la cellula con l'aiuto dell'esocitosi. |
Lisosomi
- organelli cellulari formati da un unico doppio strato di membrana. I complessi ligando-recettore vengono distrutti nei lisosomi
metabolismo del colesterolo
le idrolasi distruggono proteine, lipidi, carboidrati, acidi nucleici
All'interno dei lisosomi viene mantenuto un pH costante = 5, fornito da una pompa ATP-dipendente, che, attraverso l'antiporto Na
+
e H
+
pompe H
+
all'interno del lisosoma. Il pH è mantenuto anche dai canali ionici Cl
Enzimi lisosomiali: ribonucleasi, desossiribonucleasi, fosfatasi, glicosidasi, arilsolfatasi (esteri organici dell'acido solforico), collagenasi, catepsine
Struttura dell'enzima lisosomiale D catepsina con zucchero attaccato incluso mannosio: PDB = 1LYA.
lgpA lgpB gruppo di proteine integrali 100-120 kDa, altamente glicosilate. La glicosilazione delle proteine dell'automembrana impedisce l'autodigestione.
Le proteine lisosomiali vengono sintetizzate nel RE, passando attraverso la rete trans-AG, formando endosomi che si fondono
d=0,2-2μm. degradazione dei componenti cellulari, ~40 idrolasi (nucleasi, proteinasi, glicosidasi, lipasi, fosfatasi, solfatasi, fosfolipasi) con un pH ottimale ~4,5-5 (nel citoplasma ~7-7,3) - pompe protoniche - protezione contro la degradazione cellulare
le proteine formate nel SER sono glicosilate in AG, i residui terminali di mannosio (Man) sono fosforilati in C-6, formando un residuo terminale -
mannosio 6-fosfato
(Uomo-6-P). I recettori AG riconoscono Man-6-P, si verifica un accumulo locale di proteine nell'AG -
clatrina
– taglia e trasporta frammenti di membrana adatti come parte delle vescicole di trasporto agli endolisosomi. Negli endolisosomi il pH viene abbassato dalle pompe protoniche (H
+
-ATP-asi). Le proteine si dissociano dai recettori e il gruppo fosfato viene rimosso da Man-6-P. I recettori Man-6-P vengono utilizzati una seconda volta dopo il riciclaggio: vengono trasferiti in AG.
contiene trans-Golgi
recettore del mannosio 6-fosfato legante il mannosio fosforilato degli enzimi lisosomiali,
dirigere gli enzimi verso la vescicola di trasporto.
Lisosomi primari.
Autofagia
– cattura degli organelli =
lisosomi secondari
– processo di scissione idrolitica |
corpi residui.
Eterocitosi
– fusione del lisosoma con gli endosomi dell'endo- e della fagocitosi.
Gli elementi di membrana dei lisosomi sono protetti dall'azione delle idrolasi acide da regioni oligosaccaridiche che non sono riconosciute dagli enzimi o che impediscono alle idrolasi di interagire con essi.
D-aminoacido ossidasi
– ossida gli amminoacidi D in chetoacidi.
Distruzione delle proteine nei lisosomi.
Le proteine citoplasmatiche possono essere degradate nei proteasomi (vedi recensione
Proteasomi
) o nei lisosomi. Le proteine degradate hanno un sito specifico riconosciuto dagli chaperoni, che si legano alla proteina e la trasportano ai recettori sulla membrana del lisosoma. La proteina viene dipanata dagli accompagnatori ed entra in un canale che conduce al lisosoma, all'altra estremità del quale una proteasi taglia la proteina in piccoli frammenti. L'attività di questa via è marcatamente ridotta nei fibroblasti e nelle cellule epatiche dei ratti anziani. Questa riduzione favorisce l’accumulo di proteine non necessarie, interrompendo vari processi cellulari.
Autofagia
Durante l'inedia prolungata, la cellula assorbe energia e i componenti necessari alla sua sopravvivenza distruggendo alcuni organelli. I lisosomi sono coinvolti nella distruzione degli organelli.
Organelli formati da lisosomi
In alcune cellule differenziate, i lisosomi possono svolgere funzioni specifiche, formando ulteriori organelli. Tutto
funzioni aggiuntive sono associate alla secrezione di sostanze.
| organelli | cellule | funzioni |
| melanosomi | melanociti, retinale epitelio pigmentato |
formazione, immagazzinamento e trasporto della melanina |
| granuli piastrinici | piastrine, megacariociti | necessario il rilascio di ATP, ADP, serotonina e calcio per la coagulazione del sangue |
| corpi lamellari | epitelio polmonare di tipo II | stoccaggio e secrezione del tensioattivo necessario per il lavoro polmoni |
| granuli di lisi | citotossico T linfociti, cellule NK |
distruzione di cellule infettate da un virus o da un tumore |
| MCG classe II | cellule presentate con l'antigene (dendritiche cellule, linfociti B, macrofagi, ecc.) |
Cambiamento e presentazione degli antigeni per i linfociti T CD4+ per la regolazione immunitaria |
| granuli basofili | basofili, mastociti | innescare il rilascio di istamine e altri agenti infiammatori incentivi |
| granuli azzurrofili | neutrofili, eosinofili | rilasciare agenti microbicidi e infiammatori |
| granuli di osteoclasti | osteoclasti | distruzione ossea |
| Corpi di Weibel-Pallade | cellule endoteliali | maturazione e rilascio regolato del fattore von Willebrand nel sangue |
| granuli α piastrinici | Piastrine, megacariociti | rilascio di fibrinogeno e fattore di von Willebrandt per l'adesione piastrine e coagulazione del sangue |
Malattie associate ai lisosomi
malattia di Tay-Sachs
sindrome di Chediak-Higashi
Sindrome di Hermansky-Pudlak
Sindrome di Griscelli
Abbreviazioni.
ER - reticolo endoplasmatico
AG - Apparato del Golgi
Gli enzimi lisosomiali, come tutte le proteine in generale, sono sintetizzati nei ribosomi situati nelle membrane ripiegate del reticolo endoplasmatico (vedi figura sotto).
Gli enzimi lisosomiali (punti neri), come tutti gli enzimi in generale, sono sintetizzati nei ribosomi della rete endoplasmatica; quindi, nelle immediate vicinanze dell'apparato di Golgi, vengono confezionati in piccole sacche: granuli genitoriali immaturi. Questi granuli si sviluppano in lisosomi primari e talvolta rilasciano il loro contenuto nell'ambiente extracellulare. Ma nella maggior parte dei casi, gli enzimi vengono immagazzinati per la digestione intracellulare. Le particelle estranee entrano nella cellula a seguito della cosiddetta endocitosi (a sinistra). Una volta entrati nella cellula, si ritrovano all'interno dei fagosomi, vescicole delimitate da una membrana. I lisosomi primari si fondono con i fagosomi, gli enzimi digestivi entrano nei fagosomi e, di conseguenza, si formano i lisosomi secondari. Le particelle vengono digerite e il materiale non digerito rimane all'interno di corpi residui, che rimangono nella cellula per qualche tempo o si fondono con la membrana cellulare, quindi il loro contenuto viene rilasciato nell'ambiente extracellulare.
In prossimità dei gruppi di vescicole che formano il cosiddetto apparato di Golgi, gli enzimi lisosomiali sono impacchettati in organelli circondati da un'unica membrana lipoproteica. Questi granuli originari si sviluppano in lisosomi primari, nei quali gli enzimi, sebbene in forma inattiva, sono pronti per l'uso in qualsiasi momento.
Non appena furono identificati i lisosomi, si scoprì quasi immediatamente che molte particelle citoplasmatiche già familiari ai biologi, di aspetto piuttosto diverso, appartenevano anche ai lisosomi. Forse i lisosomi più tipici sono i caratteristici granuli che si trovano costantemente nel citoplasma dei leucociti. Ma in tutte le altre cellule di origine animale studiate finora, ad eccezione degli eritrociti, sono presenti organelli contenenti enzimi idrolitici e, quindi, appartenenti alla categoria dei lisosomi. Organelli simili si trovano nelle piante, inclusi funghi e lieviti.
I batteri non hanno lisosomi nella forma in cui si trovano negli organismi superiori, ma con l'aiuto di alcuni metodi è possibile isolare da essi enzimi idrolitici con proprietà simili a quelle dei lisosomi. In altre parole, la presenza di enzimi litici (cioè digestivi), solitamente racchiusi in membrane, ma capaci di essere rilasciati nell'ambiente esterno sotto determinate influenze, sembra essere una delle caratteristiche più comuni degli organismi viventi.
"Molecole e cellule", ed. acad. G. M. Frank
Prevalenza tra i regni viventi
I lisosomi furono descritti per la prima volta nel 1955 da Christian de Duve nelle cellule animali e successivamente furono scoperti nelle cellule vegetali. Nelle piante, i vacuoli sono simili ai lisosomi nel metodo di formazione e in parte nella funzione. I lisosomi sono presenti anche nella maggior parte dei protisti (sia con alimentazione fagotrofica che osmotrofica) e nei funghi. Pertanto, la presenza di lisosomi è caratteristica delle cellule di tutti gli eucarioti. I procarioti non hanno lisosomi perché mancano di fagocitosi e non hanno digestione intracellulare.
Segni di lisosomi
Una delle caratteristiche dei lisosomi è la presenza in essi di numerosi enzimi (idrolasi acide) in grado di scomporre proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici. Gli enzimi lisosomiali includono catepsine (proteasi tissutali), ribonucleasi acida, fosfolipasi, ecc. Inoltre, i lisosomi contengono enzimi in grado di rimuovere gruppi solfato (solfatasi) o fosfato (fosfatasi acida) da molecole organiche.
Guarda anche
Collegamenti
- Biologia Molecolare Della Cellula, 4a edizione, 2002 - libro di testo sulla biologia molecolare in inglese