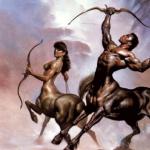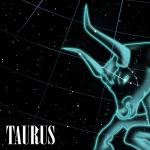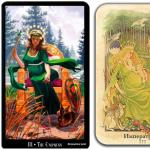Mosca
Standartinformare
3. APPROVATO E INTRODOTTO CON Ordine agenzia federale sulla regolamentazione tecnica e metrologica del 26 ottobre 2005 n. 264-st
4. La presente norma attua le disposizioni di legge Federazione Russa"Sulla garanzia dell'uniformità delle misurazioni" e la legge della Federazione Russa "Sulla regolamentazione tecnica"
5. INTRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA
Le informazioni sulle modifiche a questo standard sono pubblicate nell'indice informativo pubblicato annualmente "Norme nazionali" e il testo delle modifiche e degli emendamenti - in cartelli informativi pubblicati mensilmente "Norme nazionali". In caso di revisione (sostituzione) o annullamento della presente norma, verrà pubblicato un avviso corrispondente nell'indice informativo pubblicato mensilmente "Norme nazionali". Le informazioni, le notifiche ei testi rilevanti sono anche inseriti nel sistema informativo uso comune- sul sito web ufficiale dell'organismo nazionale della Federazione Russa per la standardizzazione su Internet
|
1 area di utilizzo. 2 3. Termini e definizioni. 3 4. Disposizioni generali. 5 5. Sviluppo di un metodo per l'analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. 5 6. Certificazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. 7 Appendice A. Norme per la presentazione degli indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. otto Appendice B. Concetti di base e rappresentazione dell'incertezza. 9 Appendice B. Metodi per valutare gli indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. dieci Appendice D. Costruzione, contenuto e presentazione di documenti che regolano i metodi di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. 12 Appendice E. Esempi di progettazione di sezioni di documenti che regolano i metodi di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. quattordici Appendice E. Contenuto del lavoro nel corso di studi metrologici e certificazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. 17 Appendice G. Modulo di certificato di attestazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua. diciotto Bibliografia. 19 |
GOST R 8.613-2005
STANDARD NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
|
Sistema statale garantire l'uniformità delle misurazioni TECNICHE PER L'ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA DI CAMPIONI DI ACQUA Requisiti generali allo sviluppo Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. |
Data di introduzione - 01-07-2006
1 area di utilizzo
La presente norma si applica ai metodi di nuova concezione e riveduti per l'analisi chimica quantitativa di campioni di acque reflue naturali, potabili (di seguito denominata MCCA dei campioni d'acqua) e stabilisce i requisiti generali per il loro sviluppo e certificazione.
2. Riferimenti normativi
Questo standard utilizza referenze normative ai seguenti standard:
GOST R 1.5-2004 Standardizzazione nella Federazione Russa. Standard nazionali della Federazione Russa. Regole per la costruzione, presentazione, progettazione e designazione
GOST R 8.563-96 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Tecniche di misurazione
GOST R ISO 5725-1-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 1. Disposizioni e definizioni di base
GOST R ISO 5725-2-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 2: Metodo di base per determinare la ripetibilità e la riproducibilità metodo standard misurazioni
GOST R ISO 5725-3-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 3. Valori di precisione intermedi del metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-4-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi e dei risultati di misurazione. Parte 4: Metodi di base per determinare la validità di un metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-5-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 5 Metodi alternativi determinare la precisione di un metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-6-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 6. Utilizzo pratico dei valori di precisione
GOST 1.2-97 Sistema di standardizzazione interstatale. Standard interstatali, regole e raccomandazioni per la standardizzazione interstatale. L'ordine di sviluppo, adozione, applicazione, aggiornamento e cancellazione
GOST 8.315-97 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Campioni di riferimento composizione e proprietà di sostanze e materiali. Disposizioni di base
GOST 8.417-2002 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Unità
GOST 27384-2002 Acqua. Standard di errore di misura degli indicatori di composizione e proprietà
Nota - Quando si utilizza questo standard, è consigliabile verificare la validità degli standard di riferimento nel sistema informativo pubblico - sul sito Web ufficiale dell'organismo nazionale della Federazione Russa per la standardizzazione su Internet o secondo l'indice informativo pubblicato annualmente "National Standards", che è stato pubblicato a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso, e secondo i corrispondenti segnali informativi pubblicati mensilmente pubblicati nell'anno in corso. Se lo standard di riferimento viene sostituito (modificato), quando si utilizza questo standard, è necessario essere guidati dallo standard sostituito (modificato). Se la norma richiamata viene cancellata senza sostituzione, la disposizione in cui si fa riferimento ad essa si applica nella misura in cui tale riferimento non sia pregiudicato.
3. Termini e definizioni
Nella presente norma vengono utilizzati i seguenti termini con le rispettive definizioni:
3.7. analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua: Determinazione quantitativa sperimentale del contenuto di uno o più componenti della composizione di un campione d'acqua mediante metodi chimici, fisico-chimici, fisici (tenendo conto delle raccomandazioni).
3.8. risultato di una singola analisi (determinazione): Il valore del contenuto di un componente in un campione d'acqua, ottenuto durante una singola implementazione della procedura di analisi.
3.9. risultato dell'analisi (misurazione): medio valore aritmetico o la mediana dei risultati di una singola analisi (determinazione) (tenendo conto delle raccomandazioni).
3.10. metodo di analisi chimica quantitativa di campioni di acque reflue naturali, potabili, fognarie, trattate; MKCA di campioni d'acqua: una serie di operazioni e regole, la cui attuazione fornisce i risultati di un'analisi chimica quantitativa di campioni di acque reflue naturali, potabili, fognarie, trattate con caratteristiche di errore stabilite (incertezza) (tenendo conto delle raccomandazioni).
Nota: l'MCCA dei campioni d'acqua è un tipo di tecnica di misurazione.
3.11. indicatori di qualità dei campioni d'acqua MKCA: Indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) del MKCA dei campioni d'acqua.
3.12. indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) di MKCA di campioni d'acqua: Caratteristiche assegnate dell'errore (i suoi componenti) dell'MCCA dei campioni d'acqua (tenendo conto delle raccomandazioni).
3.13. caratteristiche assegnate dell'errore MKCA dei campioni d'acqua e le caratteristiche dell'errore dei suoi componenti: Le caratteristiche stabilite dell'errore e delle sue componenti per la totalità dei risultati dell'analisi ottenuti in conformità con i requisiti e le regole dei campioni d'acqua certificati ICCA (tenendo conto delle raccomandazioni).
Nota - Le caratteristiche di errore assegnate caratterizzano l'accuratezza garantita dell'MCA dei campioni d'acqua.
3.14. incertezza di misura: Un parametro associato a un risultato di misurazione che caratterizza la diffusione dei valori attribuibili al misurando.
NOTA L'incertezza è l'equivalente di una caratteristica di errore assegnata. In questo caso, l'equivalente dell'incertezza estesa è la stima dell'intervallo della caratteristica di errore assegnata, l'equivalente dell'incertezza tipo è la stima puntuale della caratteristica di errore assegnata [vedi. Tabella A.1 (Appendice A) e Appendice B].
3.15. intervallo di contenuto (intervallo di misurazione): L'intervallo del contenuto dell'indicatore di un campione d'acqua, previsto dall'ICCA dei campioni d'acqua.
3.16. Ambito dei campioni d'acqua MKCA: L'intervallo di contenuti e gli intervalli di valori consentiti dei fattori di influenza dei campioni d'acqua e MCCA dei campioni d'acqua.
3.17. fattori di influenza del campione d'acqua: Componenti interferenti e altre proprietà (fattori) del campione che influiscono sul risultato e sull'errore (incertezza) delle misurazioni.
3.18. fattori che influenzano l'MCCA dei campioni d'acqua: Fattori, i cui valori determinano le condizioni per l'analisi dei campioni d'acqua secondo l'ICCA e che influenzano il risultato e l'errore (incertezza) delle misurazioni.
4. Disposizioni generali
4.1. L'MCCA dei campioni d'acqua è sviluppato e utilizzato per garantire l'esecuzione delle misurazioni con un errore (incertezza) che non supera la norma dell'errore di misurazione per gli indicatori della composizione e delle proprietà dell'acqua, stabilita da GOST 27384.
4.2. L'ICCA dei campioni d'acqua è contenuta nei seguenti documenti:
Standard nazionali della Federazione Russa;
Standard delle organizzazioni (imprese).
4.3. Vengono utilizzati campioni d'acqua MKCA:
Organi controllo statale per l'inquinamento e lo stato dell'ambiente naturale;
Organismi di vigilanza sanitaria statale;
Organi Servizio pubblico monitorare il livello di inquinamento ambientale;
Organizzazioni, singole imprese o gruppi di imprese (legati al settore, dipartimento o associazione di persone giuridiche) per valutare la qualità e (o) l'inquinamento delle acque.
4.4. Gli standard per MCCA di campioni d'acqua (di seguito denominati documenti per MCCA di campioni d'acqua) sono sviluppati in conformità con i requisiti di GOST R 1.5, GOST 1.2 e GOST R 8.563. La supervisione metrologica dei campioni d'acqua certificati dall'MKCA viene effettuata in conformità con GOST R 8.563 e,.
5. Sviluppo di un metodo per l'analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
5.1. Lo sviluppo dei campioni d'acqua ICCA consiste nelle seguenti fasi:
Sviluppo dei termini di riferimento (TOR);
Scelta del metodo di analisi e dei mezzi tecnici (strumenti di misura, campioni standard, miscele certificate, reagenti e materiali, utensili volumetrici, attrezzature);
Stabilire la sequenza e il contenuto delle operazioni nella preparazione e nell'esecuzione delle misurazioni, compresa la determinazione dei fattori di influenza dei campioni d'acqua e dell'MCCA dei campioni d'acqua e dei metodi per la loro eliminazione, l'intervallo dei contenuti del componente determinato e i valori consentiti di fattori influenzanti;
Verifica sperimentale dell'algoritmo stabilito per l'esecuzione delle misurazioni (effettuazione di misurazioni pilota);
Progettazione e conduzione di un esperimento (studi metrologici) per valutare gli indicatori di qualità dell'ICCA di campioni d'acqua per stabilire le caratteristiche attribuite all'errore di misura (incertezza) e le sue componenti;
Stabilire i valori della caratteristica assegnata dell'errore (incertezza) delle misurazioni;
Selezione e assegnazione di algoritmi controllo operativo procedure di analisi per l'attuazione dell'ICCA di campioni d'acqua in un particolare laboratorio;
Elaborazione di una bozza di documento per l'ICCA dei campioni d'acqua;
Certificazione MKCA di campioni d'acqua;
Approvazione della bozza di documento per l'ICCA dei campioni d'acqua.
5.2. Il TOR fornisce i dati iniziali per lo sviluppo dell'ICCA dei campioni d'acqua (nomi delle grandezze misurate, caratteristiche dei campioni d'acqua analizzati, errori di misurazione degli indicatori della composizione e delle proprietà dei campioni d'acqua, condizioni di misurazione sotto forma di valori nominali e (o) limiti di intervallo valori possibili grandezze d'influenza).
5.3. I metodi e gli strumenti di misura sono scelti secondo. I tipi di strumenti di misura scelti devono essere omologati secondo:
Regole, se l'MCA dei campioni d'acqua è destinato all'uso nel campo della distribuzione del controllo e della supervisione metrologica statale;
La procedura stabilita nel campo della difesa e della sicurezza, se l'ICCA dei campioni d'acqua è destinata all'uso nel campo della difesa e della sicurezza.
I campioni standard devono essere approvati in conformità con GOST 8.315, le miscele certificate devono essere approvate in conformità con.
5.4. Per l'MCA dei campioni d'acqua utilizzati per misurare il componente al livello dello standard di qualità dell'acqua, quando si stabilisce l'intervallo di contenuto del componente, il limite inferiore dell'intervallo di contenuto del componente determinato DA n deve soddisfare la condizione
DA n? 0.5NKV, (1)
dove NKV è lo standard di qualità dell'acqua.
Appunti
1. Fanno eccezione i componenti per i quali è impossibile raggiungere i valori indicati nella formula (1). In questo caso DA n può soddisfare la condizione DA n? NKV.
2. In assenza di dati sul valore dell'NKV, i dati sui livelli di fondo o medi dei valori di questo indicatore vengono utilizzati come livello indicativo di valori per la componente di qualità dell'acqua.
5.5. La pianificazione di un esperimento per valutare gli indicatori di qualità dell'MKCA dei campioni d'acqua viene eseguita in conformità con GOST R ISO 5725-1, GOST R ISO 5725-2, GOST R ISO 5725-4 e.
In generale, le fasi principali della pianificazione di un esperimento per valutare gli indicatori di qualità dell'MCCA dei campioni d'acqua sono:
Stesura di uno schema a blocchi dell'ICCA dei campioni d'acqua e analisi delle possibili fonti di errore (incertezza) delle misurazioni;
Studiare la composizione dei campioni d'acqua iniziali, studiando la possibile influenza della composizione totale dei campioni d'acqua sui risultati della misurazione;
Perfezionamento della gamma e dell'ambito dell'ICCA di campioni d'acqua in base allo studio;
Selezione del metodo per valutare gli indicatori di qualità dell'MCCA dei campioni d'acqua in base allo studio, determinazione della disponibilità di campioni standard, possibilità di preparare miscele certificate, aggiunta di additivi al campione analizzato, disponibilità di un metodo di confronto, ecc. ;
Determinazione del numero di laboratori che dovrebbero essere coinvolti in un esperimento di valutazione congiunta (se necessario, introduzione di campioni d'acqua ICCA nella rete dei laboratori);
Determinazione della tempistica dell'esperimento di valutazione.
5.6. I metodi per esprimere le caratteristiche di errore attribuite all'MCA dei campioni d'acqua devono essere conformi alle raccomandazioni, tenendo conto dell'allegato A e dei requisiti di GOST R ISO 5725-1. L'incertezza è espressa in conformità con , , e tenendo conto dell'allegato B.
I metodi per valutare gli indicatori di qualità dell'MKCA di campioni d'acqua sono selezionati secondo GOST R ISO 5725-1, GOST R ISO 5725-2, GOST R ISO 5725-4, GOST R ISO 5725-5 e anche in conformità con le raccomandazioni e l'Appendice B. I metodi per valutare l'incertezza scelgono secondo , , .
5.7. La scelta e l'assegnazione di algoritmi per il controllo operativo della procedura di analisi durante l'implementazione dell'ICA di campioni d'acqua in un particolare laboratorio viene effettuata in conformità con. La scelta e l'assegnazione di algoritmi per il monitoraggio della stabilità dei risultati di misurazione ottenuti dall'MKCA di campioni d'acqua quando viene implementato in un particolare laboratorio viene eseguita in conformità con GOST R ISO 5725-6 e.
5.8. I documenti per l'ICCA di campioni d'acqua nel caso generale dovrebbero contenere le seguenti sezioni:
Scopo e portata dei campioni d'acqua ICCA;
Caratteristiche assegnate dell'errore di misura (incertezza);
Strumenti di misura, dispositivi ausiliari, reagenti, materiali;
Metodo di misurazione;
Requisiti per la qualificazione degli esecutori;
Condizioni di misura;
Preparazione per l'esecuzione delle misurazioni;
eseguire misurazioni;
Calcolo dei risultati di misurazione, compresi i metodi per verificare l'accettabilità dei singoli risultati di determinazione ottenuti in condizioni di ripetibilità e dei risultati di misurazione ottenuti in condizioni di riproducibilità;
Controllo della qualità dei risultati delle misurazioni durante l'implementazione dell'MCA dei campioni d'acqua in laboratorio;
Registrazione dei risultati di misurazione.
La costruzione e la presentazione di documenti per l'ICCA di campioni d'acqua - in conformità con l'Appendice D. Esempi di progettazione di alcune sezioni dei documenti per l'ICCA di campioni d'acqua sono riportati nell'Appendice D.
6. Certificazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
6.1. La certificazione dell'ICCA dei campioni d'acqua viene effettuata al fine di confermare la possibilità di effettuare misurazioni secondo la procedura regolata dal documento per l'ICCA dei campioni d'acqua, con caratteristiche di errore di misura (incertezza) che non superano l'errore assegnato ( incertezza) caratteristiche specificate nel documento per l'ICCA dei campioni d'acqua.
6.2. I campioni d'acqua sono certificati dal MKCA:
Centri scientifici e metrologici statali (GNMC);
Enti del Servizio Metrologico dello Stato (OGMS);
32 Istituto Statale di Ricerche e Prove (di seguito denominato 32 GNIII MO RF) (in materia di difesa e sicurezza);
Servizi metrologici (strutture organizzative) di un'organizzazione (impresa).
Servizio metrologico ( struttura organizzativa) le organizzazioni (imprese) che effettuano la certificazione dell'ICCA di campioni d'acqua, utilizzate nel campo della distribuzione del controllo e della supervisione metrologica statale, devono essere accreditate per il diritto di certificare l'ICCA di campioni d'acqua secondo le norme.
Nota - I documenti per l'ICCA dei campioni d'acqua utilizzati nelle aree di distribuzione del controllo e della supervisione metrologica dello Stato sono sottoposti a esame metrologico presso l'SSMC o in organizzazioni i cui servizi metrologici sono accreditati per il diritto di condurre l'esame metrologico dei documenti per l'ICCA di campioni d'acqua utilizzati nelle aree di distribuzione del controllo e supervisione metrologica statale. I documenti per l'MCA di campioni d'acqua destinati all'uso nel campo della difesa e della sicurezza sono soggetti a esame metrologico presso il 32° Istituto statale di ricerca del Ministero della Difesa della Federazione Russa. L'esame metrologico dei documenti per l'MKCA di campioni d'acqua non viene effettuato se la certificazione dell'MKCA di campioni d'acqua viene eseguita da uno dei GNMC o 32 GNIII MO RF.
6.3. La certificazione dell'MCA dei campioni d'acqua viene effettuata mediante esame metrologico i seguenti materiali per lo sviluppo di campioni d'acqua ICCA:
TOR per lo sviluppo di campioni d'acqua ICCA;
Progetto di documento che regola l'ICCA dei campioni d'acqua;
Programmi e risultati della valutazione sperimentale e computazionale degli indicatori di qualità dei campioni d'acqua ICCA.
6.4. Quando si effettuano studi per stabilire gli indicatori di qualità dell'ICCA dei campioni d'acqua, nonché durante la sua certificazione, dovrebbe essere fornita l'esecuzione del lavoro elencato nell'Appendice E.
6.5. Quando conducono un esame metrologico dei materiali per lo sviluppo dell'ICCA di campioni d'acqua, analizzano la conformità dei metodi per presentare gli indicatori di qualità dell'ICCA di campioni d'acqua con le principali disposizioni di GOST R ISO 5725-1 - GOST R ISO 5725-4, raccomandazioni e Appendice C (metodi per presentare incertezza alle raccomandazioni e Appendice B); in termini di procedure di controllo della qualità per i risultati della misurazione, analizzare e annotare nel parere di esperti l'uso di procedure in conformità con GOST R ISO 5725-6 e. Quando si esegue un esame metrologico di documenti per l'ICCA di campioni d'acqua, vengono utilizzate raccomandazioni e.
6.6. In risultati positivi attestazioni:
Rilasciare un certificato di attestazione del MKCA dei campioni d'acqua (ad eccezione del MKCA dei campioni d'acqua regolato dalle norme nazionali). La forma del certificato è riportata nell'Appendice G. La procedura per la registrazione dei certificati di attestazione dell'ICCA di campioni d'acqua è stabilita dalle organizzazioni (imprese) che effettuano la certificazione dell'ICCA di campioni d'acqua;
Il documento che regola l'ICCA dei campioni d'acqua è approvato secondo le modalità previste;
Nel documento che regola l'ICCA dei campioni d'acqua (ad eccezione del norma statale), indicare: "il metodo è certificato" - con la designazione dell'organizzazione (impresa), il servizio metrologico di cui ha effettuato la certificazione, o il GNMC, o l'OGMS, che ha eseguito la certificazione del MKCA di campioni d'acqua.
Annesso A
(riferimento)
Forme di presentazione degli indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
Tabella A.1
|
Nome dell'indicatore di qualità dei campioni d'acqua ICCA |
Modulo di presentazione dell'indicatore di qualità dei campioni d'acqua ICCA |
|
Indicatore di precisione di MKCA di campioni d'acqua - caratteristica di errore assegnata di MKCA di campioni d'acqua |
1. I confini [inferiore, superiore (D n, D c)], in cui si trova l'errore di uno qualsiasi della totalità dei risultati dell'analisi (misurazioni) con la probabilità accettata R,- stima dell'intervallo, o ±D, R, per D = |D n | =D in = Z s(D), dove Z- quantile di distribuzione, a seconda del tipo e della probabilità accettata R. 2. Deviazione standard - s(D) dell'errore nei risultati dell'analisi (misure) ottenuti in tutti i laboratori che utilizzano questo ICCA di campioni d'acqua - stima puntuale |
|
L'indicatore della correttezza dell'MCCA dei campioni d'acqua è la caratteristica assegnata dell'errore sistematico dell'MCCA dei campioni d'acqua |
dov'è l'aspettativa matematica (stima) dell'errore sistematico; s c - deviazione standard dell'errore sistematico non escluso dell'MCCA dei campioni d'acqua - stima puntuale. Nota - ? può essere introdotto nel risultato di una singola analisi (determinazione) come correzione. 2. Confini (D s, n, D s, c), in cui si trova l'errore sistematico dell'MCCA dei campioni d'acqua con la probabilità accettata R, - stima dell'intervallo, o ± D s, R, dove D s,v = |D s,n | =D con = Z c |
|
L'indicatore della ripetibilità dell'MCCA dei campioni d'acqua è la caratteristica assegnata dell'errore casuale dei risultati di una singola analisi ottenuta in condizioni di ripetibilità |
1. Deviazione standard dei risultati di una singola analisi ottenuta in condizioni di ripetibilità (risultati di determinazioni parallele) - s r . 2. Limite di ripetibilità - r per due singoli risultati di analisi ottenuti in condizioni di ripetibilità (risultati di determinazioni parallele) |
|
L'indicatore di riproducibilità dell'MCA dei campioni d'acqua è la caratteristica assegnata dell'errore casuale dei risultati dell'analisi (misurazioni) ottenuti in condizioni di riproducibilità |
1. Deviazione standard dei risultati dell'analisi (misure) ottenuti in condizioni di riproducibilità - s R. 2. Limite di riproducibilità - R per due risultati di analisi (misure) |
NOTA Se l'MCCA dei campioni d'acqua è sviluppato per l'uso in un unico laboratorio, le caratteristiche di errore assegnate all'MCCA dei campioni d'acqua sono: indice di accuratezza, indice di precisione intralaboratorio, indice di ripetibilità e indice di correttezza (bias di laboratorio). Moduli di presentazione - in conformità con .
Allegato B
(riferimento)
Concetti di base e rappresentazione dell'incertezza
B.1. L'incertezza del risultato dell'analisi (misure), espressa come deviazione standard, è l'incertezza tipo e .
B.2. Il metodo per stimare l'incertezza mediante l'analisi statistica di serie di osservazioni è una stima di tipo A.
B.3. Un metodo per stimare l'incertezza, diverso dall'analisi statistica di serie di osservazioni, è una stima di tipo B.
B.4. L'incertezza tipo di un risultato di misurazione, quando il risultato è ottenuto dai valori di un numero di altre quantità, pari alla radice quadrata positiva della somma dei termini, essendo i termini le varianze o covarianze di queste altre quantità, ponderata in base a come cambia il risultato della misurazione al variare di queste grandezze, è l'incertezza tipo totale.
B.5. La grandezza che definisce l'intervallo attorno al risultato della misurazione, entro il quale (ci si potrebbe aspettare) la maggior parte delle distribuzioni di valori che potrebbero essere ragionevolmente attribuite al misurando, è l'incertezza estesa.
B.6. Il fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell'incertezza tipo combinata per ottenere l'incertezza estesa è il fattore di copertura. Il tasso di copertura è generalmente compreso tra 2 e 3. Accettazione del tasso di copertura K= 2 fornisce un intervallo che ha un livello di confidenza di circa il 95% e accettazione K= 3 fornisce un intervallo avente un livello di confidenza di circa il 99%.
B.7. Conformemente a quando si calcola l'incertezza, il risultato dell'analisi (misure) - X deve essere specificato insieme all'incertezza estesa tu, che viene calcolato utilizzando il fattore di copertura K= 2. Si consiglia il seguente modulo:
X ± u, (B.1)
dove uè l'incertezza estesa, calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2, che fornisce un livello di confidenza di circa il 95%.
Metodi per la valutazione degli indicatori di accuratezza (correttezza e precisione) del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
IN 1. Nel caso generale, l'MCCA dei campioni d'acqua comprende le seguenti fasi:
Preparazione del campione per l'analisi;
Misure dirette di segnali analitici (misure intermedie) e loro elaborazione;
Calcolo del risultato delle misurazioni del valore dell'indicatore della composizione (proprietà) delle acque, funzionalmente correlato ai risultati delle misurazioni dirette.
Ognuna di queste operazioni è gravata da propri errori. Molti fattori possono influenzare la formazione dell'errore del risultato della misurazione, tra cui:
Differenze casuali tra le composizioni dei campioni prelevati;
Effetti matrice e influenze reciproche;
Estrazione incompleta, concentrazione;
Possibili variazioni nella composizione del campione dovute alla sua conservazione;
Errori degli strumenti di misura utilizzati, inclusi campioni standard (RM) o miscele certificate (AC), apparecchiature, nonché la purezza dei reagenti utilizzati;
Inadeguatezza del modello matematico alla base del metodo di misurazione al fenomeno fisico;
Inadeguatezza dei campioni per la calibrazione rispetto ai campioni analizzati;
Incertezza del valore di correzione del bianco;
Azioni dell'operatore;
Variazioni dei parametri ambientali durante le misurazioni (temperatura, umidità, inquinamento atmosferico, ecc.);
Effetti casuali, ecc.
IN 2. La valutazione dei valori della caratteristica di errore assegnata - un indicatore dell'accuratezza dell'MCCA dei campioni d'acqua - viene effettuata secondo i valori stabiliti delle caratteristiche delle sue componenti casuali e sistematiche nell'intero intervallo di contenuto del componente determinato, per tutti gli intervalli di componenti associati (di seguito denominati fattori di influenza del campione), nonché le condizioni per l'esecuzione delle misurazioni riportate nel documento per i campioni d'acqua ICCA.
ALLE 3. La valutazione degli indicatori di precisione (ripetibilità e riproducibilità) può essere eseguita su campioni di acqua di lavoro omogenei e stabili utilizzando sia RM per la composizione dell'acqua secondo GOST 8.315, sia AC secondo la base di un esperimento interlaboratorio. I risultati dell'analisi degli stessi campioni o SS (AS) si ottengono con variazioni casuali dei fattori di influenza della metodologia in condizioni di riproducibilità ( tempo diverso, analisti diversi, lotti diversi di reagenti dello stesso tipo, set diversi di utensili volumetrici, copie diverse di strumenti di misura dello stesso tipo, laboratori diversi).
Nota: i campioni di lavoro devono essere omogenei e stabili nella composizione per tutta la durata dell'esperimento.
AT 4. La valutazione dell'indicatore di correttezza dell'MCCA dei campioni d'acqua può essere effettuata in uno dei seguenti modi - utilizzando:
Un insieme di campioni per la valutazione (ES) sotto forma di CO o AS;
Il metodo additivo e il metodo additivo abbinati al metodo di diluizione;
Metodologia certificata con caratteristiche di errore di misura note (stimate) (metodi di confronto);
Metodo di calcolo (sommando i valori numerici delle componenti dell'errore di misurazione sistematico).
B.4.1. L'uso di una serie di campioni per la valutazione sotto forma di CO o AS nelle condizioni di ottenere dati sperimentali in diversi laboratori consente di valutare la parte costante dell'errore sistematico, nonché la parte variabile dell'errore sistematico dovuto a i fattori di influenza del campione. Composizione generale Il TOE deve essere conforme allo scopo dell'ICCA per i campioni d'acqua. Il contenuto dell'indicatore da determinare ed i livelli dei fattori interferenti del campione nell'EPT sono selezionati secondo i requisiti del disegno sperimentale (singolo fattore o multifattore).
B.4.2. L'uso del metodo di addizione in combinazione con il metodo di diluizione consente di stimare le parti additiva (costante) e moltiplicativa (variante proporzionalmente) dell'errore sistematico dell'MCCA dei campioni d'acqua. L'uso del metodo additivo consente di stimare la parte moltiplicativa (variante proporzionalmente) dell'errore sistematico dell'MCCA dei campioni d'acqua. L'uso del metodo additivo è consentito se nella fase di studi preliminari o in base a dati a priori si stabilisce che la parte additiva (costante) dell'errore sistematico non è una frazione statisticamente significativa dell'errore del risultato dell'analisi.
I campioni per la valutazione sono campioni di acqua di lavoro, campioni di acqua di lavoro con un additivo noto, campioni di lavoro diluiti e campioni di lavoro diluiti con un additivo noto.
Nota - L'uso del metodo dell'addizione e del metodo dell'addizione in combinazione con il metodo della diluizione è accettabile se in fase di studi preliminari o in base a dati a priori si stabilisce che i fattori di influenza del campione non hanno un effetto significativo su l'errore del risultato dell'analisi.
B.4.3. L'uso di un metodo basato sull'uso di campioni d'acqua certificati ICCA con caratteristiche di errore note (stimate) (di seguito denominato confronto ICCA) è possibile alle seguenti condizioni:
L'ambito dell'MCCA di confronto coincide con l'ambito dell'MCCA investigato di campioni d'acqua o si sovrappone ad esso;
Il valore dell'indicatore di riproducibilità dell'MCCA di confronto non supera il valore dell'indicatore di riproducibilità dell'MCCA investigato di campioni d'acqua;
L'errore sistematico del confronto MKCA è insignificante sullo sfondo del suo errore casuale;
Il confronto MKCA soddisfa i requisiti del controllo intralaboratorio dell'accuratezza dei suoi risultati.
Nota - L'uso del confronto MCCA è accettabile se in fase di studi preliminari o in base a dati a priori si stabilisce che i fattori di influenza del campione non hanno un effetto significativo sull'errore del risultato dell'analisi.
B.4.4. L'applicazione del metodo di calcolo si basa sulla somma dei valori numerici delle componenti dell'errore sistematico.
Nel metodo di calcolo, i fattori che costituiscono l'errore sistematico dell'MCCA dei campioni d'acqua possono includere tutti i fattori elencati in B.1, ad eccezione degli effetti casuali, la cui valutazione quantitativa della cui influenza viene presa in considerazione nel calcolo la deviazione standard dei risultati di una singola analisi (determinazione) ottenuta in condizioni di ripetibilità.
Costruzione, contenuto e presentazione di documenti che regolano i metodi di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
D.1. Il nome del documento per l'MKCA di campioni d'acqua deve essere conforme ai requisiti di GOST R 1.5 e GOST R 8.563.
D.2. Il documento per l'ICCA dei campioni d'acqua deve contenere una parte introduttiva e sezioni disposte nell'ordine:
Norme di errore di misura;
Metodo di analisi (misure);
Strumenti di misura, dispositivi ausiliari, reagenti e materiali;
Requisiti di sicurezza, protezione dell'ambiente;
Requisiti di qualificazione dell'operatore;
Condizioni per l'esecuzione dell'analisi (misure);
Preparazione per analisi (misure);
Esecuzione di analisi (misure);
È consentito escludere e (o) combinare alcune sezioni.
D.3. Nella parte introduttiva, dovrebbero essere stabiliti lo scopo e la portata dell'ICCA dei campioni d'acqua. Devono essere indicati i tipi di acque analizzate, il nome del componente analizzato, l'intervallo di contenuto del componente analizzato e gli intervalli di variazione dei fattori di influenza del campione consentiti dall'ICCA dei campioni d'acqua. Se necessario, possono essere fornite informazioni sulla durata e la complessità delle misurazioni.
Il primo paragrafo della parte introduttiva è così recitato: “Il presente documento (indicare il tipo di documento per l'ICCA dei campioni d'acqua) stabilisce un metodo per l'analisi chimica quantitativa dei campioni d'acqua (indicare i tipi di acque analizzate) per determinare in essi (di seguito - il nome della grandezza misurata, con indicazione dell'intervallo della componente misurata e del metodo di misura utilizzato)”.
D.4. La sezione "Norme di errore di misurazione" dovrebbe contenere i valori consentiti dell'indice di precisione, che caratterizzano l'accuratezza di misurazione richiesta. I tassi di errore di misurazione sono indicati in conformità con GOST 27384 per l'intera gamma di contenuti misurati dell'analita.
D.5. La sezione "Caratteristiche attribuite dell'errore di misurazione e dei suoi componenti" contiene i valori numerici degli indicatori di qualità dell'MKCA dei campioni d'acqua. I metodi per esprimere gli indicatori di qualità dei campioni d'acqua ICCA dovrebbero essere conformi all'Appendice B e alle raccomandazioni.
I valori delle caratteristiche assegnate dell'errore di misurazione (gli indicatori di qualità dell'MKCA dei campioni d'acqua) devono essere indicati per l'intera gamma dei contenuti misurati. Se gli indicatori di qualità dell'MCCA dei campioni d'acqua dipendono dal contenuto misurato, i loro valori dovrebbero essere presentati sotto forma di una dipendenza funzionale dal contenuto misurato o una tabella di valori per intervalli di contenuto, all'interno di ciascuno dei quali cambia nei valori degli indicatori di qualità possono essere trascurati.
Nota - Se la sezione fornisce i valori di incertezza, i metodi della sua espressione sono presentati secondo e .
D.6. La sezione "Metodo di misurazione" dovrebbe contenere il nome del metodo di misurazione e una descrizione del principio (fisico, fisico-chimico, chimico) che lo sta alla base.
D.7. La sezione "Strumenti di misura, dispositivi ausiliari, reagenti, materiali" dovrebbe contenere un elenco completo degli strumenti di misura (compresi i campioni standard), dispositivi ausiliari, materiali e reagenti necessari per eseguire le misurazioni. Nell'elenco di questi mezzi, insieme al nome, designazioni di norme nazionali (norme di altre categorie) o specifiche tecniche, designazioni di tipi (modelli) di strumenti di misura, loro caratteristiche metrologiche (classe di precisione, limiti di errori consentiti, limiti di misurazione , ecc.) sono indicati.
Se la misurazione richiede dispositivi speciali, dispositivi, in applicazione di aiuto disegni, descrizioni e caratteristiche dei campioni d'acqua dovrebbero essere riportati nel documento per l'ICCA dei campioni d'acqua.
D.8. La sezione "Requisiti per la sicurezza, la protezione dell'ambiente" contiene i requisiti il cui rispetto garantisce la sicurezza del lavoro, gli standard di igiene industriale e la protezione dell'ambiente durante l'esecuzione delle misurazioni.
D.9. La sezione "Requisiti per la qualifica dell'operatore" dovrebbe includere i requisiti per il livello di qualifica (professione, istruzione, esperienza lavorativa, ecc.) delle persone autorizzate a eseguire misurazioni.
D.10. La sezione "Condizioni per l'esecuzione delle misurazioni" dovrebbe contenere un elenco di fattori (temperatura, pressione, umidità, ecc.) che determinano le condizioni per l'esecuzione delle misurazioni, gli intervalli di variazione di questi fattori consentiti dall'ICAA dei campioni d'acqua o i loro valori nominali , indicando i limiti delle deviazioni ammissibili.
D.11. La sezione "Preparazione per le misurazioni" dovrebbe contenere una descrizione di tutti i preparativi per le misurazioni.
La sezione dovrebbe descrivere la fase di verifica delle modalità operative dell'apparecchiatura di misurazione e messa in condizione di lavoro, o fornire un collegamento a documenti normativi che stabiliscono la procedura per la preparazione dell'apparecchiatura utilizzata.
La sezione dovrebbe descrivere i metodi di elaborazione dei campioni analizzati di campioni per la calibrazione, le procedure per la preparazione delle soluzioni necessarie per l'analisi. Per soluzioni con stabilità limitata vanno indicate le condizioni ed i periodi di conservazione. È consentito fornire il metodo di preparazione delle soluzioni nell'appendice di riferimento al documento per l'ICCA dei campioni d'acqua.
Se, durante l'esecuzione delle misurazioni, è prevista la determinazione di una caratteristica di calibrazione, la sezione dovrebbe fornire i metodi per la sua determinazione e controllo, nonché la procedura per l'utilizzo dei campioni per la calibrazione.
Se, per stabilire una caratteristica di calibrazione, è necessario utilizzare campioni per la calibrazione sotto forma di miscele preparate direttamente durante le misurazioni, la sezione dovrebbe contenere una descrizione della procedura per la loro preparazione, i valori (uno o più) del contenuto dei componenti della miscela di sostanze iniziali e delle caratteristiche dei loro errori.
È consentito indicare il metodo di preparazione di tali campioni nell'appendice di riferimento al documento per l'ICCA dei campioni d'acqua.
Se la procedura per i lavori preparatori è stabilita da documenti per strumenti di misura e altro mezzi tecnici, quindi la sezione fornisce collegamenti a questi documenti.
D.12. Nella sezione "Esecuzione delle misurazioni", dovrebbero essere stabiliti i requisiti per il volume (massa) delle porzioni di campione, il loro numero, i metodi per prelevare una porzione analitica, se necessario, viene fornita un'istruzione per condurre un "esperimento in bianco"; vengono determinati la sequenza di esecuzione e il contenuto delle operazioni che forniscono il risultato della misurazione, comprese le operazioni per eliminare l'influenza di eventuali componenti del campione interferenti.
D.13. Nella sezione "Elaborazione (calcolo) del risultato della misurazione", dovrebbero essere descritti i metodi per calcolare il valore del contenuto dell'indicatore nel campione d'acqua analizzato dai dati sperimentali ottenuti. Le formule di calcolo per ottenere il risultato della misurazione devono essere fornite con l'indicazione delle unità dei valori misurati secondo GOST 8.417.
Questa sezione fornisce metodi per verificare l'accettabilità dei risultati di determinazioni parallele ottenute in condizioni di ripetibilità e dei risultati di misurazione ottenuti in condizioni di riproducibilità.
I valori numerici del risultato della misurazione devono terminare con una cifra della stessa cifra del valore dell'indice di precisione del MKCA dei campioni d'acqua.
D.14. La sezione "Formazione dei risultati di misurazione" contiene i requisiti per la forma di presentazione dei risultati di misurazione ottenuti.
D.15. La sezione "Controllo di qualità dei risultati di misurazione durante l'attuazione della metodologia in laboratorio" dovrebbe contenere una descrizione delle procedure di controllo, i valori degli standard di controllo, i requisiti per i campioni di controllo.
Allegato D
(riferimento)
Esempi di progettazione di sezioni di documenti che regolano i metodi di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
D.1. In conformità con l'Appendice A, questa appendice fornisce esempi del progetto della parte introduttiva e le seguenti sezioni di documenti per l'ICCA dei campioni d'acqua:
Caratteristiche assegnate dell'errore di misura e delle sue componenti;
Elaborazione (calcolo) del risultato dell'analisi (misure);
Registrazione dei risultati dell'analisi (misure);
Controllo della qualità dei risultati dell'analisi (misure) durante l'implementazione della metodologia in laboratorio.
D 2. Un esempio del design della parte introduttiva
"Questo standard di un'organizzazione (impresa) stabilisce una metodologia per l'analisi chimica quantitativa di campioni di acque reflue per determinare in essi concentrazione di massa ioni solfato da 25 a 400 mg/dm 3 con il metodo gravimetrico.
D.3. Un esempio del progetto della sezione "Caratteristiche attribuite dell'errore di misura e dei suoi componenti"
E.3.1. Il metodo dell'analisi chimica quantitativa fornisce i risultati dell'analisi (misure) con un errore, il cui valore non supera i valori indicati nella tabella E.1.
Tabella E.1 - Intervallo di misura, valori degli indicatori di accuratezza, ripetibilità e riproducibilità del MKCA dei campioni d'acqua
E.3.2. I valori dell'indice di precisione del MKCA dei campioni d'acqua vengono utilizzati per:
Registrazione dei risultati delle analisi (misure) rilasciati dal laboratorio;
Valutazione delle attività dei laboratori per la qualità delle prove;
Valutare la possibilità di utilizzare i risultati dell'analisi (misure) nell'implementazione dell'ICA di campioni d'acqua in un particolare laboratorio.
D.4. Un esempio del design della sezione "Elaborazione (calcolo) del risultato dell'analisi (misurazioni)"
E.4.1. Il risultato di una singola analisi (determinazione): il contenuto dell'indicatore determinato nel campione viene trovato secondo la curva di calibrazione.
E.4.2. Il risultato dell'analisi (misure) del contenuto dell'indicatore determinato nel campione viene preso come media aritmetica dei risultati di due determinazioni parallele ottenute in condizioni di ripetibilità, la cui discrepanza non deve superare il limite di ripetibilità. Valori limite di ripetibilità r per due risultati di determinazioni parallele sono indicati nella tabella E.2.
Quando viene superato il limite di ripetibilità r bisogno di ottenere di più n (n? 1) risultati di determinazioni parallele. Se, in questo caso, la discrepanza ( X max- X min) risultati 2 + n definizioni parallele inferiori (o uguali) all'intervallo critico CR 0,95 (2+ n) secondo GOST R ISO 5725-6, quindi la media aritmetica dei risultati 2 + n definizioni parallele. Valori di intervallo critico per 2+ n i risultati delle determinazioni parallele sono riportati nella tabella E.2.
Se la discrepanza ( X max- X min) di più CR 0,95 (2+ n), come risultato finale dell'analisi (misurazione) prendere la mediana 2 + n risultati di determinazioni parallele.
Al ricevimento di due risultati consecutivi dell'analisi (misurazioni) sotto forma di mediana, vengono individuati i motivi del verificarsi di tale situazione e viene effettuato il controllo operativo della procedura di analisi secondo .
Tabella E.2 - Campo di misura, valori del limite di ripetibilità e del campo critico alla probabilità ipotizzata R = 0,95
E.4.3. La discrepanza tra i risultati dell'analisi (misure) ottenuti in due laboratori non deve superare il limite di riproducibilità. Se questa condizione è soddisfatta, entrambi i risultati dell'analisi (misurazioni) sono accettabili e il loro valore medio totale può essere utilizzato come risultato finale. I valori del limite di riproducibilità sono indicati nella Tabella E.3.
Se il limite di riproducibilità viene superato, è possibile utilizzare metodi per valutare l'accettabilità dei risultati dell'analisi (misurazioni) in conformità con la sezione 5 di GOST R ISO 5725-6.
Tabella E.3 - Range di misura, valori del limite di riproducibilità alla probabilità accettata R = 0,95
D.5. Un esempio del design della sezione "Formattazione dei risultati dell'analisi (misure)"
Il risultato dell'analisi (misure), , nei documenti che ne prevedono l'uso, può essere rappresentato come
![]()
dove - il risultato dell'analisi (misure), ottenuto secondo quanto prescritto dalla metodologia;
D è un indicatore dell'accuratezza del MKCA dei campioni d'acqua. I valori di D sono riportati nella sezione E.3 "Caratteristiche assegnate dell'errore di misura e delle sue componenti".
È consentito presentare il risultato dell'analisi (misure) nei documenti rilasciati dal laboratorio nel modulo
![]() previsto D l< D,
previsto D l< D,
dove ± D l - il valore della caratteristica di errore dei risultati di misurazione, stabilito durante l'implementazione della metodologia in laboratorio, secondo la procedura adottata in laboratorio, tenendo conto delle raccomandazioni e assicurata monitorando la stabilità dei risultati di misurazione .
Nota - Quando si presenta il risultato dell'analisi (misure) nei documenti rilasciati dal laboratorio, indicare il numero di risultati delle determinazioni parallele eseguite per ottenere il risultato dell'analisi (misure) e il metodo di calcolo del risultato dell'analisi (misure) - la media aritmetica o mediana dei risultati di determinazioni parallele.
D.6. Un esempio della progettazione della sezione "Controllo di qualità dei risultati dell'analisi (misure) durante l'implementazione della metodologia in laboratorio"
D.6.1. Il controllo della qualità dei risultati dell'analisi (misure) quando si implementa la metodologia in laboratorio prevede:
Controllo operativo della procedura di analisi (misure) - basato sulla valutazione dell'errore nell'attuazione di un'unica procedura di controllo;
Controllo della stabilità dei risultati della misurazione - basato sul controllo della stabilità della deviazione standard della ripetibilità, della deviazione standard della precisione intralaboratorio, dell'errore.
D.6.2. Algoritmo per il controllo operativo della procedura di analisi (misure) utilizzando campioni di controllo (CO o AS)
K a con standard di controllo K.
K k è calcolato dalla formula
dove - il risultato della misurazione di controllo del contenuto dell'analita nel campione di controllo - la media aritmetica di due risultati di determinazioni parallele la cui discrepanza non supera il limite di ripetibilità r. Significato r indicare nella tabella D.2;
DA- valore certificato del campione di controllo.
Norma di controllo K calcolato dalla formula
K= D l, (D.2)
dove ±D l - caratteristica dell'errore dei risultati della misurazione, corrispondente al valore certificato del campione di controllo e impostata secondo .
Ka ? K.(D.3)
Se la condizione (D.3) non è soddisfatta, l'esperimento viene ripetuto. Se la condizione (D.3) non si ripresenta, il processo di analisi viene sospeso, vengono individuate le ragioni che portano a risultati insoddisfacenti e si adottano misure per eliminarle.
E.6.3. Algoritmo per il controllo operativo della procedura di analisi (misure) mediante il metodo delle addizioni
Il controllo operativo della procedura di analisi (misure) viene effettuato confrontando il risultato di una singola procedura di controllo K a con standard di controllo K d .
Il risultato della procedura di controllo K k è calcolato dalla formula
![]() (D.4)
(D.4)
dove - il risultato di una misurazione di controllo del contenuto dell'analita in un campione con un additivo noto - la media aritmetica di due risultati di determinazioni parallele la cui discrepanza non supera il limite di ripetibilità r. Significato r indicare nella tabella D.2;
Il risultato della misurazione di controllo del contenuto del componente determinato nel campione di lavoro è il valore medio aritmetico n risultati di determinazioni parallele, la cui discrepanza non supera il limite di ripetibilità r;
DA- additivo.
Norma di controllo K d è calcolato dalla formula
![]() (D.5)
(D.5)
dove sono i valori dell'errore caratteristici dei risultati dell'analisi (misure) stabiliti in laboratorio al momento dell'implementazione della metodologia, corrispondenti al contenuto dell'analita nel campione di lavoro e nel campione con l'additivo.
La procedura di analisi (misurazioni) è riconosciuta soddisfacente se la condizione è soddisfatta
K a? K d . (D.6)
Se la condizione (D.6) non è soddisfatta, l'esperimento viene ripetuto. Se la condizione (D.6) non si ripresenta, il processo di analisi viene sospeso, vengono individuate le ragioni che portano a risultati insoddisfacenti e si adottano misure per eliminarle.
La frequenza del controllo della procedura di analisi (misure), nonché le procedure implementate per monitorare la stabilità dei risultati dell'analisi (misure) sono stabilite nel Manuale della Qualità del Laboratorio.
Allegato E
(riferimento)
Il contenuto del lavoro nel corso di studi metrologici e certificazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua
Tabella E.1
|
Nome delle opere |
Esecutore |
|
1. Verifica della disponibilità delle condizioni necessarie per gli studi metrologici del MKCA di campioni d'acqua: Verifica della conformità della bozza di documento, che regola l'ICCA dei campioni d'acqua, presentati per la certificazione metrologica, ai requisiti del ToR e dell'allegato D della presente norma; Verifica della correttezza della scelta degli strumenti di misura previsti dall'ICCA dei campioni d'acqua; Verifica del rispetto delle condizioni per l'uso degli strumenti di misura previste dall'ICCA dei campioni d'acqua, le condizioni per il loro utilizzo specificate in documenti normativi sugli strumenti di misura; Verifica disponibilità, condizione tecnica e la conformità ai requisiti dell'ICCA dei campioni d'acqua degli strumenti di misura, equipaggiamento ausiliario, vetreria di laboratorio, reagenti, materiali necessari per la certificazione dei campioni d'acqua da parte dell'ICCA; Verifica della conformità dei metodi per la preparazione delle miscele richieste per la certificazione dell'ICCA dei campioni d'acqua con le raccomandazioni |
|
|
2. Elaborazione di un programma per la valutazione sperimentale e computazionale degli indicatori di qualità dell'ICCA dei campioni d'acqua |
Sviluppatore del MKCA di campioni d'acqua, servizio metrologico dell'organizzazione (impresa), GNMC, OGMS |
|
3. Effettuare ricerche per stabilire i valori degli indicatori di qualità dell'ICCA di campioni d'acqua per valutare i valori della caratteristica di errore assegnata e delle sue componenti, formalizzando i risultati della ricerca |
Sviluppatore di campioni d'acqua ICCA |
|
4. Convalida: Realizzazione di studi per stabilire indicatori di qualità dei campioni d'acqua MKCA; Stabilire i valori degli indicatori di qualità dei campioni d'acqua ICCA; La scelta (calcolo) delle norme di errore di misura per la determinata componente della composizione (proprietà) dell'acqua. Verifica della conformità dei valori calcolati della caratteristica assegnata dell'errore di misurazione agli standard dell'errore di misurazione. Analisi della validità delle procedure e degli standard per il controllo di qualità dei risultati delle misurazioni nell'implementazione dell'IQCA dei campioni d'acqua in laboratorio |
Sviluppatore del MKCA di campioni d'acqua, servizio metrologico dell'organizzazione (impresa), GNMC, OGMS |
|
5. Certificazione di campioni d'acqua da parte dell'ICCA sulla base dei risultati dell'esame metrologico dei materiali per il suo sviluppo, compresi i materiali per stabilire indicatori di qualità, in conformità con le raccomandazioni |
Organizzazione che certifica la MKCA dei campioni d'acqua [servizio metrologico dell'organizzazione (impresa), GNMC, OGMS] |
|
Modulo di attestazione del metodo di analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua nome dell'organizzazione (impresa) che ha effettuato la certificazione dei campioni d'acqua MKCA CERTIFICATO n. Metodo per l'analisi chimica quantitativa di campioni d'acqua ________________________________________________________________________ nome della quantità misurata, metodo di misurazione, tipi di acqua sviluppato da ____________________________________________________________ nome dell'organizzazione (impresa) che ha sviluppato l'ICCA dei campioni d'acqua e regolato da _________________________________________________________ denominazione e nome del documento certificato secondo GOST R 8.563-96. La certificazione è stata effettuata sulla base dei risultati di _____________________________________ tipo di lavoro: esame metrologico dei materiali per lo sviluppo ________________________________________________________________________ MCCA di campioni d'acqua, studio teorico o sperimentale di MCCA di campioni d'acqua, altri tipi di lavoro I risultati della certificazione dell'MKCA di campioni d'acqua che soddisfano i requisiti metrologici sono riportati nelle tabelle G.1 e G.2 (con la probabilità accettata P = 0,95). Tabella G.1 Tabella G.2 Quando si implementa l'MKCA, i campioni d'acqua in laboratorio forniscono: Controllo operativo della procedura di analisi (basato sulla valutazione dell'errore nell'attuazione di un'unica procedura di controllo); Controllo della stabilità dei risultati dell'analisi (basato sul controllo della stabilità della deviazione standard della ripetibilità, della deviazione standard della precisione intralaboratorio, dell'errore). L'algoritmo per il controllo operativo della procedura di analisi è riportato nel documento per l'ICCA dei campioni d'acqua. Le procedure per il monitoraggio della stabilità dei risultati dell'analisi sono stabilite nel Manuale della Qualità del laboratorio. data di emissione Responsabile dell'organizzazione (impresa) _________________ __________________ trascrizione della firma personale della firma Luogo di stampa |
Bibliografia
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Indicatori di accuratezza, correttezza, precisione dei metodi di analisi chimica quantitativa. Metodi di valutazione. - M.: IPK Casa editrice di standard, 2004 |
|
|
Dizionario internazionale di termini in metrologia VIM (Dizionario russo-inglese-tedesco-spagnolo di termini di base e generali in metrologia). - M.: IPK Casa editrice di standard, 1998 |
|
|
PR 50.2.002-94 |
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. La procedura per esercitare la supervisione metrologica statale sul rilascio, lo stato e l'uso degli strumenti di misura, i metodi certificati per l'esecuzione delle misurazioni, gli standard e il rispetto di regole e norme metrologiche. - M.: VNIIMS, 1994 |
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Controllo metrologico e supervisione effettuati dai servizi metrologici delle persone giuridiche. - M.: VNIIMS, 1994 |
|
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. La scelta di metodi e mezzi di misurazione nello sviluppo di metodi per eseguire misurazioni. Disposizioni generali. - M.: VNIIMS, 1989 |
|
|
PR 50.2.009-94 |
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. La procedura per il collaudo e l'approvazione del tipo di strumenti di misura (con emendamento n. 1). - M.: VNIIMS, 1994 |
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Miscele certificate. Requisiti generali per lo sviluppo. - M.: IPK Casa editrice di standard, 2004 |
|
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Risultati e caratteristiche degli errori di misura. Moduli di presentazione. Metodi di utilizzo per testare campioni di prodotto e monitorare i loro parametri. - M.: VNIIMS, 2004 |
|
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Applicazione delle "Linee guida per l'espressione dell'incertezza nella misurazione". - M.: IPK Casa editrice di standard, 2001 |
|
|
Guida all'espressione dell'incertezza di misura. - Per. dall'inglese. - S.-Pb.: VNIIM im. DI. Mendeleev, 1999 |
|
|
Manuale EURACHIM/SITAC//Descrizione quantitativa dell'incertezza nelle misure analitiche. - 2a ed., 2000. - Per. dall'inglese. - S.-Pb.: VNIIM im. DI. Mendeleev, 2002 |
|
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Controllo interno la qualità dei risultati dell'analisi chimica quantitativa. - Ekaterinburg: UNIIM, 2002 |
|
|
PR 50.2.013-97 |
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. La procedura per l'accreditamento dei servizi metrologici delle persone giuridiche per il diritto di attestare i metodi per l'esecuzione delle misurazioni e l'esecuzione dell'esame metrologico dei documenti. - M.: VNIIMS, 1997 |
|
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Garantire l'efficacia delle misurazioni nella gestione processi tecnologici. Stima dell'errore di misura con informazioni iniziali limitate. - M.: IPK Casa editrice di standard, 2004 |
|
|
R 50.2.008-2001 |
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Metodi di analisi chimica quantitativa. Il contenuto e la procedura per l'esame metrologico. - M.: IPK Casa editrice di standard, 2001 |
Parole chiave: metodologia per l'analisi chimica quantitativa di campioni di acque reflue naturali, potabili (MCCA di campioni d'acqua), standard di errore di misurazione, caratteristiche di errore di misurazione attribuito, indicatori di qualità di MCCA di campioni d'acqua
Pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4

pagina 5

pagina 6

pagina 7

pagina 8

pagina 9

pagina 10

pagina 11

pagina 12

pagina 13
Metodi chimici Metodo n. 113-X
LATTINA
Metodologia del settore Categoria III precisione
(Versione 2009)
Mosca, 2009
MINISTERO DELLE RISORSE NATURALI ED ECOLOGIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA
CENTRO FEDERALE SCIENTIFICO E METODOLOGICO PER STUDI DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONE DELLE MATERIE PRIME MINERALI "VIMS"
Consiglio Scientifico per i metodi analitici
Metodi chimici Metodo 113-X
LATTINA
METODO DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA
DETERMINAZIONE FOTOMETRICA DELLO STAGNO IN ROCCE, MINERALI E MINERALI CON fenilfluorone dopo co-precipitazione con berillio idrossido
Categorie di accuratezza della metodologia del settore 111
(Versione 2009)
Mosca, 2009
X - la quantità di stagno trovata secondo la curva di calibrazione, μg,
V è il volume totale della soluzione in esame, cm ';
A è il volume di un'aliquota della soluzione in esame prelevata per la determinazione, cm 1;
H - intoppo, g.
Se la frazione di massa dello stagno deve essere convertita in materia assolutamente secca,
il risultato ottenuto (in%) viene moltiplicato per il valore -, dove a è il contenuto
acqua igroscopica (in %), determinata asciugando una porzione separata del campione a 105°C.
11.2. Il risultato della misurazione del contenuto di stagno nel campione viene preso come media aritmetica di due risultati di determinazioni parallele, la cui discrepanza non deve superare il limite di ripetibilità. I valori del limite di ripetibilità (r) per due risultati di determinazioni parallele sono riportati nella tabella 2.
11J. Le discrepanze tra i risultati dell'analisi (misure) ottenuti in due laboratori, ns non devono superare il limite di riproducibilità L = 2.&7 *. Se la differenza assoluta tra i risultati di due misurazioni non supera R, queste misurazioni sono considerate coerenti e la loro media aritmetica può essere utilizzata come risultato finale. I valori del limite di riproducibilità sono indicati nella tabella 2. Se viene superato il limite di riproducibilità R, scoprire i motivi di questo eccesso (GOST R ISO 5725-6, sezione 5.3).
|
Tavolo 2 Campo di misura, valori di ripetibilità e limiti di riproducibilità al livello di confidenza P=0,95 |
|||||||||||||||||||||
|
12. REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANALISI (MISURE)
Il risultato dell'analisi (misurazioni) nei documenti che ne prevedono l'utilizzo si presenta come:
ChiL, R- 0,95,
dove x è il risultato dell'analisi (misure), espresso come frazione di massa dell'elemento da determinare (%),
D è un indicatore dell'accuratezza del metodo applicato di analisi chimica quantitativa.
I valori di L sono riportati nella Tabella 1. Il valore numerico del risultato dell'analisi deve terminare con una cifra della stessa cifra del valore della caratteristica di errore.
13. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI RISULTATI DELL'ANALISI
13.1. Il controllo di qualità dei risultati di misura nell'implementazione della metodologia in laboratorio prevede:
Controllo operativo da parte dell'esecutore della procedura di misurazione basato sulla valutazione dell'errore nell'esecuzione di un'unica procedura di controllo;
Monitoraggio della stabilità dei risultati di misurazione basato sul monitoraggio della stabilità della deviazione standard della ripetibilità e della deviazione standard della precisione intralaboratorio.
13.2. Algoritmo per il controllo operativo della procedura di analisi utilizzando
campioni per il controllo.
Il controllo operativo della procedura di misura viene effettuato confrontando il risultato di una singola procedura di controllo K k con lo standard di controllo di precisione K.
Il risultato della procedura di controllo da K a (in frazioni di massa,%) è calcolato da
formula: K k \u003d jx-C |,
dove X è il risultato della misurazione del contenuto dell'analita nel campione di controllo (in frazioni di massa, %);
C - valore certificato del componente determinato nel campione di controllo (in frazioni di massa, %).
Lo standard di controllo della precisione è calcolato dalla formula:
K = D, /> = 0,95,
dove D è un indicatore dell'accuratezza dei risultati di misura corrispondenti al valore certificato del campione di controllo C.
I valori D sono riportati nella tabella I.
L'accuratezza della misura di controllo è considerata soddisfacente se:
K k £ K e insoddisfacente se K k > K.
Se la condizione K a< К эксперимент повторяют. При повторном невыполнении условия, процесс анализа приостанавливают, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
È accettabile presentare il risultato dell'analisi (misure) nei documenti rilasciati dal laboratorio nella forma:
x e D, P - 0,95, soggetto a D,< Д.
dove Dn è il valore della caratteristica di errore dei risultati di misura, stabilita durante l'implementazione della metodologia in laboratorio, secondo la procedura adottata in laboratorio, e assicurata monitorando la stabilità dei risultati di misura.
LETTERATURA
1. Ginzburg LB, Shkrobot E.P. Determinazione di piccole quantità di stagno nei minerali mediante metodi fluorescenti e colorimetrici. Testa Laboratorio. 23, 5, 527 (1957).
2. Istruzioni di sicurezza per lavoro di laboratorio, M.VIEMS, 1976.
3. Nazarenko VA, Lebedeva NV Determinazione dello stagno in minerali poveri con paranitrofenilfluorone. Testa Laboratorio. 23, 3.268, 1962.
4. Nazarenko VA, Lebedeva NV Derivati del triossifluorone come reagenti per stagno e antimonio. JAH, X, 5, 289, 1955.
5. Nazarenko VA, Lebedeva NV Ravitskaya RV Metodi per la determinazione del germanio in minerali, carboni e rifiuti industriali. Testa Laboratorio. 24.1, 9, 1958.
6. Sakaki Takashi. Sulla determinazione dello stagno nel ferro e nell'acciaio con il metodo spettrofotometrico. Rif. Zhur. Chimica, 23, G 133, 1966 (Nihon Konzoku Gakkaishi. J. Japan Inst. Metals 29, Jfe 9, 835, 1965)
7. Seidel E. Metodi colorimetrici per la determinazione di tracce di metalli. ed. "Mir", M., 1964, p.774.
8. Silaeva E.V., Kurbatova V.N. Determinazione dello stagno nel ferromolibdeno. Testa Laboratorio. 27.12, 1462 (1961).
9. Charlot G. Analisi quantitativa di composti inorganici. ed. "Chimica", M., 1965, p.754.
10. Shumova TI, Blum IA Determinazione del basso contenuto di stagno con butilrodamina S. Head. Laboratorio. 34, 6, 1968.
11. Bcnnct RL, Smith HA Determinazione spettrofotometrica dello stagno con phcnylfluorone. analista. Chimica. 31, 8.1441, 1959.
12. Luca CL Determinazione fotometrica dello stagno con phcnylfluorone. analista. Chimica. 28, 8, 1276, 1956.
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL METODO
Questo documento stabilisce una metodologia per l'analisi chimica quantitativa di rocce, minerali e minerali da determinare in essi metodo fotometrico frazione di massa stagno nell'intervallo da 0,02 a 1,5%.
2. CARATTERISTICHE DELL'ERRORE DI MISURA
I limiti dell'errore totale relativo del risultato delle misurazioni della frazione di massa dello stagno in oggetti naturali di varia composizione sono riportati nella tabella 1.
Gli errori indicati nella tabella 1 corrispondono ai requisiti per gli errori di misurazione stabiliti da OST 41-08-212-04 e adottati dal Ministero delle risorse naturali della Russia.
Tabella 1
|
Limiti di errore totali relativi |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3. STRUMENTI DI MISURA, ATTREZZATURE AUSILIARI, MATERIALI, REAGENTI
Quando si eseguono misurazioni, vengono utilizzati i seguenti strumenti di misurazione, apparecchiature ausiliarie, materiali e reagenti.
3.1. Strumenti di misura.
Bilance analitiche da laboratorio di qualsiasi tipo, 1a classe di precisione, GOST 24104.
Spettrofotometro o fotocolorimetro di qualsiasi tipo che misuri densità ottica soluzioni nell'intervallo 490 - 530 nm.
Cilindri dimensionali 1-5 (10, 25, 50. 100), GOST 1770.
3.2. Attrezzature ausiliarie, utensili.
Piano cottura elettrico con spirale chiusa e a temperatura controllata riscaldamento, GOST 14419.
Forno a muffola di qualsiasi tipo con temperatura di riscaldamento di 100°C.
3.3. Campioni a composizione standard.
Campioni standard della composizione (GSO, OSO, MSO) o miscele certificate (AS) con contenuto di stagno certificato, accertate con un errore di certificazione insignificante rispetto all'errore della metodologia (tabella 1). GSO, OSO, MSO e AS dovrebbero essere simili per composizione e contenuto di vanadio ai campioni analizzati.
3.4. Reagenti e materiali.
Acido fluoridrico, grado analitico, GOST 10484.
Ossalato di ammoniaca, un'acqua, puro, GOST 5712.
Berillio solfato, sale tetraidrato, (BeS0 4 -4H 2 0), grado analitico, TU 6-09-2561.
Tricloruro di ferro, sei acqua, grado analitico, GOST 4328.
11 tetraborato di sodio, decaidrato (borace), grado analitico, GOST 4199.
Sale disodico dell'acido tetraacetico, due acque (complesso 111), grado analitico, GOST 10652.
Carbonato di sodio, anidro (soda), grado analitico, GOST 83.
Stagno metallico, chimicamente puro, TU 6-09-2704.
Fenilfluorone, grado analitico, TU 6-09-05-289.
Gelatina.
Indicatore P-dinitrofenolo,
Carta indicatrice, universale (pH 1-10), TU 6-09-1181
Cartina tornasole (indicatore), TU 6-09-3403.
Alcool etilico, TU 6-09-1710.
Filtri senza cenere "nastro bianco", diametro 9 cm e 7 cm, TU 6-09-1678.
È consentito utilizzare altri tipi di strumenti di misura, utensili, apparecchiature ausiliarie, anche di importazione, con caratteristiche non peggiori di quelle indicate ai punti 3.1, 3.2. Tutti i reagenti utilizzati p.3.4. deve avere una classe di purezza analitica (chda o chimicamente pura).
4. METODO DI MISURA
Lo stagno tetravalente in un mezzo acido (0,1-3 N) forma un composto complesso poco solubile con fenilfluorone. A un basso contenuto di stagno nella soluzione, si forma una sospensione colloidale, che viene stabilizzata dall'aggiunta di un colloide protettivo: la gelatina. La soluzione colloidale risultante, a seconda del contenuto di stagno, acquisisce un colore dal giallo (il colore di una soluzione acida di fenilfluorone) al rosso attraverso varie sfumature arancione (I, 4, 8, II, 12J.
Il massimo assorbimento di luce di una soluzione di un complesso colorato di stagno con fenilfluorone si trova nella regione di circa 500 nm. Il coefficiente di assorbimento della luce molare è 80000.
In questa versione del metodo, la reazione avviene in una soluzione di 0,3 N in acido solforico. L'intensità del colore raggiunge il massimo dopo due ore e rimane costante per diverse ore.
La densità ottica della soluzione viene misurata su un fotocolorimetro (Xp**=490-530 nm). Il colore della soluzione obbedisce alla legge di Bouguer-Beer nell'intervallo da 2 a 20 μg di stagno in 50 cm 3 di soluzione.
Fsnilfluoron non è un reagente specifico per lo stagno. Germanio (IV), zirconio e afnio, gallio, antimonio (III), molibdeno (VI), tungsteno (VI), niobio, tantalio, titanio e ferro (III), antimonio (V) ns forma un composto colorato con fenilfluorone.
La determinazione dello stagno è inoltre ostacolata da elementi i cui ioni hanno un proprio colore.
Il cromo (VI), il vanadio (V), il manganese (VII) e lo ione nitrato interferiscono con la determinazione dello stagno, poiché ossidano il reagente, e in questo caso appare un colore simile a quello del fenilfluoronato di stagno.
Il fluoro interferisce con la determinazione, poiché lega lo stagno in un complesso più forte.
Gli elementi interferenti vengono separati precipitando idrossido di stagno insieme a idrossido di berillio a pH~9 in presenza di complexone III. In queste condizioni, ferro, titanio, zirconio, afnio e altri elementi si legano in composti forti e complessi.
Poiché quantità significative di acido tetraborico passano dal flusso alla soluzione, che impedisce la completa precipitazione di berillio e idrossido di stagno in presenza di complexone III, i sesquiossidi vengono preliminarmente precipitati con ammoniaca senza aggiunta di berillio e complexone (10). In questo caso, tungsteno e molibdeno sono parzialmente separati.
Lo ione nitrato e il fluoro vengono rimossi durante la decomposizione di un campione di prova.
L'effetto interferente del tantalio (Ta 2 0 5) e del niobio (Nb 2 Oj) con il loro contenuto totale di ns superiore a 1,3 mg nel campione analizzato viene eliminato aggiungendo alla soluzione colorimetrica ossalato di ammonio, che forma composti forti e complessi con la elementi (3). L'influenza di alti contenuti di tantalio e niobio non è stata testata dagli autori.
Per decomporre il campione, viene trattato con acido solforico e fluoridrico, evaporato a secco e il residuo secco viene fuso con una miscela di borace e soda. Con questo metodo di decomposizione, lo stagno viene ossidato a quattro valenza, necessaria per la reazione con il fenilfluorone; l'antimonio è ossidato ad antimonio pentavalente, che non forma un composto colorato con il fenilfluorone; L'acido redoxico viene rimosso e l'intero campione (compresa la cassiterite, il minerale di stagno più comune e poco solubile) diventa solubile.
5. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA, TUTELA DELL'AMBIENTE
Quando si eseguono misurazioni della frazione di massa dello stagno, è necessario osservare i requisiti di sicurezza quando si lavora con reagenti chimici secondo GOST 12.1.007, i requisiti di sicurezza elettrica quando si lavora con impianti elettrici secondo GOST 12.1.019. I locali del laboratorio devono essere conformi ai requisiti di sicurezza antincendio
temperatura dell'aria ambiente, °С 20±5;
Pressione atmosferica, kPa (mm Hg) 101 ±4 (760±30);
umidità relativa dell'aria, % 65±15;
tensione di rete, V 220±22;
Frequenza AC, Hz 50± I.
8. CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE
Il campionamento viene effettuato secondo la normativa del cliente
documenti.
Al momento del campionamento, viene redatto un documento di accompagnamento nel modulo approvato, che indica:
Lo scopo dell'analisi,
Luogo, ora di selezione,
Numero del campione
■ posizione, nome del campionatore, data.
La preparazione e la conservazione dei campioni vengono eseguite secondo OST 41-08-249-85.
9. PREPARAZIONE ALLE MISURE
In preparazione alle misurazioni, vengono eseguiti i seguenti lavori:
9.1. Preparazione del dispositivo per il lavoro.
La preparazione dello spettrofotometro o del fotocolorimetro per il funzionamento e l'ottimizzazione delle condizioni di misurazione viene eseguita secondo le istruzioni per l'uso degli strumenti. I dispositivi devono essere verificati.
92. Preparazione di soluzioni ausiliarie.
9.2.1. Preparazione della soluzione di acido solforico diluita 1:1.
Un uguale volume di acido solforico viene aggiunto lentamente al volume di acqua distillata, raffreddato, agitato. La durata è di un anno.
92.2. Preparazione di una soluzione di acido solforico, diluita 1:3.
Un volume di acido solforico viene aggiunto lentamente a tre volumi di acqua distillata, raffreddata, agitata. La durata è di un anno.
922. Preparazione di soluzione di acido solforico, diluita 1:9.
Un volume di acido solforico viene aggiunto a nove volumi di acqua distillata, raffreddata, agitata. La durata è di un anno.
92A. Preparazione della soluzione di acido cloridrico, diluita 1:1.
Mescolare volumi uguali di acqua distillata e acido cloridrico. La durata è di un anno.
9.2.5. Preparazione della soluzione di acido cloridrico, diluita 1:10.
A dieci volumi di acqua distillata aggiungere un volume di acido cloridrico, raffreddare, mescolare. La durata è di un anno.
9.2.6. Preparazione della soluzione di ammoniaca diluita 1:1.
Mescolare volumi uguali di acqua distillata e ammoniaca. La durata è di un anno.
9.2.7. Preparazione della soluzione di ammoniaca diluita 1:4.
Un volume di ammoniaca viene aggiunto a quattro volumi di acqua distillata. Agitare. La durata è di un anno.
92A. Preparazione di una soluzione di idrossido di sodio al 25%.
Una porzione di idrossido di sodio del peso di 25 g viene sciolta in acqua distillata, il volume della soluzione viene regolato con acqua distillata a 100 cm 3 , raffreddato, agitato. Conservare in un recipiente di polietilene con tappo a vite per 1 anno. La soluzione deve essere trasparente.
9.2.9. Preparazione di una soluzione al 4% di ossalato di ammoniaca.
Il sale del peso di 4 g di sale viene sciolto in acqua distillata, il volume della soluzione viene regolato con acqua distillata a 100 cm 3 , miscelato. La durata è di un anno.
9.2.10. Preparazione di una soluzione di solfato di berillio contenente - 10 mg di Be
Una porzione di BeS0 4 -4H 2 0 del peso di 19,7 go una porzione di BeCl 2 4H 2 0 del peso di 16,9 g viene sciolta in 20-30 cm 3 di acido cloridrico e il volume della soluzione viene regolato con acqua distillata a 100 cm 3 . La durata è di un anno.
9.2.11. Preparazione di una soluzione di cloruro ferrico contenente - 10 mg Ke 2 0 * in
Una porzione di FeCl 3 del peso di 2 g viene sciolta in 100 cm 3 di acido cloridrico, diluito 1:10. La durata di conservazione è un obiettivo.
9.2.12. Preparazione di una soluzione al 15% di complexone III.
Una porzione di complexon III del peso di 150 g viene sciolta in 1 dm 3 di ammoniaca, diluita 1:4, miscelata. La durata è di un anno.
9.2.13. Preparazione di una soluzione allo 0,03% di fenilfluorone.
Una porzione di fenilfuorone del peso di 0,15 g viene sciolta riscaldando a bagnomaria in 450 cm 3 di alcol, a cui sono stati preventivamente aggiunti 2 cm 3 di acido solforico 1:1. L'alcol viene aggiunto alla soluzione raffreddata fino a un volume di 500 cm 3, lasciato per una notte e filtrato.
attraverso un filtro a secco in un matraccio asciutto, scartando le prime porzioni del filtrato. La durata di conservazione della soluzione è di un anno. La soluzione deve essere trasparente.
9.2.14. Preparazione di una miscela per fusione, composta da borace e soda in un rapporto di 1: 2.
Un campione di borace disidratato a 300-400°C viene accuratamente macinato con soda in un mortaio di porcellana. Il composto pestato viene mescolato per ottenere un composto omogeneo in un barattolo di vetro capiente con tappo macinato. La durata è di un anno.
9.2.15. Preparazione di una soluzione di gelatina allo 0,5%.
Una porzione di gelatina del peso di 0,5 g viene sciolta in 100 cm 3 di acqua distillata, riscaldata a 60-70°C. La soluzione viene filtrata. Utilizzare il giorno della preparazione.
9.2.16. Preparazione dello 0,1% soluzione acquosa indicatore (cainitrofenolo.
100 mg dell'indicatore vengono sciolti in 100 cm 3 di acqua distillata. Periodo di validità I
9.3. Preparazione della soluzione di calibrazione di stagno.
9.3.1. Preparazione della soluzione A.
Una porzione di stagno metallico chimicamente puro del peso di 0,1000 g viene sciolto riscaldando in acido solforico -10 cm 3 1:1, evaporato fino alla comparsa di vapore di acido solforico, le pareti del vetro vengono lavate con acqua distillata e nuovamente evaporate a vapore di acido solforico. La soluzione raffreddata viene trasferita in un matraccio tarato da 100 cm 3 e rabboccata con acido solforico diluito 1:3. Periodo di validità 1 anno. La soluzione deve essere trasparente.
In I cm 3 la soluzione A contiene 1000 μg di stagno.
9JJ. Preparazione della soluzione B.
10 cm 3 di soluzione A vengono posti in un matraccio tarato da 100 cm 3 e rabboccati con acido solforico 1:9. La durata è di cinque mesi. La soluzione deve essere trasparente.
I cm 1 di soluzione B contiene 100 μg di stagno.
933. Preparazione della soluzione B.
10 cm 3 di soluzione B vengono posti in un matraccio tarato da 100 cm 3 e rabboccati con acido solforico 1:9. La durata è di un mese. La soluzione deve essere trasparente.
1 cm 1 di soluzione B contiene 10 μg di stagno.
9.4. Costruzione di grafici di calibrazione.
In bicchieri della capacità di 300 cm 3 porre 2 g della miscela per fusione, circa 40 cm 3 di acido cloridrico 1:1, 1 cm 1 di soluzione di cloruro ferrico e 0; 2.5; 5.0; 7.5; 10.0; 15.0; 20,0 cm 3 di soluzione standard B contenente 10 μg di stagno in 1 cm 3 (0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0; 150,0; 200,0 μg di stagno). Gli idrossidi metallici vengono quindi precipitati con ammoniaca e quindi continuano come indicato durante l'analisi. Per la fotografia si prelevano 5 cm 3 di ciascuna soluzione (0; 2.5; 5.0; 7.5; 10.0; 15.0; 20.0 µg di stagno in un volume colorimetrico) e si prosegue come descritto durante l'analisi. La densità ottica viene misurata dopo 2 ore ma relativa alla soluzione zero su un fotocolorimetro in una cuvetta da 20 mm con un filtro luce blu-verde (X pml = 490-500 nm). La densità ottica è tracciata lungo l'asse y e la concentrazione di stagno in 50 cm 3 della soluzione è tracciata lungo l'ascissa.
9L Controllo della stabilità della caratteristica di calibrazione.
Il controllo della stabilità delle caratteristiche di calibrazione viene effettuato contemporaneamente alla misura delle soluzioni analizzate. I mezzi di controllo sono soluzioni preparate per la calibrazione (almeno tre soluzioni corrispondenti in termini di concentrazione di stagno all'incirca all'inizio, al centro e alla fine della curva di calibrazione).
La caratteristica di calibrazione è considerata stabile se per la calibrazione di ciascuna soluzione è soddisfatta la seguente condizione:
dove C è il risultato di una misura di controllo della concentrazione in massa di stagno nella soluzione di calibrazione;
C, - il valore della concentrazione in massa di stagno nella soluzione di calibrazione;
D è il valore della caratteristica di errore corrispondente alla concentrazione in massa di stagno nella soluzione di calibrazione (C c). I valori di D sono riportati in tabella. uno.
Se la condizione per la stabilità della caratteristica di calibrazione non è soddisfatta per una sola soluzione di calibrazione, è necessario rimisurarla per eliminare il risultato contenente un errore grossolano.
Se la caratteristica di calibrazione non è stabile, scoprire i motivi dell'instabilità della caratteristica di calibrazione e ripetere il controllo della sua stabilità utilizzando altre soluzioni di calibrazione previste dalla procedura. Quando viene rilevata nuovamente l'instabilità della caratteristica di calibrazione, viene costruita una nuova dipendenza da una nuova serie di soluzioni di calibrazione.
10. ESECUZIONE DELL'ANALISI
Quando si eseguono misurazioni del contenuto di stagno, vengono eseguite le seguenti operazioni.
10.1. Decomposizione del campione.
Una porzione del materiale analizzato del peso di 0,1-0,5 g viene posta in un crogiolo di platino o in una coppetta di platino, si aggiungono 10-15 cm 3 di acido fluoridrico e si scalda per 1-2 ore. Al residuo evaporato a secco, aggiungere 3-4 cm 3 di acido solforico 1:1 e riscaldare fino a quando compaiono densi fumi di acido solforico.
Il crogiolo viene lasciato raffreddare, le pareti del crogiolo (o tazza) vengono lavate con acqua distillata fredda, agitate e nuovamente riscaldate fino a cessare il rilascio dei vapori di acido solforico. Al residuo secco si aggiungono 2 g della miscela di fusione e si fonde accuratamente a 900°C in un forno a muffola. La massa fusa nel crogiolo (o tazza) viene distribuita mediante movimento rotatorio in uno strato sottile uniforme sulle pareti. Il crogiolo raffreddato con il contenuto viene posto in un becher con un volume di 300 cm 3 , si aggiungono 15-30 cm 3 di acqua distillata, 20 cm 3 di acido cloridrico concentrato e si scalda fino a dissoluzione della lega. Il crogiolo viene rimosso dalla soluzione e risciacquato accuratamente con acqua distillata.
10.2. Separazione dello stagno dagli elementi interferenti.
Gli idrati di ossidi misti vengono precipitati con ammoniaca per separare la maggior parte del boro che è passato in soluzione dal flusso. Ad una soluzione riscaldata ad ebollizione, aggiungere
diluire 1:1 la soluzione di ammoniaca fino a quando appare l'odore e un eccesso di 1-1,5 cm ji . La soluzione insieme al precipitato viene lasciata per 10-15 minuti su una piastra calda per coagulare il precipitato e filtrata attraverso un filtro a "nastro bianco". Il precipitato sul filtro viene lavato più volte con acqua distillata calda con aggiunta di ammoniaca. Il precipitato lavato viene accuratamente lavato via dal filtro con acqua distillata calda nel becher in cui è stata effettuata la precipitazione, nello stesso becher si aggiungono 20 cm 1 di acido cloridrico facendo passare acido cloridrico attraverso il filtro. 0,5 cm 3 di una soluzione di sale di berillio, 10 cm 3 di una soluzione di complessone III vengono aggiunti alla soluzione in un bicchiere e portati a bollore. La soluzione di ammoniaca 1:1 viene aggiunta alla soluzione calda fino a odore forte e un eccesso di 5-8 cm 3 a pH=9 (verificare con carta indicatrice universale!). Quindi, 1-2 gocce di una soluzione di sale di berillio vengono aggiunte alla soluzione con un precipitato, mescolate energicamente, lasciate per 10 minuti (ma non di più) per piastrelle calde per coagulare il precipitato e controllare immediatamente il pH della soluzione. Se il pH è maggiore o minore di 9, viene aggiunta ammoniaca o acido cloridrico. Le soluzioni vengono lasciate per 1,5-2 ore per il completo rilascio di idrossido di berillio. La soluzione fredda viene filtrata attraverso un filtro a "nastro bianco" del diametro di 7 cm, lavata accuratamente con acqua distillata con aggiunta di ammoniaca (pH=9) e lasciata sul filtro per 30 minuti per scaricare l'acqua. Il residuo lavato viene lavato via dal filtro espanso con acido solforico caldo diluito 1:9 nel becher in cui è stata effettuata la precipitazione e, dopo raffreddamento, trasferito con lo stesso acido in un matraccio tarato da 50 cm 3 .
10.3. Fotografia.
Per l'analisi si prelevano 5 cm 3 della soluzione, posti in un matraccio tarato da 50 cm 3 (se sono stati prelevati meno di 5 cm 3 aggiungere acido solforico 1:9 a 5 cm 3), aggiungere 3 gocce di una soluzione di indicatore 0-dintrofsnol e goccia a goccia con cautela soluzione di idrossido di sodio al 25 % fino a quando il colore della soluzione non cambia da incolore a leggermente giallo. Alla soluzione si aggiungono quindi 4 cm 3 di una soluzione al 4% di ossalato di ammonio e 4 cm 3 di acido solforico 1:9. Dopo aver aggiunto ogni reagente, la soluzione viene agitata. Con cautela, lungo la parete, per non mescolare la soluzione, aggiungere 2 cm 3 di una soluzione allo 0,5% di gelatina e subito 3 cm 3 di una soluzione allo 0,03% di fenilfluorone. La soluzione viene agitata, rabboccata con acqua distillata fino alla tacca e mescolata nuovamente.
Contemporaneamente si prepara una soluzione “zero”: in un matraccio tarato da 50 cm 3 vengono posti 5 cm 3 di acido solforico 1:9 e tutte le soluzioni vengono poste nello stesso ordine.
Due ore dopo, la densità ottica della soluzione viene misurata su fotocolorimstrs a X* id =490-500 nm in una cuvetta con uno spessore dello strato di 20 mm rispetto alla soluzione "zero".
11. ELABORAZIONE (CALCOLO) DEI RISULTATI DELL'ANALISI
Il calcolo dei risultati dell'analisi per determinare il contenuto di stagno viene effettuato come segue:
11.1 La frazione di massa (in%) di stagno è calcolata con la formula:
1 Se contemporaneamente il precipitato non cade o cade in quantità insignificante, aggiungere 1 cm* di una soluzione di cloruro ferrico
In pratica, tutte le conquiste della chimica analitica come scienza si realizzano nel suo prodotto finale - tecnica di analisi chimica oggetto specifico.
Esistono metodi di analisi chimica qualitativa e metodi di analisi chimica quantitativa della sostanza dell'oggetto di analisi. Le procedure di analisi chimica qualitativa e quantitativa possono essere descritte in sequenza in un metodo.
Metodo di analisi chimica sostanze dell'oggetto di analisi: un documento in cui, secondo il metodo di analisi utilizzato, è descritta una sequenza di operazioni e regole, la cui attuazione garantisce l'ottenimento risultato dell'analisi chimica una sostanza specifica di uno specifico oggetto di analisi con stabilito caratteristiche di errore o incertezza per i metodi di analisi quantitativa e per i metodi analisi qualitativa- con comprovata affidabilità.
Il risultato dell'analisi chimica può essere presentato, ad esempio, come segue: secondo il metodo dell'analisi qualitativa, conducendo reazioni qualitative, è stato stabilito che con una certezza del 100% c'è ferro nel campione della sostanza minerale del Bakcharskoye depositare; secondo il metodo dell'analisi quantitativa mediante dicromatometria, è stato stabilito che il contenuto di ferro nel campione della sostanza minerale del deposito di Bakcharskoe è (40 ± 1)% con un livello di confidenza di 0,95.
Ogni metodo di analisi chimica si basa sull'uso di un metodo qualsiasi di analisi chimica.
Esempi di nomi di metodi di analisi chimica:
Metodo per misurare le concentrazioni di massa di ioni cadmio, rame e piombo in acqua potabile, naturale e liquame metodo della voltammetria di stripping .
Metodologia per eseguire misure di concentrazione di massa policlorurato dibenzo-p-diossine e dibenzofurani in campioni aria atmosferica mediante spettrometria di massa cromatografica.
Metodo per eseguire misurazioni della frazione di massa dei metalli pesanti nei suoli e nei suoli utilizzando analizzatori fluorescenti a raggi X del tipo X‑MET, METOREX (Finlandia).
L'analisi chimica di una sostanza è un processo complesso a più stadi, viene eseguita in una determinata sequenza, che di solito è descritta nella metodologia di analisi. oggetto specifico.
L'analisi di qualsiasi campione di una sostanza, compresi i campioni della sostanza di oggetti ambientali, viene eseguita in una determinata sequenza delle sue fasi:
1. Campionamento di una sostanza (in campo ecologico);
2. Ottenere un laboratorio rappresentativo e un campione analitico dell'analita;
3. Preparazione del campione dell'analita per la misura del segnale analitico;
4. Creazione delle condizioni per le misurazioni e predisposizione degli strumenti di misura;
5. Preparazione della sostanza di riferimento (standard);
6. Effettuare misurazioni dirette del segnale analitico degli standard e predisporre un metodo per il confronto con lo standard quando si applicano metodi fisici di analisi;
7. Effettuare misurazioni dirette del segnale analitico del campione analizzato della sostanza;
8. Elaborazione dei risultati delle misurazioni dirette - identificazione dei componenti e calcolo del contenuto dell'analita nel campione dell'analita (misure indirette);
9. Valutazione dell'accettabilità del risultato dell'analisi chimica verificandone la precisione (ripetibilità, riproducibilità) e la correttezza;
10. Registrazione dei risultati dell'analisi chimica del campione della sostanza dell'oggetto dell'analisi.
L'ecologo è obbligato a utilizzare i servizi laboratori analitici, accreditato per il diritto di eseguire analisi chimiche di sostanze ambientali Un laboratorio accreditato è un laboratorio giuridicamente indipendente i cui dipendenti hanno ripetutamente confermato la propria competenza tecnica. La metodologia dovrebbe essere classificata come standard nazionale (GOST) o industriale (OST) o documento di settore (RD, PND F).
Un esempio di requisiti per i documenti organizzativi per la protezione dell'aria atmosferica nel laboratorio di un'impresa per il controllo impatto negativo sull'ambiente. Il laboratorio deve disporre dei seguenti documenti:
Regolamento sul laboratorio, il suo passaporto;
Documenti sull'accreditamento (attestazione);
Certificati di verifica degli strumenti di misura da parte delle autorità metrologiche statali
Passaporti per campioni standard statali della composizione e delle proprietà degli oggetti controllati;
Risultati del controllo di qualità interno ed esterno delle misurazioni eseguite;
Atti di campionamento e registri della loro registrazione;
Metodi di misurazione certificati;
Registri dei risultati del monitoraggio dell'impatto ambientale.
Il risultato di un'analisi chimica quantitativa di un campione di una sostanza, compreso un oggetto ecologico, viene espresso attraverso frazione di massa w (A) o concentrazione di massa del componente A, C m (A) determinato.
Un ecologista, ad esempio, quando valuta l'inquinamento di una sostanza di oggetti ambientali, sottopone per l'analisi chimica a un laboratorio di analisi campioni selezionati di sostanze solide, liquide, gassose o eterofasiche di peso fino a 1 kg. È interessato alla composizione chimica completa o al contenuto di uno o più componenti (sotto forma di atomi, isotopi, ioni, molecole o gruppi di molecole con le stesse proprietà) nel campione della sostanza dell'oggetto di analisi - in suoli, nelle piante, nei sedimenti di fondo, nelle acque naturali, nell'aria atmosferica e altri oggetti ecologici.
Frazione di massa w (A) componente Aè il rapporto di massa m (A) componente MA, sostanza presente nel campione massa totale campioni di sostanze, m (cosa), che è andato all'analisi:
w (A) \u003d m (A) / m(articolo), con / r
Frazione di massa del componente MA in un campione di una sostanza può essere convertito nella sua percentuale:
w (A) \u003d × 100,%
Frazione in volume della componente liquida MA in un campione di una sostanza liquida o di un componente gassoso MA in un campione di una sostanza gassosa si calcola come:
w (A) \u003d 100,%,
dove V (A) - volume del componente liquido o gassoso MA in totale V totale campioni di una sostanza liquida o gassosa;
Nella pratica internazionale, usano il modo di esprimere la frazione di massa come parte di un componente in un gran numero di altre parti:
parti per cento , %, pph, g∙100/kg;
parti per mille , ‰, ppt, g/kg;
parti per milione , ppm, mg/kg, g/t;
parti per miliardo , ppb, μg/kg, mg/t;
Per quantificare il contenuto del componente MA nella materia liquida e gassosa, il concetto concentrazione dei componenti MA.
Concentrazione del componente A (CIRCA)) è un valore che caratterizza il contenuto relativo di un dato componente in una sostanza multicomponente ed è definito come il rapporto tra il numero di particelle componenti MA(concentrazione molare del componente MA, concentrazione molare del componente equivalente MA) o la massa del componente MA ( concentrazione di massa del componente MA), relativo ad un determinato volume di sostanza liquida o gassosa.
La concentrazione di un componente è sempre un valore denominato, ha senso per il componente MA nome specifico. Ciò si riflette anche nella definizione di concentrazione, che sottolinea che si tratta del contenuto relativo di un dato componente nel volume di una sostanza liquida o gassosa multicomponente.
L'unità di misura di base per il numero di particelle di un componente (n) nel Sistema internazionale di unità quantità fisiche(Sistema SI), adottato per l'uso in URSS nel 1984, è 1 mol. 1 mol particelle di qualsiasi componente che ci interessa sotto forma di unità chimiche strutturali come atomo (elemento), isotopo, gruppo funzionale, incluso uno ione, o molecola, contiene 6.022 × 10 23 tali particelle in qualsiasi volume o massa di materia. millesima parte 1 mol(unità multipla) è indicato mmol ( leggere millimole).
Numero di particelle componenti MA (n / a)) in qualsiasi massa del componente MA (m(A)) calcolato con la formula:
n (A) \u003d m (A) / M (A), mol,
dove m (LA) - massa componente A, g; M (LA) - massa molare relativa del componente A, g/mol;
Nel sistema internazionale di unità di quantità fisiche, secondo GOST 8.417-2002 “GSI. Unità di quantità", sono i nomi principali per la concentrazione di componenti nel volume di una sostanza liquida o gassosa concentrazione molare del componente, mol / m 3, e concentrazione di massa del componente, kg/m3.
Concentrazione molare del componente A in soluzione – C m (LA) -è il contenuto del numero di particelle del componente A n (A) per unità di volume V
C m (A) \u003d n (A) / V; o C m (A) \u003d m (A) / [M (A) V . ]
La concentrazione molare di un componente viene misurata in mol / m 3; mol/dm 3, mmol/dm 3 mol/l.)
Un esempio di modulo di registrazione nei documenti: C m (NaCl) \u003d 0,1 mol / dm 3 \u003d 0,1 mmol / cm 3 (in pratica analitica per uso interno utilizzare anche la seguente forma di scrittura: 0.1 M NaCl).
Sia nella pratica analitica che in vari tipi di attività professionali, inclusa l'ecologia, viene utilizzata la concentrazione espressa in unità di massa.
Concentrazione di massa del componente Aè il contenuto di massa m (A) componente MA per unità di volume V sostanza liquida o gassosa, si calcola come:
C m (LA) \u003d m (LA) / V. ,
La concentrazione di massa del componente è misurata in kg/m3; vengono utilizzate anche unità sottomultiple - g/m3, g/dm 3, mg/dm 3 eccetera. (per uso intralaboratorio è consentita un'unità g/l, g/ml).
Un esempio di un modulo di registrazione: C m (NaCl) \u003d 0,1 g / dm 3, (in pratica analitica per uso interno è consentito il modulo di notazione C m (NaCl) \u003d 0,1 g / l \u003d 0,1 mg / ml).
Conoscere la concentrazione di massa del componente MA in soluzione, puoi calcolarne la concentrazione molare e viceversa.
C m (A) \u003d C m (A) / M (A), Se Cm (LA) espresso in g/m3,
C m (A) \u003d C m (A) M (A), Se Cm (LA) espresso in mol/dm 3.
Metodi per esprimere la concentrazione di un componente in una soluzione e la relazione tra vari tipi si danno le concentrazioni Allegato 3.
In ecologia, il contenuto di determinati componenti nei campioni di una sostanza liquida è solitamente espresso attraverso la concentrazione di massa in unità g/dm 3, mg/dm 3, mcg / dm 3, in campioni di una sostanza gassosa - in unità g / m 3, mg / m 3 μg / m 3.
La massa del campione m (cosa) può essere misurato con la precisione richiesta su una bilancia analitica, il volume V può essere misurato con la precisione richiesta utilizzando strumenti di misurazione. Peso del componente A, m (A), o il numero di particelle del componente A, n (A), è impossibile misurare direttamente le sostanze presenti nel campione, esse possono essere misurate solo indirettamente (calcolate utilizzando l'apposita formula, ricavata dal grafico di calibrazione). A tal fine, vari metodi di analisi chimica quantitativa.
R 50.2.008-2001
Sistema di sostegno statale
unità di misura
TECNICHE PER LA QUANTITATIVA
ANALISI CHIMICA
GOSTANDART DI RUSSIA
Mosca
Prefazione
1 SVILUPPATO dall'Istituto statale di ricerca metrologica dell'impresa unitaria tutta russa. DI. Stendardo statale di Mendeleev della Russia
INTRODOTTO dal Dipartimento di metrologia dello standard statale della Russia
2 ADOTTATO E INTRODOTTO CON Decreto dello standard statale della Russia del 20 giugno 2001 n. 244-st
3 INTRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA
R 50.2.008-2001
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni
TECNICHE DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA
Data di introduzione 01-01-2002
1 area di utilizzo
Queste raccomandazioni sono destinate ai centri metrologici scientifici statali che conducono l'esame metrologico di documenti per i metodi di analisi chimica quantitativa (di seguito denominato esame metrologico del MKCA) in conformità con GOST R 8.563.
2 Riferimenti normativi
GOST 8.221-76 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Umidità e igrometria. Termini e definizioni
a) un documento o una bozza di documento che regola l'ICCA;
b) termini di riferimento per lo sviluppo dell'ICA o altro documento contenente i dati iniziali per lo sviluppo (tranne quando i dati rilevanti sono contenuti in standard statali, interstatali o internazionali applicabili all'oggetto analizzato);
c) copia del certificato di certificazione metrologica dell'ICCA (se effettuata). Contestualmente, il Richiedente può presentare ulteriori materiali: il programma ed i risultati (sotto forma di relazioni, protocolli) della valutazione sperimentale o computazionale delle caratteristiche metrologiche del MKCA, documenti normativi (anche dipartimentali) che disciplinano il controllo di l'accuratezza dei risultati di misurazione, ecc. Inoltre, vengono presentati materiali aggiuntivi Richiedente su richiesta dell'SSMC che conduce l'esame (vedi).
Qualora il Richiedente ritenga necessario formulare domande per l'esame, queste devono essere formulate per iscritto (ad esempio, in lettera di presentazione al GNMC).
5 Contenuto dell'esame metrologico dell'ICAC
5.1 Nel caso generale, durante l'esame metrologico, l'MKCA viene sottoposto ad analisi critica (valutare):
La correttezza dei nomi delle grandezze misurate e le designazioni delle loro unità;
Scelta degli strumenti di misura (compresi campioni standard);
Conformità delle caratteristiche metrologiche dell'MKCA ai requisiti specificati;
Procedure per il monitoraggio dell'errore dei risultati di misurazione;
Completezza della dichiarazione dei requisiti, delle regole e delle operazioni;
Correttezza dei termini metrologici.
5.2 Su richiesta del Richiedente o in connessione con le peculiarità dello scopo dell'ICCA, durante l'esame metrologico possono essere presi in considerazione altri aspetti, ad esempio: il livello metrologico di tale tecnica in relazione ad altri metodi aventi analogo scopo, il prospettive di standardizzazione dell'ICCA, la razionalità nella scelta del metodo di analisi.
6 La procedura per l'esame metrologico dell'ICCA
6.1 L'esame metrologico del MKCA è effettuato da un esperto o da un gruppo di esperti autorizzato dal capo (vice capo) del SSMC.
Un esperto può essere un dipendente dell'SSMC che ha lavorato in esso per almeno tre anni, ha esperienza nell'attestazione (sviluppo) di almeno cinque IAC e ha familiarità con i documenti normativi nazionali e internazionali relativi alla garanzia dell'uniformità delle misurazioni. È preferibile che l'esperto (capofila del gruppo di esperti) abbia una formazione superiore di base nel campo della chimica e sia un esperto certificato del Sistema di Accreditamento dei Laboratori (Centri) analitici. L'esperto deve essere consapevole principi generali e metodi per stimare gli errori di misurazione -, caratteristiche dell'ACC come procedura di misurazione, metodi e tecniche specifici per garantire l'affidabilità dei risultati dell'ACC -, il ruolo e il ruolo dell'ACC nel monitoraggio della qualità del prodotto e dello stato degli oggetti ambientali -. L'esperto dovrebbe migliorare sistematicamente le sue qualifiche, in particolare, conoscere le pubblicazioni pertinenti in periodici scientifici e tecnici specializzati.
Gli esperti sono responsabili della corretta, obiettiva e tempestiva esecuzione del lavoro, nonché della non diffusione di informazioni riservate. Il capo del gruppo di esperti formula compiti per i membri del gruppo, riassume le loro valutazioni e opinioni.
6.2 L'esame metrologico del MKCA comprende le seguenti fasi:
Registrazione dei documenti presentati per l'esame;
Analisi preliminare dei documenti;
Richiesta di ulteriori documenti (se necessari), loro registrazione;
Valutare la conformità dell'ICCA ai requisiti metrologici;
Redazione di una perizia, sua approvazione e trasferimento al Richiedente.
6.3 I documenti ricevuti per l'esame metrologico sono registrati in un giornale, la cui forma raccomandata è data. È consentito combinare la registrazione di documenti presso l'ICCA con la registrazione di altri tipi di documenti soggetti a esame metrologico, ad esempio bozze di norme.
7.2.5 Nel presentare l'ICCA che regola la misurazione di più grandezze che caratterizzano la composizione chimica, viene talvolta utilizzato il loro nome generico: “contenutoio ]. Nell'esaminare tale ICCA, è necessario assicurarsi che l'uso di un nome generico non comporti una riduzione o distorsione delle informazioni di misurazione, non crei prerequisiti per interpretazioni diverse del testo ICCA. Un nome generico non dovrebbe essere utilizzato quando si descrivono compiti di misurazione specifici, quando si indicano le caratteristiche metrologiche, nonché nelle spiegazioni delle formule di calcolo e quando si riportano i risultati della misurazione.
7.2.6 Le unità dei valori misurati devono essere conformi a GOST 8.417, tenendo conto del documento normativo.
7.2.7 Esempi di errori tipici:
a) “La quantità di zinco in 10 cm 3 di una soluzione è 15 mmol” invece della corretta “La quantità di sostanza di zinco in 10 cm 3 di una soluzione è 15 mmol”;
b) “Ossigeno disciolto 60 µmol / dm 3” invece della corretta “Concentrazione molare di ossigeno disciolto 60 µmol, dm 3”;
d) “Numero di ioni cadmio nella soluzione di calibrazione 2,00 μg/5 cm 3 ” invece del corretto “Massa di cadmio in 5 cm 3 della soluzione di calibrazione 2,00 μg”;
e) "Residuo secco in acqua 5 mg / 100 g" invece della corretta "Frazione di massa del residuo secco in acqua 0,05%".
7.3 Valutazione della scelta degli strumenti di misura
a) conformità delle finalità applicative dello strumento di misura prescelto (compreso il campione standard) con la finalità fissata nella descrizione del tipo o nella documentazione tecnica degli strumenti di misura;
b) la possibilità di utilizzare uno strumento di misura in determinate condizioni;
c) realizzabilità dell'accuratezza richiesta dei risultati di misura quando si utilizza uno strumento di misura con caratteristiche metrologiche stabilite per questo tipo;
d) la razionalità nella scelta degli strumenti di misura;
e) il rispetto dei requisiti per gli strumenti di misura utilizzati nel campo della distribuzione del controllo e della supervisione metrologica statale.
7.3.2 Le informazioni sullo scopo e sulle caratteristiche principali degli strumenti di misura dei tipi approvati possono essere prese in prestito dalle descrizioni dei tipi, dalle pubblicazioni nelle riviste "Izmeritelnaya Tekhnika", "Legislative and Applied Metrology", nonché dai database formati da VNIIMS ( per strumenti di misura) e UNIIM (per campioni di standard statali).
7.3.3 La realizzabilità dell'accuratezza richiesta viene valutata calcolando i limiti della corrispondente componente strumentale dell'errore dei risultati di misura e confrontando il valore trovato con i limiti (confini) dell'errore specificati nel documento per l'MKCA. Questa procedura è sufficiente nei casi in cui la componente strumentale dell'errore prevale su quella metodologica.
Esempi di errori rilevati:
a) Per misurare l'altezza del picco cromatografico si utilizza un righello con un valore di divisione di 1 mm; limiti di tolleranza ± 0,5 mm. L'altezza del picco del componente determinato, corrispondente al limite inferiore della concentrazione di massa del componente nell'oggetto analizzato, è» 4 mm. I limiti dell'errore relativo di misurazione dell'altezza del picco in questo caso saranno ± 12%, che chiaramente non corrisponde all'errore assegnato caratteristico del risultato della misurazione della concentrazione in massa del componente ± 10%, indicato nel documento per il MKCA.
b) Il metodo per misurare la concentrazione in massa di un componente nelle emissioni di un'impresa industriale prevede il prelievo di un campione di gas mediante aspiratore (a valore costante della sua portata volumetrica di 4 dm 3 /min) in una soluzione di assorbimento e successiva analisi della soluzione con il metodo fotocolorimetrico. La norma per i limiti dell'errore relativo nella misurazione della concentrazione di massa di un componente durante il monitoraggio delle sorgenti di inquinamento atmosferico è ± 25%. I limiti dell'errore relativo nell'analisi della soluzione assorbente con il metodo fotocolorimetrico sono generalmente del 10% - 20%. Per misurare la portata volumetrica del flusso di gas, un rotametro con limite superiore misure di 20 dm 3 /min e limiti dell'errore di base ammissibile ridotto ± 5%. I limiti dell'errore relativo delle misure di portata volumetrica (con l'introduzione delle correzioni) saranno ± 25%. Il confronto dei valori dei componenti dell'errore con la norma indica l'impossibilità di ottenere la precisione richiesta quando si utilizza il tipo di flussometro selezionato.
7.3.4 Quando si valuta la razionalità della scelta degli strumenti di misura, è possibile utilizzare raccomandazioni , , , nonché GOST R 1.11.
7.3.5 Se l'MKCA è destinato all'uso nel campo della distribuzione del controllo e della supervisione metrologica statale, l'esperto deve assicurarsi che i tipi di strumenti di misura utilizzati siano registrati nel registro statale dei tipi approvati di strumenti di misura, campioni standard - nel registro statale dei tipi approvati di campioni standard.
7.3.6 Si tenga presente che i dispositivi di campionamento e dosaggio utilizzati nell'ICA possono avere o lo stato di strumenti di misura o lo stato di apparecchiature ausiliarie. In quest'ultimo caso, la valutazione non viene effettuata.
7.3.7 Insieme a sostanze e materiali che hanno lo status di strumenti di misura (materiali di riferimento per la composizione e le proprietà di sostanze e materiali secondo , materiali di riferimento VNIIM secondo , miscele certificate secondo ), sostanze pure e reagenti prodotti secondo gli standard e le specifiche possono svolgere le funzioni di misure nelle condizioni del produttore dell'ICCA (sostanze di composizione nota secondo), nonché sostanze pure, soluzioni, miscele ottenute secondo la procedura regolata nel documento per l'ICCA.
7.4 Valutazione della conformità delle caratteristiche metrologiche del MEXA ai requisiti specificati
a) i termini di riferimento per lo sviluppo dell'ICCA o altri documenti, i cui requisiti si applicano al presente ICCA. (Tali documenti possono essere standard, specifiche, linee guida, programmi di test, ecc.);
b) GOST R 8.563 - in termini di indicazione dell'intervallo di misurazione e della forma di presentazione delle caratteristiche dell'errore.
Il compito dell'esperto è anche quello di identificare caratteristiche attribuite inattendibili all'errore di misurazione o conclusioni errate sulla conformità dell'errore di misurazione agli standard stabiliti.
7.4.2 Gli intervalli di misurazione (campi di valori della quantità misurata) indicati nel documento per l'MKCA e le caratteristiche di errore assegnate vengono confrontati con i requisiti indicati nei documenti su, elenco a).
Esempi : Le caratteristiche metrologiche dell'MKHA delle acque naturali e reflue vengono confrontate con i requisiti di GOST 27384 e GOST 8.556, le caratteristiche metrologiche dell'MKHA dell'aria atmosferica vengono confrontate con i requisiti di GOST 17.2.4.02.
7.4.3 Se i requisiti per l'errore non sono stabiliti in modo esplicito, i limiti (limiti) dell'errore specificati nel documento per l'MKCA vengono confrontati con una tolleranza per un valore controllato.
Esempio . Le specifiche tecniche del prodotto chimico indicano che la frazione in massa del componente impurezza "B" (win) non deve superare lo 0,50%. Durante il controllo, è necessario distinguere in modo affidabile un prodotto di buona qualità dawin= 0,50% e prodotto conwin= 0,51%. Per fare ciò, è necessario ottenere risultati di misurazione il cui errore non superi lo 0,003% (con adeguate giustificazioni economiche - 0,005%).
Linee guida utili per effettuare tali confronti sono fornite nelle raccomandazioni , , ; per l'analisi chimica, la metodologia è descritta in .
7.4.4 A volte gli sviluppatori del MKCA non limitano il range di misura dall'alto, riferendosi alla possibilità di variare la massa del campione prelevato per l'analisi, la sua diluizione, ecc. Questa pratica non soddisfa i requisiti di GOST R 8.563.
Altri esempi di incongruenze:
Indicazione del "limite di rilevamento" al posto del limite inferiore del campo di misura;
Rappresentazione delle caratteristiche dell'errore di misurazione in una forma che non consente di specificarne il valore per ciascuno dei valori della quantità misurata nell'intervallo di misurazione;
Indicazione delle caratteristiche della sola componente casuale dell'errore;
Indicazione dello standard di controllo dell'errore (senza specificare la caratteristica dell'errore).
7.4.5 Se l'esperto dubita dell'affidabilità delle caratteristiche attribuite all'errore di misurazione o della correttezza delle conclusioni sulla conformità dell'errore di misurazione agli standard stabiliti, deve calcolare approssimativamente i limiti di errore. Le fonti di dubbio possono essere esperienza personale e intuizione di un esperto, differenze significative nelle caratteristiche dell'errore rispetto a quelle stabilite per simili ICCA, un algoritmo di elaborazione dei dati chiaramente semplificato, incoerenza nelle caratteristiche e negli standard per il controllo degli errori, ecc.
Nella maggior parte dei casi, è consigliabile eseguire tale calcolo per il valore più piccolo (più grande) della quantità misurata. La metodologia generale di calcolo è descritta in , , gli algoritmi di calcolo sono riportati in , -, in relazione all'analisi chimica - nelle raccomandazioni , . Inoltre, gli esperti possono fare riferimento al documento EURAHIM. L'incertezza estesa calcolata secondo questo documento (a fattori di copertura di 2 e 3) è praticamente uguale al margine di errore a un livello di confidenza di 0,95 e 0,99.
Nell'effettuare i calcoli, l'esperto dovrebbe fare affidamento sui dati sperimentali forniti dal Richiedente, informazioni sulle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura, standard per il controllo delle componenti di errore (se fornite nel documento per l'ICCA).
a) il termine "errore" è utilizzato al posto di "margine di errore" o "margine di errore";
b) il termine “caratteristica di errore” (o “indicatore di accuratezza”) è utilizzato senza specificare per quale caratteristica si intende: “margini di errore”, “limiti di errore” o “deviazione standard di errore”;
c) il termine “margine di errore” è utilizzato con l'indicazione di una probabilità diversa da una;
d) il termine “margine di errore” è utilizzato senza indicare il livello di confidenza;
e) i limiti dell'errore relativo sono indicati con un numero eccessivo di cifre significative (ad esempio ± 19,8% anziché ± 20%);
f) il limite del range di misura è indicato con un numero eccessivo di cifre significative (ad esempio 100,0 mg/dm 3 anziché 100 mg/dm 3);
g) sono indicati i limiti dell'errore di misura relativo della frazione di massa del componente principale del prodotto tecnico senza tener conto dei vincoli imposti dalla modello fisico(± 2,0% per limite superiore del campo di misura 99,5%);
i) i limiti dell'errore relativo del risultato di misura della frazione volumetrica della componente impurezza nel prodotto tecnico sono ± 100%;
j) sono indicati i valori delle caratteristiche della componente casuale dell'errore senza spiegazione delle condizioni a cui corrispondono (ad esempio condizioni di convergenza, riproducibilità intra o interlaboratorio);
k) la caratteristica dell'errore è stabilita solo per la miscela modello più semplice (cioè senza tenere conto dei componenti di accompagnamento reali) o per un intervallo di valori irragionevolmente ristretto di fattori di influenza esterni;
l) la caratteristica dell'errore è stabilita senza tener conto delle fasi di campionamento e preparazione del campione, sebbene tali fasi siano incluse nell'ICA.
7.5 Valutazione delle procedure di controllo dell'incertezza di misura
7.5.1 L'esperto valuta:
Disponibilità di procedure di controllo operativo in ICCA;
La corretta scelta dei mezzi di controllo;
Interconnessione di standard di controllo e caratteristiche di errore di misura.
7.5.2 Va tenuto presente che la procedura di controllo può riguardare tutte le fasi dell'ICCA contemporaneamente (“controllo integrato”) o solo alcune di esse. I metodi per il controllo completo degli errori di misurazione (analisi), nonché la loro convergenza e riproducibilità, sono descritti nella raccomandazione. Il controllo delle singole fasi viene effettuato nei casi in cui un controllo complesso non può essere tecnicamente attuato o è irrazionale. Tale controllo può essere effettuato anche in aggiunta a quello complesso; in questo caso, il più delle volte vengono controllati il grado di separazione o estrazione dei componenti, l'errore nella costruzione della caratteristica di calibrazione e la sua stabilità. In tutti i casi in cui il valore del valore misurato (compreso intermedio) viene calcolato mediando i risultati ottenuti durante misurazioni ripetute (determinazioni), è opportuno controllarne la convergenza.
7.5.3 Il documento per il MKCA non può descrivere le procedure di controllo degli errori, ma deve contenere un'indicazione del controllo in conformità con qualsiasi documento normativo.
Esempio . Quando si analizza bevendo acqua il controllo degli errori può essere eseguito secondo GOST R 51232; quando si analizza l'oro - secondo GOST 27973.0; quando si analizzano le materie prime minerali - secondo lo standard del settore; durante l'analisi dell'acqua naturale nei laboratori di rete di Roshydromet - secondo il documento di orientamento.
7.5.4 Nel valutare la correttezza della scelta dei mezzi di controllo, l'esperto deve prestare attenzione al rapporto tra il limite (limite) dell'errore del risultato della misurazione secondo l'MCA e il limite (limite) dell'errore del controllo. Per garantire l'affidabilità del controllo, questo rapporto, di regola, dovrebbe essere almeno 3 (se esiste una giustificazione adeguata, almeno 2).
Se viene utilizzata una miscela (soluzione) come mezzo di controllo, il cui metodo di preparazione è descritto nell'appendice all'ICA, l'esperto deve calcolare approssimativamente i margini di errore con cui il contenuto dell'analita nella miscela ( soluzione) In questo caso, possono essere applicate raccomandazioni.
Se un campione standard viene utilizzato come mezzo di controllo, la sua categoria dovrebbe corrispondere al campo di applicazione dell'ICCA.
7.5.5 Quando si valuta la relazione tra standard di controllo operativo e caratteristiche dell'errore di misurazione, è consigliabile essere guidati dalla raccomandazione per il controllo integrato, raccomandazioni , - per il controllo dell'errore di costruzione e stabilità della caratteristica di calibrazione. L'esperto dovrebbe prestare attenzione alla chiarezza della formulazione delle condizioni per il controllo della riproducibilità intralaboratorio, poiché lo standard di controllo dipende da quali fattori (tempo, operatore, attrezzatura, calibrazione) variano da analisi ad analisi. Questa dipendenza si verifica anche quando si controlla l'errore con il metodo delle addizioni; metodo di diluizione del campione; un metodo che combina additivo e diluizione. Se l'analisi del campione senza additivo e con l'additivo viene eseguita in condizioni di costanza dei suddetti fattori, lo standard di controllo dell'errore calcolato con il metodo sarà significativamente sovrastimato.
7.5.6 Esempi di errori tipici:
a) i termini "controllo della convergenza dei risultati delle determinazioni", "standard per il controllo della convergenza dei risultati delle determinazioni" sono usati senza indicare quale parametro è controllato: "l'intervallo dei risultati delle determinazioni" , "deviazione del risultato della determinazione dalla media aritmetica...", la deviazione standard delle definizioni dei risultati", "deviazione standard della media aritmetica...", ecc.;
b) è data la discrepanza ammissibile tra i due risultati dell'analisi senza specificare le condizioni per ottenerli e il livello di confidenza;
d) lo standard per "l'intervallo di due risultati di determinazioni parallele, riferito alla media aritmetica ( R = 0,95)”, pari al 30%, non concorda con i limiti dell'errore relativo del risultato dell'analisi ± 10%, R= 0,95 (l'analisi include due determinazioni).
7.6 Valutazione della completezza della dichiarazione dei requisiti, delle regole e delle operazioni
7.6.1 L'esaminatore dovrebbe rivedere le sezioni del documento ICCA e le sue appendici in sequenza. Allo stesso tempo, è consigliabile porre le domande: "Ci sono informazioni sufficienti per condurre un'analisi con l'accuratezza richiesta?", "Ci sono disposizioni in questa sezione che non sono coerenti con i requisiti di GOST R 8.563, altro standard statali, o con altre disposizioni del documento per l'ACI?”, “Non consente questa dicitura varie interpretazioni, che può causare un errore incontrollato?
7.6.2 L'esperto dovrebbe prestare particolare attenzione a quei requisiti (regole, operazioni) che maggiormente influiscono sulla qualità dei dati ricevuti. In questo caso, è necessario ispirarsi alle informazioni disponibili in letteratura sui limiti e le fonti di errore che sono caratteristiche dei metodi di campionamento e di analisi implementati, nonché dalle stime ottenute nel calcolo dei limiti di errore del risultati della misurazione (vedi ).
7.6.3 Le carenze riscontrate più spesso nei documenti per l'ICCA:
Non sono specificate le limitazioni dovute all'interferenza dei componenti del campione;
Non sono stati formulati i requisiti per il contenuto del componente principale nella sostanza pura utilizzata per la preparazione delle miscele di taratura;
La durata di conservazione delle miscele di calibrazione non è stata stabilita;
Non ci sono criteri di qualità della calibrazione;
I criteri per l'identificazione dei componenti, i criteri di separazione (durante l'analisi di campioni multicomponenti mediante cromatografia, spettrometria di massa, spettrofotometria, ecc.) non sono forniti;
Il termine "definizioni parallele" viene utilizzato senza specificare esattamente quali operazioni devono essere ripetute e quali restano comuni;
Le designazioni delle varie grandezze misurate coincidono;
Le designazioni delle quantità incluse nella formula per il calcolo del risultato dell'analisi non vengono decifrate;
Non ci sono requisiti per la formattazione del risultato dell'analisi.
7.6.4 Non è compito dell'esperto eliminare gli errori grammaticali e le imprecisioni stilistiche presenti nel documento presso l'ICCA.
7.7 Validazione dei termini metrologici
7.7.1 I termini metrologici devono essere conformi a GOST R 1.12 e.
7.7.2 Nei documenti ICCA, i termini “analizzato”, “determinato”, “misurabile”, “controllato” sono spesso usati come sinonimi, il che crea incertezza nelle interpretazioni. Quando si elaborano conclusioni, è consigliabile che gli esperti utilizzino le seguenti frasi fisse:
Campione analizzato, sostanza analizzata (materiale), oggetto di analisi;
Il componente in fase di definizione;
Valore misurato;
Parametro controllato, standard di controllo.
7.7.3 Nel regolamento dell'ICA, che prevede l'esecuzione ripetuta di una sequenza di operazioni, diventa necessario utilizzare due termini, uno dei quali si applica ad una singola sequenza di operazioni, l'altro - alla totalità di tali sequenze . In questi casi si utilizzano le combinazioni di termini: “osservazione e misura”, “misura singola” e “due (tre) misure multiple”, “misurazione singola” e “misurazione multipla” (se il numero di misure è quattro o più) , “determinazione singola” (o “definizione”) e “analisi”. È necessario prestare attenzione al fatto che solo una delle combinazioni di termini indicate (o di significato simile) è utilizzata nel documento ICCA.
7.7.4 L'esaminatore dovrebbe tenere conto del fatto che l'analisi chimica spesso funge da fase della procedura di prova o di controllo, e pertanto i termini pertinenti possono essere utilizzati nel documento ICAC. In particolare, il valore misurato può essere interpretato come un indicatore della qualità del prodotto e il risultato delle misurazioni (analisi) - come un risultato di test o un valore indicatore.
La forma del registro dei documenti ricevuti per l'esame metrologico
|
Richiedente |
Data di ricezione dei documenti |
Elenco dei documenti ricevuti |
Data di richiesta di ulteriori documenti |
Data di ricezione dei documenti aggiuntivi |
Elenco dei documenti aggiuntivi ricevuti |
Esperti |
Data di approvazione della perizia |
Modulo richiesta documenti aggiuntiviTesta ___________________________ impresa richiedente RICHIESTA Sulla base dei risultati dell'esame metrologico preliminare _________ numero (indice) e nome del documento (bozza di documento) in cui è regolamentato l'ICAC Propongo di inviare a _________________________________________________ prima di ________________ nome GNMC i seguenti ulteriori documenti: _______________________________________ ________________________________________________________________________ L'esame si svolge secondo _______________________________________ numero e data della lettera (contratto) Contatto telefonico _____________________ Vicedirettore della SSMC _____________________________ ________________________ firma nome e cognome |
Forma del parere degli esperti 1)_________________________________________________________________________ __________________________________ organizzazione che effettua la revisione APPROVARE ____________________________________ titolo di lavoro ___________ _____________________ firma di decodifica della firma ___________________ l'appuntamento CONCLUSIONE secondo i risultati dell'esame metrologico del metodo di analisi chimica quantitativa 1), regolato in _________________________________________________, numero (indice) e nome del documento (bozza documento), ________________________________________________________________________ organizzazione-sviluppatore, il suo indirizzo certificato 2) _________________________________________________________ organizzazione che ha certificato la metodologia, numero di certificato L'esame si è svolto sulla base di ______________________________________ numero della lettera (contratto), _________________________________________________________________________ organizzazione che ha sottoposto l'ICCA all'esame Materiali aggiuntivi forniti dall'esperto: ________________________ compito tecnico, _________________________________________________________________________ certificato di attestazione, rapporti, protocolli, ecc. Metodologia (non) progettato per l'uso nelle aree di distribuzione del controllo e supervisione metrologica statale. Conclusioni sulla conformità dell'MKCA ai requisiti di GOST R 8.563-96 “Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Metodi di misurazione": a) Nomi delle grandezze misurate e designazioni delle loro unità ( ad eccezione di quelli indicati nelle osservazioni n. __________) soddisfano i requisiti di GOST 8.417-81 “Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Unità di grandezze fisiche”, ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ altri documenti b) Scelta degli strumenti di misura ( ad eccezione di quanto indicato nelle osservazioni n. _______ _) soddisfa le condizioni del problema di misura e può essere riconosciuto come razionale. Tipi di strumenti di misura selezionati, compresi i campioni standard( _____), approvato dallo Stato Standard della Russia 3) . c) Campo di misura 4) ( non) soddisfa i requisiti di __________________________ compito tecnico, ______________________________________________ (vedi anche la nota n. ___) 5) . specifiche, standard, ecc. d) Caratteristiche dell'errore di misura ( non) soddisfare _________ ____________________________________________ (vedi anche la nota n. _____) 6) . termini di riferimento, specifiche, standard, ecc. e) Procedure di controllo dell'accuratezza della misurazione ( non) sono forniti; gli standard di controllo sono collegati ( non collegato) con caratteristiche di errore di misura ( vedi anche la nota n. _____). e) Requisiti, regole e operazioni ( ad eccezione di quelli indicati nelle osservazioni n. _____) sono presentati con sufficiente completezza per ottenere risultati di misura il cui errore non ecceda i limiti stabiliti 7). g) Termini metrologici ( ad eccezione di quelli indicati nelle osservazioni n. _____) corrispondono a GOST R 1.12-99 “Sistema di standardizzazione statale della Federazione Russa. Standardizzazione e attività connesse. Termini e definizioni” e “Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Metrologia. Termini e definizioni di base”. e) ______________________________________________________________________ altre perizie Osservazioni Esperto ( S): ________________________________________________________________________ trascrizione della firma della posizione __________ 1 ) Opzione "Metodi di misurazione". 3) Sono dati solo per MKCA, destinati all'uso nelle aree di distribuzione del controllo e della supervisione metrologica statale. 4) Variante: "campo dei valori misurati". 5) Opzione: "campo di misura non impostato". 6) Opzione: "le caratteristiche dell'errore di misura non sono state stabilite". 7) Opzione: "... limiti stabiliti." |
Esempi di schemi a blocchi del MKHA
OPERAZIONE- campionamento leghe; misurare le masse t 1 e t 2, G.
P- preparazione del campione: dissoluzione per riscaldamento, raffreddamento, diluizione.
E- titolazione potenziometrica dell'argento con soluzione di cloruro di sodio,V 1 e V 2 - volumi di soluzione utilizzati per la titolazione, cm 3 .
BP-calcolo dei risultati delle determinazioni; T NaCl/Ag - titolo della soluzione di cloruro di sodio per l'argento, g/cm 3 ; X 1 e X 2- frazione di massa dell'argento nei campioni, %.
Controllo della convergenza dei risultati delle determinazioni e calcolo del valore medio della frazione di massa dell'argento nella legaXcR(risultato dell'analisi).
Prova della lega.
soluzione titolabile.
Figura D.1 - Schema a blocchi della tecnica di misura della frazione di massa dell'argento nelle leghe

OPERAZIONE- campionamento gas; durante il campionamento vengono misurati i parametri del campione: temperatura T, ° DA; Pressione atmosferica RA, kPa; sotto pressioneDR, kPa; tempo di selezionet , min; flusso volumetricoQ, dm 3 /min.
PP- estrazione di metanolo da un campione di gas mediante un tubo di assorbimento.
e- estrazione del metanolo e misurazione del volume dell'estrattoVehm, cm 3 .
E-immissione di tre aliquote dell'estratto nell'evaporatore del cromatografo e ottenimento dei segnali analiticiS 1 , S 2 , S 3 .
Monitoraggio della convergenza dei segnali analitici e calcolo del valore medioS.
PV- calcolo preliminare; Centimetro- concentrazione in massa di metanolo nell'estratto, mg/cm 3 .
BP- calcolo del risultato della misurazione; Hm- concentrazione in massa di metanolo in un campione di gas ad una temperatura di 273 K e una pressione di 101,3 kPa, mg/m 3 .
PGR-1 - preparazione della soluzione di calibrazione 1 con concentrazione in massa di metanolo, mg/cm 3 .
Le righe (2), (3), (4) corrispondono alle soluzioni di calibrazione 2, 3, 4.
Calcolo dei coefficienti di calibrazione per le soluzioni 1-4, controllo della convergenza dei coefficienti e calcolo della media A.
Campione di gas/
Assorbente con metanolo.
Estratto e soluzione di calibrazione
Figura D.2 - Schema strutturale della tecnica di misura della concentrazione in massa del metanolo nelle emissioni gassose con il metodo cromatografico
Rabinovich SG Errori di misura. - L.: Energia, 1978
Semenko NG, Panova VI, Lakhov VM Campioni standard nel sistema per garantire l'uniformità delle misurazioni. - M.: Casa editrice di standard, 1990
Kateman G., Piipers F.V. Controllo di qualità dell'analisi chimica. - Chelyabinsk: Metallurgia, 1989
Dörfel K. Statistica in chimica analitica. - M.: Mir, 1994
Buytash P., Kuzmin N.M., Leistner L. Garanzia della qualità dei risultati dell'analisi chimica. - M.: Nauka, 1993 RD 50-160-79 Implementazione e applicazione di GOST 8.417-81 “Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. unità"
Stotsky RL Grandezze fisiche e unità. Directory. Il libro per l'insegnante. - M.: Illuminismo, 1984
[ 22 ] Raccomandazione MI 2377-98. Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Sviluppo e certificazione di metodi di misura
[ 27 ] Raccomandazione MI 2083-90. Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Le misurazioni sono indirette. Determinazione dei risultati di misura e stima dei loro errori
MI 2232-2000 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Garantire l'efficienza delle misurazioni nel controllo di processo. Stima degli errori con informazioni iniziali limitate
Quantificare l'incertezza nelle misure analitiche. Traduzione di documenti EURACHEM. - San Pietroburgo: Natale, 1997
[ 33 ] Raccomandazione MI 2552-99. Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Applicazione delle "Linee guida per l'espressione dell'incertezza di misura"
[ 34 ] Raccomandazione MI 2335-95. Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Controllo interno della qualità dei risultati dell'analisi chimica quantitativa
[ 37 ] Raccomandazione MI 1992-98. Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Certificazione metrologica di campioni standard della composizione di sostanze e materiali secondo la procedura di preparazione. Disposizioni di base
Parole chiave: metodo di analisi chimica quantitativa, esame metrologico, centro scientifico metrologico statale, oggetto analizzato, componente determinato, valore misurato, strumento di misura, caratteristica di errore del risultato di misura
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni
TECNICHE DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA
Requisiti generali per lo sviluppo, la certificazione e l'applicazione
Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Procedure di analisi chimica quantitativa. Requisiti generali per lo sviluppo, la certificazione e l'applicazione
OK 17.020
Data di introduzione 01-01-2015
Prefazione
1 SVILUPPATO dall'Impresa Unitaria dello Stato Federale "Istituto di Metrologia degli Urali" (FGUP "UNIIM")
2 INTRODOTTO comitato tecnico sulla standardizzazione TC 53 "Norme e regole di base per garantire l'uniformità delle misurazioni"
3 APPROVATO E ATTUATO con Ordinanza dell'Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia del 22 novembre 2013 N 1940-st
4 INTRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA
Le regole per l'applicazione di tali raccomandazioni sono stabilite in GOST R 1.0-2012 (sezione 8). Le informazioni sulle modifiche a queste raccomandazioni sono pubblicate nell'indice informativo annuale (a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso) "Standard nazionali" e nel testo ufficiale delle modifiche e degli emendamenti - nell'indice informativo mensile "Standard nazionali". In caso di revisione (sostituzione) o annullamento di tali raccomandazioni, verrà pubblicato un avviso corrispondente nel prossimo numero dell'indice informativo mensile "Norme nazionali". Informazioni, notifiche e testi pertinenti sono anche pubblicati nel sistema informativo pubblico - sul sito Web ufficiale dell'Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia su Internet (gost.ru)
introduzione
introduzione
Metodi di analisi chimica quantitativa (di seguito denominati MKCA), che sono una delle varietà di metodi di misurazione e sono utilizzati nel controllo analitico della composizione o delle proprietà di sostanze, materiali, oggetti ambientali, oggetti di regolamentazione tecnica, biologici e altri gli oggetti, così come nel trasferimento delle dimensioni delle unità dagli standard e per la certificazione di campioni standard, costituiscono una parte significativa dei metodi di misurazione utilizzati sia nel campo della regolamentazione statale per garantire l'uniformità delle misurazioni, sia al di fuori di esso. Allo stesso tempo, indipendentemente dall'ambito di applicazione, MCCA ha specifiche comuni associate alla presenza e all'implementazione di procedure speciali inerenti all'analisi chimica quantitativa, come la disponibilità di varie procedure per il campionamento e la stabilizzazione dei campioni per oggetti diversi, la presenza di condizioni speciali per la conservazione e il trasporto di campioni di oggetti chimicamente aggressivi, la presenza di procedure specifiche per l'apertura dei campioni (decomposizione chimica, termica, ecc.), la disponibilità di procedure speciali per la preparazione dei campioni per l'analisi relativa al trasferimento dell'analita (componente ) in uno stato conveniente per l'analisi (misurazione) (vari metodi di estrazione, concentrazione) e così via. Ciascuna delle procedure di cui sopra può causare un proprio contributo, a volte abbastanza significativo, all'errore complessivo (incertezza) dei risultati dell'analisi, causandone l'inaffidabilità , se uno qualsiasi dei fattori elencati non è stato sufficientemente ben analizzato, valutato e preso in considerazione nel processo di sviluppo dell'ICA e nella valutazione della sua idoneità allo scopo previsto - Validazione MKCA (valutazione di idoneità secondo GOST ISO/IEC 17025-2009). A seconda dell'ambito dell'MCCA, la fase finale del suo sviluppo può essere la procedura di convalida del metodo in conformità con GOST ISO / IEC 17025-2009 (per l'MCCA destinato all'uso al di fuori dell'ambito della normativa statale per garantire l'uniformità delle misurazioni) o la procedura di certificazione (secondo la legge federale N 102-FZ "On Ensuring the Uniformity of Measurements" e GOST R 8.563-2009) per l'MKCA utilizzata nel campo della regolamentazione statale per garantire l'uniformità delle misurazioni), che può essere eseguita sulla base dei risultati della validazione MKCA. Allo stesso tempo, la convalida dell'MCCA è effettuata dallo sviluppatore o dall'utente della metodologia e la certificazione dell'MCCA è effettuata da coloro accreditati per questo tipo di attività nel campo della garanzia dell'uniformità delle misurazioni. persone giuridiche(singoli imprenditori).
L'affidabilità e la tracciabilità dei risultati dell'analisi ottenuti utilizzando un particolare ICCA dipende dal suo livello metrologico, che, a sua volta, è determinato dalla qualità dell'attuazione della stessa procedura di sviluppo dell'ICCA e dalle sue fasi finali - validazione, certificazione.
Lo scopo di queste raccomandazioni è descrivere il sistema di disposizioni e raccomandazioni che dovrebbero essere prese in considerazione quando si eseguono le procedure per lo sviluppo dell'MCCA, tenendo conto delle suddette specifiche dell'analisi chimica quantitativa e della necessità di applicare varie procedure per valutandone la conformità allo scopo previsto, quale fase finale dello sviluppo dell'MCCA (a seconda dell'ambito della sua applicazione), nonché le caratteristiche e la procedura per l'applicazione dell'MCCA, compreso l'MCCA, sviluppato sulla base degli standard internazionali che disciplinano i metodi di misurazione (analisi) standardizzati.
Queste raccomandazioni sono sviluppate nello sviluppo delle disposizioni di GOST R 8.563-2009.
1 area di utilizzo
1.1 Queste raccomandazioni definiscono un sistema di disposizioni e raccomandazioni che dovrebbero essere prese in considerazione nello sviluppo, convalida, certificazione e applicazione di metodi di analisi chimica quantitativa, che sono una delle varietà di metodi di misurazione.
_______________
Secondo GOST ISO / IEC 17025 - valutazione di idoneità.
1.2 Queste raccomandazioni si applicano ai metodi di analisi chimica quantitativa (di seguito denominati MKCA), nonché ai metodi di prova, metodi di prova, misurazioni, analisi, se sono o contengono MKCA.
2 Riferimenti normativi
In queste raccomandazioni vengono utilizzati riferimenti normativi ai seguenti documenti normativi:
GOST 8.315-97 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Campioni standard della composizione e delle proprietà di sostanze e materiali. Disposizioni di base
GOST 8.417-2002 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Unità
GOST 17.4.3.03-85 Protezione della natura. Suoli. Requisiti generali per i metodi per la determinazione degli inquinanti
GOST 17.2.4.02-81 Protezione della natura. Atmosfera. Requisiti generali per i metodi per la determinazione degli inquinanti
GOST 27384-2002 Acqua. Standard di errore di misura degli indicatori di composizione e proprietà
GOST 28473-90. Ghisa, acciaio, ferroleghe, cromo, manganese metallo. Requisiti generali per i metodi di analisi
GOST ISO 9000-2011 Sistemi di gestione della qualità. Fondamenti e lessico
GOST ISO/IEC 17025-2009 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e calibrazione
GOST R 8.563-2009 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Tecniche (metodi) di misurazione
GOST R 8.568-97 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Certificazione apparecchiature di prova. Disposizioni di base
GOST R 8.596-2002 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Supporto metrologico dei sistemi di misura. Disposizioni di base
GOST R 8.654-2009 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Requisiti per Software strumenti di misura. Disposizioni di base
GOST R 8.736-2011 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Molteplici misurazioni dirette. Metodi per elaborare i risultati delle misurazioni. Disposizioni di base
GOST R 52361-2005 Controllo analitico dell'oggetto. Termini e definizioni
GOST R 52599-2006 Metalli preziosi e loro leghe. Requisiti generali per i metodi di analisi
GOST R 54569-2011 Ghisa, acciaio, ferroleghe, cromo e manganese. Standard di precisione per l'analisi chimica quantitativa
GOST R ISO 5725-1-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 1. Disposizioni e definizioni di base
GOST R ISO 5725-2-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 2: Metodo di base per determinare la ripetibilità e la riproducibilità di un metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-3-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 3. Valori di precisione intermedi del metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-4-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi e dei risultati di misurazione. Parte 4: Metodi di base per determinare la validità di un metodo di misurazione standard
GOST R ISO 5725-6-2002 Precisione (correttezza e precisione) dei metodi di misurazione e dei risultati. Parte 6. Utilizzo pratico dei valori di precisione
RMG 54-2002 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Caratteristiche degli strumenti di calibrazione per misurare la composizione e le proprietà di sostanze e materiali. Metodo per eseguire misurazioni utilizzando campioni standard
RMG 60-2003 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Miscele certificate. Requisiti generali di sviluppo
RMG 61-2010 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Indicatori di accuratezza, correttezza, precisione dei metodi di analisi chimica quantitativa. Metodi di valutazione
RMG 62-2003 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Garantire l'efficienza delle misurazioni nel controllo di processo. Stima dell'errore di misura con informazioni iniziali limitate
RMG 63-2003 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Garantire l'efficienza delle misurazioni nel controllo di processo. Esame metrologico della documentazione tecnica
RMG 64-2003 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Garantire l'efficienza delle misurazioni nel controllo di processo. Metodi e modi per migliorare l'accuratezza delle misurazioni
RMG 76-2004 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Controllo interno della qualità dei risultati dell'analisi chimica quantitativa.
PMG 44-2001 Regole per la standardizzazione interstatale. Procedura per il riconoscimento dei metodi di misurazione
PMG 96-2009 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Risultati e caratteristiche della qualità della misura. Moduli di presentazione
R 50.2.008-2001 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Metodi di analisi chimica quantitativa. Contenuto e procedura per l'esame metrologico
R 50.2.028-2003 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Algoritmi per costruire caratteristiche di taratura di strumenti di misura per la composizione di sostanze e materiali e stimarne gli errori (incertezze). Stima dell'errore (incertezza) delle caratteristiche di calibrazione lineare utilizzando il metodo dei minimi quadrati
R 50.2.060-2008 Sistema statale per garantire l'uniformità delle misurazioni. Implementazione di metodi standardizzati per l'analisi chimica quantitativa in laboratorio. Conferma del rispetto dei requisiti stabiliti
Nota - Quando si utilizzano queste raccomandazioni, è consigliabile verificare la validità dei documenti di riferimento e dei classificatori nel sistema informativo pubblico - sul sito Web ufficiale dell'Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia su Internet o secondo l'indice informativo annuale "National Standards", che è stato pubblicato a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso, e secondo i numeri dell'indice informativo mensile "Standard nazionali" per l'anno in corso. Se è stato sostituito un documento di riferimento non datato, si raccomanda di utilizzare la versione corrente di tale documento, tenendo conto di eventuali modifiche apportate a tale versione. Se il documento di riferimento è sostituito da un riferimento datato, si raccomanda di utilizzare la versione di questo documento con l'anno di approvazione (accettazione) sopra indicato. Se, dopo l'approvazione di queste raccomandazioni in Documento di riferimento, a cui si fa riferimento datato, è stata apportata una modifica che incide sulla disposizione a cui si fa riferimento, quindi si raccomanda di applicare tale disposizione senza tener conto di tale modifica. Se il documento di riferimento viene cancellato senza sostituzione, si raccomanda di applicare la disposizione in cui è riportato il collegamento ad esso nella parte che non pregiudica questo collegamento.
3 Termini e definizioni
Queste raccomandazioni utilizzano i termini secondo GOST R 8.563, GOST R 52361, GOST ISO 9000, GOST R ISO 5725-1, PMG 96, RMG 61, nonché i seguenti termini con le definizioni corrispondenti:
3.1 analisi chimiche quantitative; CCA: Determinazione sperimentale quantitativa nell'oggetto di analisi (sostanza, materiale) del contenuto (concentrazione in massa, frazione in massa, frazione in volume, ecc.) di uno o più componenti mediante metodi chimici, fisico-chimici, fisici.
Nota - Il risultato dell'ACC è il contenuto accertato di un componente di una sostanza in un campione, espresso in unità di quantità fisiche approvate per l'uso nel paese, indicando le caratteristiche del suo errore (incertezza) o le loro stime statistiche. Il risultato QCA è una sorta di risultato di misurazione.
3.2 metodo di analisi chimica quantitativa; MKCA: un insieme di operazioni specificatamente descritte, la cui esecuzione fornisce i risultati di un'analisi chimica quantitativa con indicatori di accuratezza stabiliti.
Appunti
1 La tecnica di analisi chimica quantitativa è un tipo di tecnica di misurazione.
2. Si assume come caratteristica misurata il contenuto di una o più componenti dell'oggetto di analisi.
Nota - Come indicatore dell'accuratezza della tecnica di misurazione, è possibile utilizzare le caratteristiche dell'errore di misurazione secondo , gli indicatori di incertezza secondo *, gli indicatori di precisione secondo GOST R ISO 5725-1.
________________
* Vedi sezione Bibliografia, qui e sotto. - Nota del produttore del database.
3.4 Indicatore di precisione MKHA: Un indicatore dell'accuratezza della misurazione stabilito per qualsiasi risultato CCA ottenuto in conformità con i requisiti e le regole di questo ICA.
Nota - I valori dell'indicatore di accuratezza possono essere attribuiti a qualsiasi risultato del CCA, ottenuto nel rispetto dei requisiti e delle regole specificate nel documento per l'ICCA.
3.5 tasso di precisione di misurazione: Valori di un indicatore di accuratezza consentiti per determinati scopi di misurazione.
3.6 Convalida ICCA: Una procedura documentata per confermare l'idoneità dell'ICCA al raggiungimento degli obiettivi dichiarati, compreso lo studio e la fornitura di prove oggettive che i requisiti specifici per l'uso specifico previsto della metodologia sono soddisfatti.
3.7 requisiti metrologici per MKHA: Requisiti per le caratteristiche (parametri) della procedura di misurazione prevista dall'ICCA, che incidono sugli indicatori di risultato e di accuratezza, e le condizioni in cui tali caratteristiche (parametri) devono essere fornite.
3.8 fattori di influenza del campione: Componenti interferenti e altre proprietà (fattori) del campione che influiscono sul risultato e sul valore dell'indicatore di precisione della misurazione.
3.9 fattori che influenzano la tecnica: Fattori, i cui valori determinano le condizioni per l'esecuzione di misurazioni secondo MKCA, influenzando il risultato e il valore dell'indicatore di precisione della misurazione.
4 Disposizioni generali
4.1 Gli MKCA sono sviluppati e applicati al fine di garantire la misurazione degli indicatori della composizione e delle proprietà di sostanze, materiali, oggetti di regolamentazione tecnica, biologici e altri oggetti soggetti a controllo analitico, in conformità con i requisiti metrologici stabiliti per le misurazioni, compresi i requisiti per la precisione della misurazione.
4.2 I requisiti metrologici per le misurazioni eseguite durante il controllo analitico sono stabiliti tenendo conto delle specificità degli oggetti controllati e delle finalità dell'utilizzo dei risultati delle misurazioni.
4.3 I requisiti metrologici per le misurazioni eseguite durante il controllo analitico includono i requisiti per:
- il tipo e le caratteristiche della grandezza misurata (indicatore);
- unità di grandezza misurata (indicatore);
- campo di misura del valore (indicatore);
- Accuratezza di misurazione;
- garantire la tracciabilità dei risultati delle misurazioni;
- alle condizioni di misurazione;
- al numero di cifre risultante dalle misurazioni (arrotondamento dei risultati delle misurazioni) - se necessario.
4.4 Per l'MKCA, in relazione all'ambito della regolamentazione statale di garantire l'uniformità delle misurazioni, in conformità con le autorità esecutive federali, determinano i requisiti metrologici obbligatori per le misurazioni, compresi gli indicatori di precisione della misurazione.
MKCA, progettato, secondo, per confermare la conformità degli oggetti del regolamento tecnico con i requisiti dei regolamenti tecnici, deve anche fornire requisiti obbligatori in termini di conformità a:
- valori misurati (indicatori) dell'oggetto controllato della regolamentazione tecnica all'elenco degli indicatori di sicurezza in esso stabiliti;
- unità di misura secondo le unità di misura ICCA determinate dalle regole tecniche;
- la gamma di misurazioni secondo l'MKCA ai livelli (ammissibili) stabiliti degli indicatori di sicurezza degli oggetti della regolamentazione tecnica;
- valori degli indicatori di accuratezza del MKCA agli standard di accuratezza della misurazione definiti dai regolamenti tecnici (se presenti).
Durante lo sviluppo dell'MKCA, il cliente (sviluppatore) può determinare ulteriori requisiti metrologici.
4.5 Per MKCA, non correlato all'ambito della regolamentazione statale di garantire l'uniformità delle misurazioni, i requisiti metrologici per le misurazioni sono determinati dal cliente (sviluppatore) della metodologia.
4.6 Lo sviluppo dell'MKCA viene effettuato sulla base di piani, programmi di standardizzazione nazionale (industriale), piani per l'ammodernamento della produzione dell'organizzazione, ecc., A seconda del suo scopo e della sua portata.
4.7 La fase finale nello sviluppo dell'ICA utilizzata nel campo della regolamentazione statale per garantire l'uniformità delle misurazioni è la sua certificazione. La fase finale nello sviluppo dell'ICCA, che non è destinata all'uso nel campo della regolamentazione statale volta a garantire l'uniformità delle misurazioni, è la sua convalida o certificazione, eseguita su base volontaria.
4.8 Il documento per l'ICCA è sviluppato in conformità con i requisiti di GOST R 8.563, queste raccomandazioni e la procedura stabilita per il rango corrispondente del documento nel campo della standardizzazione, in cui è prevista l'approvazione di un particolare ICCA.
4.9 La certificazione dell'MKCA viene eseguita secondo la procedura determinata da GOST R 8.563 e queste raccomandazioni. La certificazione di MKCA relativa alla sfera della regolamentazione statale per garantire l'uniformità delle misurazioni viene effettuata da persone giuridiche e singoli imprenditori accreditati secondo la procedura stabilita per la certificazione dei metodi di misurazione secondo lo scopo approvato del loro accreditamento.
4.10 La convalida dell'MCCA è effettuata dal suo sviluppatore o, per suo conto, da un'organizzazione terza competente nel campo del supporto metrologico CCA in conformità con queste raccomandazioni.
4.11 L'utilizzo dell'MCCA in un laboratorio specifico che non sia lo sviluppatore dell'MCCA deve essere preceduto da una procedura per la sua verifica (attuazione), confermandone la fattibilità nelle condizioni di tale laboratorio con gli indicatori di accuratezza stabiliti.
4.12 MKHA sono utilizzati in stretta conformità con il loro scopo e scopo, che sono regolati nel documento approvato per MKHA.
di solito non richiede più di pochi minuti. [email protetta], lo scopriremo.